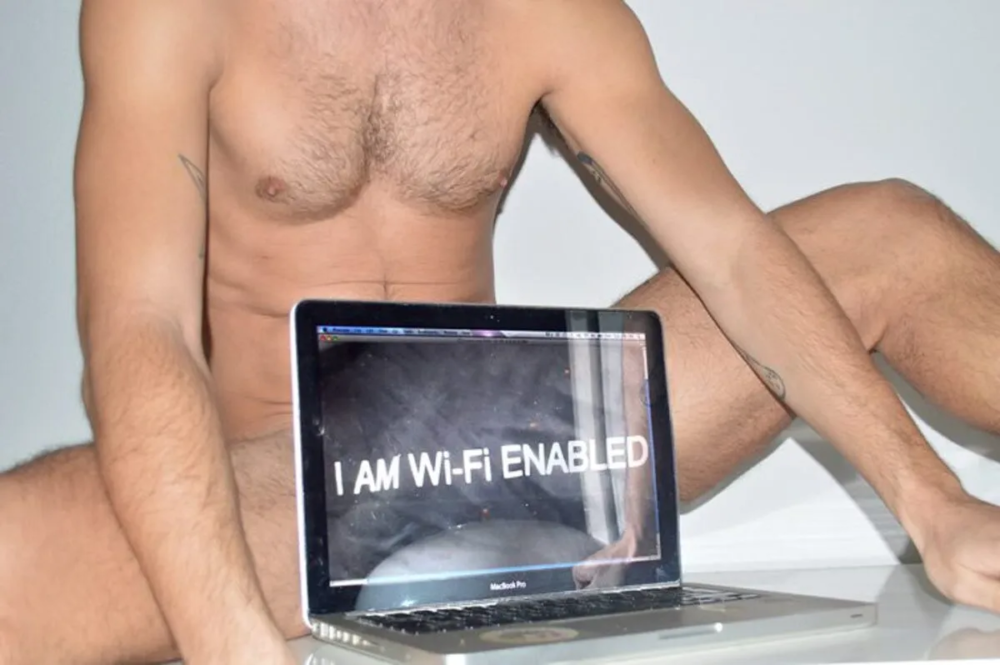Le Tracce di Nicola Sani. A Siena la decima edizione di Chigiana International Festival
Tracce sonore e nuove tecnologie: la musica contemporanea, dal tributo a György Ligeti ai concerti in Piazza del Campo a Siena – Nicola Sani racconta l’Accademia Chigiana, che festeggia i dieci anni del suo festival
Nicola Sani è Direttore artistico dell’Accademia Musicale Chigiana, una delle principali istituzioni musicali italiane e del Chigiana International Festival & Summer Academy che quest’anno festeggia la sua decima edizione, intitolata Tracce, con oltre cento eventi tra cui concerti sinfonici e open air, spettacoli d’opera, concerti da camera e numerose prime esecuzioni assolute.
Chigiana International Festival & Summer Academy
Il Festival propone un programma ampio, in cui il rapporto tra le diverse tracce sonore è declinato in una grande molteplicità di forme, come spiega Nicola Sani: «Dieci anni fa la Chigiana ha dato vita al Chigiana International Festival & Summer Academy, un progetto che ogni anno organizza la propria programmazione intorno a un tema, con un “focus” su un autore contemporaneo, con cui si confronta tutta l’accademia. In questa edizione sarà la volta di György Ligeti, considerato una delle personalità principali e più originali della Nuova Musica. Ventotto delle sue composizioni verranno eseguite all’interno dei due mesi di festival, insieme a quelle di molti altri autori di ieri e di oggi. Tra le iniziative in programma c’è anche il “Concerto per l’Italia” in Piazza del Campo, che vede protagonista la Filarmonica della Scala, diretta da Myung-Whun Chung – già allievo e docente dell’Accademia Chigiana, in un avvincente programma beethoveniano».
Il festival avrà inizio il 5 luglio al Teatro dei Rinnovati, con il celebre violinista Ilya Gringolts e l’Orchestra della Toscana diretta da Marco Angius e per i successivi due mesi la città senese sarà in festa: «Il Festival della Chigiana è dedicato alla musica a 360 gradi ed è interamente realizzato dall’Accademia, dall’energia prodotta dai corsi di alto perfezionamento, caratteristica che lo rende unico. Non si viene alla Chigiana per imparare la musica, ma per diventare protagonisti della musica, questo è il senso di una scuola che ha avuto nella sua storia allievi come Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Zubin Mehta,Salvatore Accardo, Kirill Petrenko, Sol Gabetta e docenti come Andrés Segovia, Sergiu Celibidache, Franco Ferrara, Maurizio Pollini, Pierre Boulez, Mischa Maisky, e oggi Salvatore Sciarrino, Daniele Gatti, Tabea Zimmermann, Lilya Zilberstein e moltissimi altri celebri protagonisti della musica del XX secolo e del nostro tempo».
L’Accademia Chigiana, l’avanguardia musicale
La storia dell’Accademia Musicale Chigiana comincia nel 1932, dalla passione del Conte Guido Chigi Saracini per la musica, e dal suo amore per Verdi e Chopin. «Oggi le sue attività continuano a essere all’avaguardia, e offrono 32 corsi in cui insegnano i più grandi musicisti del mondo, frequentati da allievi provenienti da 52 Paesi. Oltre ai corsi più tradizionali di strumento, canto, composizione, direzione d’orchestra, direzione di coro, abbiamo corsi introdotti negli ultimi dieci anni, tra cui il corso di Percussioni, quello di Live Electronics-Sound and Music Computing e uno dedicato alla comunicazione musicale online, Tell me Chigiana; in collaborazione con la Siena Jazz University, abbiamo creato il corso Tabula rasa, che sperimenta le tecniche di improvvisazione e unisce i due contesti della musica “colta” e della musica jazz; in collaborazione con la Mozarteum University di Salisburgo, abbiamo dato vita al prestigioso Chigiana Mozarteum Baroque Programme, uno straordinario programma di otto corsi dedicati alla musica barocca, con alcuni tra i più celebri esponenti internazionali di questa disciplina. Poi ci sono i laboratori d’opera, grazie ai quali realizziamo le produzioni di teatro musicale. Ma la Chigiana oggi è anche molte altre attività, durante tutto l’anno».
L’offerta dell’Accademia è riuscita ad evolvere e sperimentarsi, al passo con le trasformazioni del settore musicale, spiega il Direttore: «Il compositore oggi è molto più simile ad un architetto o a un designer rispetto a quanto lo era in passato: lo spazio è un parametro compositivo in un spazio multidimensionale. Questo aspetto deriva dall’introduzione dell’elettronica nella musica e il compositore che forse più ha contribuito a questo approccio è stato Iannis Xenakis, che ha collaborato con Le Corbusier alla progettazione del Padiglione Phillips, per l’Expo di Bruxelles nel 1958, creando il Poème Electronique, uno dei primi esempi del rapporto strutturale tra architettura e musica. Al suo interno il parametro spaziale diventa un termine compositivo».
Da Domenico Guaccero a Karlheinz Stockhausen
Nicola Sani ha studiato composizione con alcuni dei maestri del XX secolo, assimilandone le influenze e l’approccio sperimentale: «Ho studiato composizione con Domenico Guaccero, uno dei protagonisti dell’avanguardia italiana del dopoguerra, espressione della corrente che si incontra alla fine degli anni ‘50 a Darmstadt, di cui facevano parte (con diverse posizioni personali) Bruno Maderna, Luigi Nono, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Franco Evangelisti. Quella di Guaccero è stata una figura centrale anche del movimento romano che ha dato vita a Nuova Consonanza, è stato tra i primi a sperimentare le tecniche di improvvisazione con le tecnologie elettroniche (fondando il gruppo Musica ex Machina) e a sviluppare la prassi intermediale, ovvero dell’integrazione in ambito compositivo delle componenti sonore con la gestualità, la teatralità e le arti visive, collocando il suono oltre l’ambito sonoro. Dopo gli studi con Domenico Guaccero ho avuto l’opportunità di specializzarmi con Karlheinz Stockhausen, una delle più grandi figure dell’avanguardia mondiale e da lì è cominciato un percorso compositivo che ha incontrato in maniera organica la tecnologia».
L’attività di Nicola Sani si distingue per la ricerca nei nuovi linguaggi sonori e per l’integrazione tra la tradizione musicale e le nuove tecnologie: «Ogni volta che ne ho avuto la possibilità, ho approfondito il rapporto tra il suono e le tecnologie, non soltanto per quanto riguarda la sintesi del suono, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione e la proiezione nello spazio dei suoni strumentali. Questo mi ha permesso di lavorare negli studi d’Europa, dove è possibile disporre delle tecnologie più innovative con diverse modalità di elaborazione e di costruzione del suono nello spazio, come all’Experimental Studio di Friburgo in Germania o al GRM di Parigi, a Radio France, dove è nata la musique concrète».


La sperimentazione dell’objet sonore
La sua formazione si è ulteriormente arricchita grazie alle esperienze presso istituzioni internazionali: «Ho lavorato su ciò che queste diverse tendenze e scuole hanno sperimentato, come ad esempio l’oggetto sonoro, l’objet sonore, alla base di quella tendenza che oggi è più conosciuta come “acusmatica”, cioè il lavoro sul suono elettronico distribuito nello spazio attraverso una moltiplicità di sorgenti sonore. È straordinario in questo senso il lavoro sviluppato dal GRM-Groupe de Recherche Musicale negli studi di Radio France a Parigi, che ha creato un’orchestra di 80 altoparlanti, un capolavoro di architettura sonora spaziale. Per questo strumento, l’Acusmonium, ho composto diversi lavori e l’aver sviluppato questo rapporto strutturale tra il suono e la tecnologia mi ha portato a guardare sempre verso la sperimentazione e a progettare nuove sonorità prodotte dagli strumenti musicali tradizionali anche quando la tecnologia non c’è».
Claudio Abbado e i Berliner Philharmoniker
L’esperienza con Claudio Abbado rappresenta un ulteriore capitolo nella carriera di Nicola Sani, che ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti per contribuire alla diffusione della musica contemporanea. «Nel 1997 ho avuto l’opportunità, grazie a una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri quale composer-in-residence a Berlino, di seguire da vicino il lavoro di Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker. È stata una lezione incredibile quella di vedere come nasceva un concerto dei Berliner fin dalle prime intuizioni di Claudio Abbado, straordinario uomo di cultura e grande intellettuale della musica. Per me è stata un’esperienza determinante non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche per quello che sarebbe stato il mio percorso di direttore artistico. Prima di tutto mi colpì l’impostazione “tematica” che Abbado dava alle sue stagioni di concerti, un fatto estremamente innovativo nell’organizzazione musicale di allora».
«Quando sono arrivato a Berlino, Abbado aveva programmato con i Berliner la stagione tematica “Der Wanderer”, il Viandante, e all’interno di questa programmazione il repertorio andava da Schubert a Luigi Nono, con una logica “drammaturgica” che univa ogni concerto della stagione. Tutta la città riverberava questa tematica: la Neue Nationalgalerie, la Biblioteca Nazionale, la Cinemateca di Berlino, tutte le istituzioni culturali berlinesi partecipavano al progetto, insieme con la Philharmonie, declinandolo secondo le diverse forme d’arte e forme di aggregazione sociale e i diversi codici estetici. Vivere quest’esperienza giorno dopo giorno, mi ha fortemente ispirato nei successivi incarichi che ho ricoperto: ho sempre cercato di fare in modo che la musica fosse una possibilità per collegare i linguaggi, le arti, le espressioni, le forme di vita della società in cui viviamo. Un ponte per raggiungere le persone e farle dialogare. Conoscere la musica significa conoscere meglio se stessi, gli altri e il proprio tempo, questo è stato un grande messaggio di Claudia Abbado».
La Fondazione Scelsi
Dal 2004 al 2014 Nicola Sani ha presieduto anche la Fondazione Isabella Scelsi a Roma, intitolata al lascito culturale di Giacinto Scelsi, compositore sperimentale italiani: «Al mio arrivo la fondazione era sull’orlo del commissariamento per conflittualità interne ed è stato un lavoro riorganizzarla e ridarle un assetto in grado di poter rappresentare una struttura degna del nome che rappresentava. Operazione che è perfettamente riuscita, avviata con la realizzazione, nel 2005, dell’imponente “Festival Scelsi” a Roma, con la partecipazione di tutte le principali istituzioni musicali e culturali della Capitale, in occasione del centenario della nascita del compositore. Negli anni successivi è stato anche creato l’Archivio Scelsi, per rendere accessibili a tutta la comunità degli studiosi e degli appassionati i documenti sonori e cartacei che costituiscono il fondamento della conoscenza del lavoro e della prassi compositiva di Scelsi, sulla quale c’era molta approssimazione, come tipicamente accade quando non c’è la conoscenza diretta dei documenti originali».
«Giacinto Scelsi rappresenta l’unico caso nella sfera occidentale di compositore che per la parte principale della sua esperienza creativa non ha utilizzato la scrittura tradizionale. La sua prassi compositiva, basata su sperimentazioni con sorgenti sonore elettroniche e concrete fissate su nastro magnetico, con tecniche pioneristiche per il suo tempo, è stata cruciale per far comprendere che il suono è un oggetto complesso, un macrocosmo all’interno del quale si può entrare e scoprire una polifonia di eventi racchiusi in un centro sonoro unico. John Cage è stato tra i suoi grandi amici e ammiratori, dalla sua esperienza è nato lo spettralismo francese, i minimalisti americani, primo fra tutti La Monte Young, lo hanno considerato un punto di riferimento assoluto».

Dal sintetizzatore all’intelligenza artificiale
A partire dalla metà del XX secolo la musica elettronica ha rivoluzionato la concezione della musica, in ogni suo genere: «Il suono elaborato tecnologicamente è un concetto che riguarda prima di tutto il rapporto tra l’interprete e l’autore, legato all’esplorazione delle possibilità della prassi strumentale. Ho intitolato Musica espansa il libro che ho scritto assieme a Francesco Galante, perché le tecnologie intermediali oggi sono un modo di “espandere” il suono, di diffonderlo, dopo la sua creazione che deriva dal rapporto imprescindibile tra compositore e interprete».
Già negli anni sessanta compositori come Karlheinz Stockhausen sperimentarono l’impiego di oscillatori, generatori di rumore e altri strumenti elettronici: «Si diceva che la musica elettronica avrebbe distrutto lo strumento tradizionale, le orchestre, i violini. Mai un’affermazione è risultata più falsa. Le tecnologie elettroniche al contrario hanno consentito una conoscenza migliore e più approfondita del mondo sonoro e hanno offerto al compositore la possibilità di entrare all’interno del suono. Attraverso le tecnologie è possibile organizzare il suono nello spazio: decostruirlo, isolarne e utilizzarne componenti parziali, assegnarle a determinati punti dello spazio e consentirne evoluzioni. Ecco perchè oggi un compositore compone in uno spazio tridimensionale».
L’intelligenza artificiale apre nuove possibilità per la creazione, la produzione e la fruizione della musica
L’intelligenza artificiale apre nuove possibilità per la creazione, la produzione e la fruizione della musica, ma la sua sperimentazione è stata avviata prima di quel che si pensa: «Tra le prime applicazioni di ricerca dell’intelligenza artificiale c’è proprio la musica. All’Università di Princeton e ai Bell Labs nella seconda metà degli anni ‘50, sono nate le prime ricerche del rapporto tra musica e intelligenza artificiale. Proprio Iannis Xenakis fu tra i primi a svilupparne le potenzialità e con lui altri compositori, come Jean-Claude Risset, che realizzò per il Disklavier, un pianoforte controllato digitalmente, alcune opere in cui il pianista esegue manualmente il suo spartito, dialogando in tempo reale con il Disklavier che risponde sulla base di algoritmi che sviluppano processi compositivi relazionati».
Dalla musica algoritmica alla composizione collaborativa, la tessitura di musica e intelligenza artificiale ha consentito sviluppi significativi «Negli anni 70, vennero sviluppati i primi software per la computer music e compositori e ricercatori come John Chowning all’Università di Stanford e Barry Truax alla Simon Fraser University di Vancouver, in Canada, cominciarono a realizzare software che erano parte integrante dei contenuti delle loro creazioni. In pratica il programma generatore era già un elemento determinante della composizione stessa.
Oggi l’intelligenza artificiale ci pone davanti a una nuova pagina, che può fare tesoro di queste ricerche ed esperienze già sviluppate. La possibilità di accedervi rende possibile un indispensabile processo di avanzamento e di sperimentazione musicale».
L’integrazione tra le arti secondo Nicola Sani
L’intermedialità e la collaborazione tra compositore e artisti visivi e ingegneri del suono è uno dei tratti riconoscibili di Nicola Sani: «Quando ero direttore artistico del Teatro dell’Opera di Roma mettemmo in scena le produzioni di Aida di Giuseppe Verdi con la regia, scene e luci di Robert Wilson e del Pelléas et Mélisande, di Claude Debussy, una coproduzione dell’Opera di Roma con il Teatro La Monnaie di Bruxelles con la regia di Pierre Audi e le scene di Anish Kapoor. Queste esperienze sono state centrali per definire un nuovo rapporto tra la grande tradizione del teatro d’opera e le nuove forme dell’arte e del design. Per il mio lavoro creativo è stata centrale l’esperienza con un grande ingegnere del suono e sound designer come Alvise Vidolin, tra i massimi studiosi e conoscitori della prassi esecutiva con le tecnologie per il live electronics del nostro tempo. Ho avuto l’opportunità di collaborare con molti video-artisti, come Nam June Paik e Studio Azzurro e in particolare con Mario Sasso, con cui ho stabilito un lungo sodalizio artistico. Ho lavorato con Michelangelo Antonioni, firmando la musica del suo ultimo cortometraggio, Noto-Mandorli-Vulvano-Stromboli-Carnevale, un’esperienza straordinaria. Il rapporto col visivo introduce un tipo di fruizione artistica della musica diverso dall’ordinario: all’interno di un’installazione intermediale o davanti a uno schermo si ha un coinvolgimento diverso rispetto a quello che si avrebbe di fronte a un palcoscenico, bisogna tenerlo in considerazione».
Diventa così possibile sperimentare anche l’interazione di una composizione con ciò che avviene mentre è in corso la sua riproduzione: «Chemical Free (?) è il nome dell’opera che ho presentato alla Biennale Musica di Venezia nel 2015, su invito di Ivan Fedele. Il progetto, grazie alle tecnologie per il motion capture sviluppate in ambito cinematografico e trasferite alla musica dal team del CSC-Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di Padova diretto da Alvise Vidolin e dal Laboratorio SaMPL del Conservatorio di Padova, allora diretto da Nicola Bernardini, mette in relazione gli esecutori, tramite sensori, a un set di telecamere in grado di generare un campo vettoriale tridimensionale che viene intercettato dai sensori fissati sulle mani degli esecutori. Il loro movimento genera una serie di dati numerici che determinano le istruzioni per i sistemi digitali di elaborazione del suono per le trasformazioni dinamiche dei parametri sonori in tempo reale. Quindi l’esecutore, mentre esegue la parte strumentale, con la sua gestualità genera conspevolmente anche le coordinate per la trasformazione timbrico-spaziale del suono da lui prodotto». Le frontiere della musica, insomma, sono infinite.
Nicola Sani
Compositore, direttore artistico, manager culturale; dal 2015 è direttore artistico della Fondazione Accademia Musicale Chigiana, è membro del consiglio artistico della IUC-Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, del consiglio di amministrazione della Fondazione Archivio Luigi Nono di Venezia e del comitato scientifico della Fondazione Bassiri. È stato sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna, consigliere di amministrazione e direttore artistico del Teatro dell’Opera di Roma, presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, presidente della Fondazione Isabella Scelsi di Roma, dedicata al lascito culturale del compositore Giacinto Scelsi. È stato curatore della Sezione Arte Elettronica del Romaeuropa Festival, direttore artistico del Festival “Emergenze” di Roma, direttore artistico del Progetto “Sonora” promosso dal Ministero degli Affari Esteri per il sostegno e la diffusione della nuova musica italiana all’estero, in collaborazione con la Federazione CEMAT. Nel 2011 è stato insignito dal Ministro della Cultura francese del titolo di “Chevalier des Arts et des Lettres”. Nel 2023 è stato nominato Accademico d’Onore dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, per la Classe di Musica. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. È autore di opere di teatro musicale e per la danza, composizioni sinfoniche e da camera, creazioni intermediali, composizioni per live electronics e fixed media, eseguite e presentate nelle principali stagioni e festival in Italia e all’estero. È autore di opere di teatro musicale e per la danza, composizioni sinfoniche e da camera, creazioni intermediali, composizioni per live electronics e fixed media, eseguite e presentate nelle principali stagioni e festival in Italia e all’estero. Ha al suo attivo un’ampia discografia, il suo catalogo è pubblicato dalle Edizioni SZSugar di Milano.