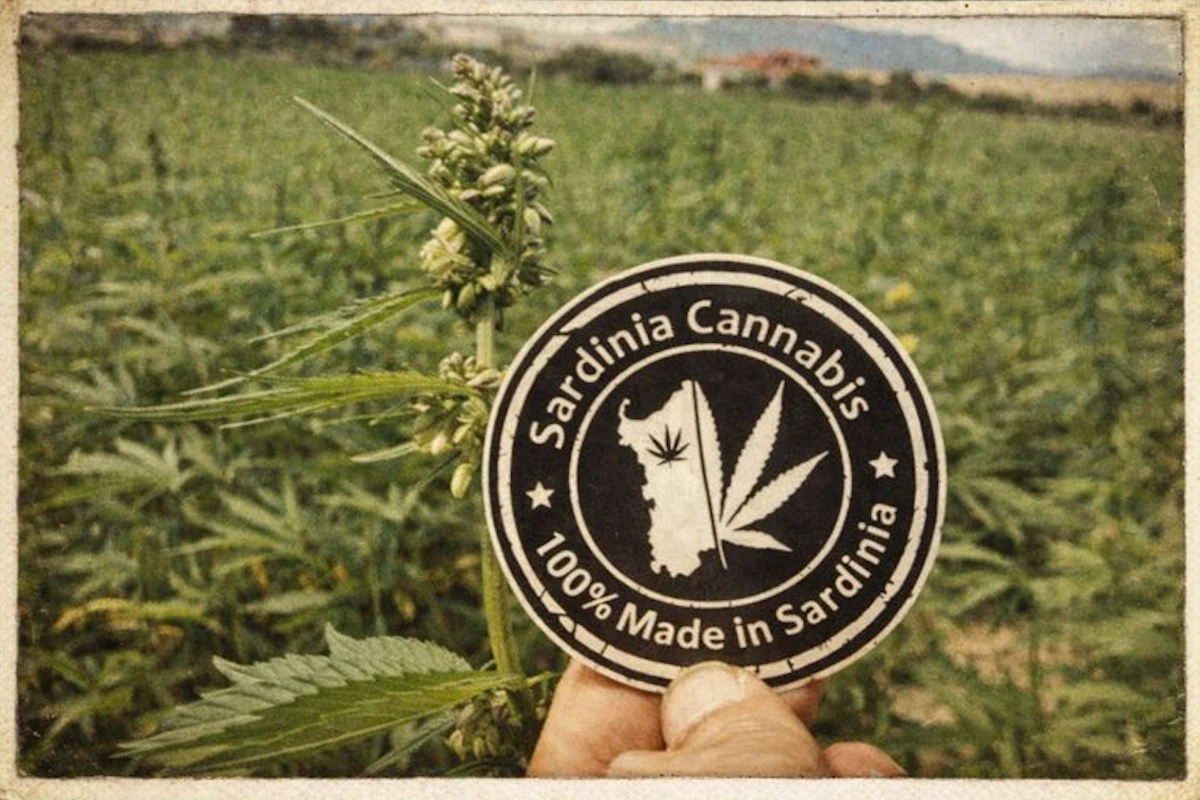Affinità tra arcipelaghi: il concetto di ma tra Venezia e il Giappone
Kengo Kito e Mika Ninagawa raccontano una relazione estetica e culturale tra due mondi solo apparentemente lontani. Anonymous art project riapre il Cortile dell’Agrippa del Museo archeologico nazionale di Venezia
Punti di contatto tra Venezia e il Giappone: il concetto giapponese di ma
Venezia e il Giappone, pur distanti geograficamente e storicamente, condividono alcuni tratti strutturali e culturali che li rendono sorprendentemente affini. Entrambe sono civiltà nate in stretta relazione con l’acqua: Venezia sviluppata su una laguna fragile e mobile, il Giappone come arcipelago circondato dall’oceano. Questa condizione insulare ha influenzato in entrambi i casi l’organizzazione dello spazio, la gestione delle risorse, la concezione del tempo e la sensibilità verso la natura. Entrambe le culture hanno prodotto una visione architettonica e urbana fondata sull’adattamento, sulla modularità e sull’equilibrio tra pieni e vuoti.
Il concetto giapponese di ma (intervallo, pausa, spazio relazionale) trova corrispondenze nella disposizione delle calli e dei campi veneziani, nei percorsi che alternano vedute e chiusure, silenzio e densità. Anche sul piano culturale, Venezia e il Giappone hanno espresso un forte senso della memoria materiale: la cura per l’oggetto, per la collezione, per la stratificazione, sia nel tessuto urbano sia nella produzione artistica, è parte integrante di entrambe le identità. Infine, si riscontra in entrambi una capacità di tenere insieme tradizione e innovazione, antico e contemporaneo, senza che l’uno annulli l’altro, ma anzi ne esalti la presenza.
Venezia e il Giappone, la relazione con l’acqua, la memoria e l’antico
A Venezia, l’urbanistica lagunare ha imposto una riflessione continua sulla gestione dello spazio fluido, sull’alternanza tra pieni e vuoti, sulla costruzione di percorsi e soglie. Venezia e il Giappone condividono un rapporto con l’acqua non solo come elemento naturale ma come condizione identitaria. La laguna veneziana e l’insularità giapponese producono forme di vita culturale legate all’adattamento, alla mobilità e alla trasformazione. L’acqua diventa un vettore simbolico che unisce, separa e riflette. Un altro punto di contatto è il valore attribuito alla memoria materiale. La tradizione del collezionismo veneziano, testimoniata dalle raccolte del Museo archeologico e dalle donazioni delle famiglie patrizie, richiama il rispetto giapponese per gli oggetti, per la loro funzione narrativa e per la loro capacità di custodire la storia. La relazione tra antico e contemporaneo si sviluppa in entrambe le culture non per opposizione, ma per integrazione.
Venezia e Giappone. Due mostre per un dialogo culturale tra arte, spazio e società
A sottolinea questi legami tra il Paese del Sol Levante e Venezia, la città lagunare nel 2025 ospita due mostre dedicate all’arte contemporanea giapponese nell’ambito del progetto anonymous art project, presentato per la prima volta in Europa. Le mostre LINES di Kengo Kito, al Museo archeologico nazionale di Venezia, e INTERSTICE di Mika Ninagawa con il collettivo EiM, a Palazzo Bollani, si inseriscono nel programma parallelo alla 19. Biennale Architettura. Questi due interventi, pur diversi per linguaggio e contenuti, si pongono come strumenti di riflessione sul rapporto tra individuo, spazio e tempo. Un legame profondo tra la cultura veneziana e quella giapponese, che si ritrova nella concezione dello spazio, nella relazione con l’acqua e nella valorizzazione del passato come risorsa presente: Kito introduce un elemento contemporaneo in uno spazio storico senza cancellarne la specificità; Ninagawa rielabora motivi tradizionali con strumenti digitali, senza neutralizzarne il significato simbolico.
Il progetto anonymous art project e la sua filosofia
Fondato nel 2023 da Hiroyuki Maki, anonymous art project nasce come programma filantropico indipendente per sostenere artisti giapponesi attraverso donazioni, residenze, mostre e collaborazioni istituzionali. Il progetto rifiuta logiche commerciali e si propone di restituire valore alla società attraverso l’arte, creando contesti di fruizione che favoriscano un rapporto diretto tra opere, pubblico e territorio. La scelta di Venezia come primo luogo di attività internazionale ha una valenza simbolica e operativa: la città è da sempre uno snodo tra culture diverse e rappresenta un ambiente complesso, stratificato e aperto.

Grazie a anonymous art project riapre il Cortile dell’Agrippa del Museo archeologico nazionale di Venezia
L’installazione LINES di Kengo Kito si ispira al concetto giapponese di ma (intervallo, pausa), inteso come spazio che rende possibile la coesistenza di elementi differenti. In questo senso, l’opera non si impone sul luogo, ma lo attraversa e lo attiva. La base specchiante riflette le strutture verticali, ma anche le superfici e le architetture circostanti, generando una sovrapposizione visiva tra antico e contemporaneo. L’opera si colloca idealmente in continuità con i temi affrontati dal Giappone alla Biennale di Architettura, dove la riflessione sullo “spazio neutro” (neutrality) mette in discussione la centralità dell’umano e propone un sistema di relazioni tra vivente, non vivente e architettura.
La mostra coincide con la riapertura del Cortile dell’Agrippa, del Museo archeologico nazionale di Venezia , chiuso da tempo, che torna visibile grazie anche a un intervento conservativo sostenuto da anonymous art project. L’installazione di Kito diventa così un dispositivo che lega memoria, accessibilità e fruizione attuale, contribuendo a rilanciare il ruolo pubblico del museo. L’apertura di un nuovo ingresso da Piazzetta San Marco, insieme alla riorganizzazione dei percorsi di visita, indica una volontà di riattivazione dello spazio culturale come luogo di relazione con la città.
LINES di Kengo Kito: lo spazio come relazione
L’intervento di Kengo Kito, allestito nel Cortile dell’Agrippa e nella Sala V del Museo archeologico nazionale di Venezia, consiste in una serie di tubi quadrati fluorescenti installati verticalmente su una base ovale riflettente. L’opera è pensata in dialogo con l’architettura rinascimentale del cortile, progettato nel XVI secolo da Vincenzo Scamozzi, e con l’impianto museale che conserva reperti greci e romani. Kito lavora da anni con materiali industriali, utilizzando strutture modulari per creare ambienti in cui lo spettatore è invitato a riflettere sulla relazione tra forma, materia e spazio.
Interstice di Mika Ninagawa con EiM: percezione e soglia
La seconda mostra, Interstice, è un progetto immersivo che vede la collaborazione tra la fotografa e regista Mika Ninagawa e il collettivo EiM, composto da figure provenienti dal mondo della data science, del lighting design e della produzione visiva. L’esposizione, ospitata a Palazzo Bollani, si sviluppa come un percorso sensoriale tra immagini, luci e suoni, con l’obiettivo di indagare i concetti di soglia, confine e passaggio. Ninagawa lavora da anni con un’estetica che mette al centro il colore, i fiori, i corpi e i paesaggi, esplorando la tensione tra realtà e rappresentazione. Nella mostra, il tema della sospensione si manifesta attraverso la combinazione di elementi naturali e artificiali, in cui la presenza dei fiori – soggetto ricorrente nella cultura giapponese – assume una funzione evocativa. I fiori fotografati da Ninagawa sono i fiori artificiali che vengono posti sulle tombe. Queste foto sono poi state stampate su tessuti rettangolari che ricordano la forma delle lapidi. Le tombe e la morte diventano qui ancora una volta sinonimo di soglia, di spazio tra due luoghi.
Mika Ninagawa con EiM a Palazzo Bollani
Le immagini non sono solo decorazioni, ma strumenti di interrogazione percettiva. I dispositivi tecnologici utilizzati dal collettivo EiM trasformano lo spazio in un ambiente mobile, dove il visitatore è sollecitato a ridefinire la propria posizione. Il titolo Interstice richiama uno spazio di transizione, che può essere interpretato sia in termini architettonici che esistenziali. Il progetto non propone una narrazione lineare, ma una costellazione di stimoli che mettono in discussione la stabilità del punto di vista. Anche in questo caso, il luogo ospitante, Palazzo Bollani – un edificio veneziano carico di stratificazioni storiche – diventa parte attiva della costruzione di senso. Venezia si conferma ancora una volta luogo di sperimentazione e scambio, capace di accogliere voci diverse e di metterle in relazione. La scelta di lavorare in spazi pubblici, museali e urbani, con opere che non solo occupano ma interpretano l’ambiente, rende questo dialogo tra Giappone e Venezia non solo estetico, ma sociale. Un dialogo che non si limita a rappresentare, ma che cerca di attivare nuovi modi di abitare il presente.