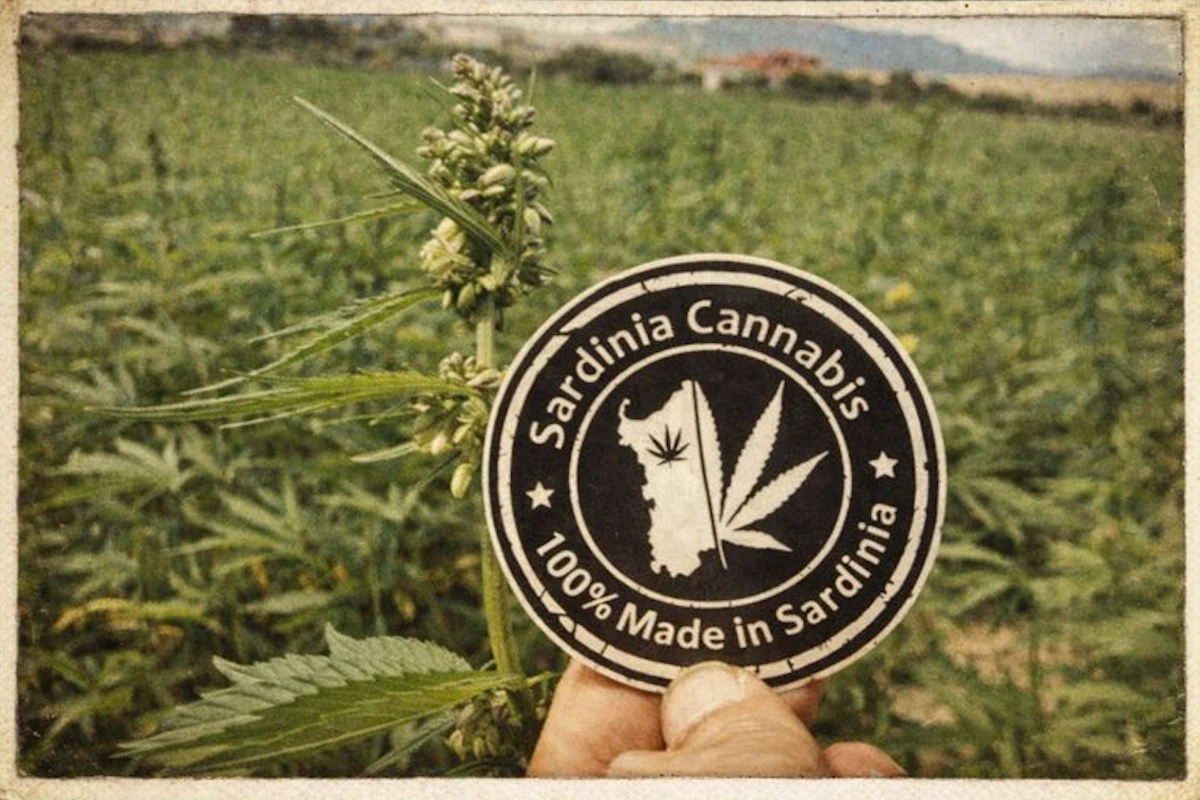Alcova a Varedo: ritorna la storia di SNIA Viscosa e il dramma delle fibre sintetiche
A Varedo, Alcova apre gli spazi della SNIA Viscosa: la storia dell’inquinamento prodotto dall’industria tessile, il dramma e la vergogna che dovrebbe essere oggi un monito per il futuro
Alcova a Varedo abita quattro architetture – tra queste l’ex Fabbrica SNIA Viscosa di Varedo
Alcova ha aperto al pubblico spazi inediti, caratterizzati da valore storico e architettonico: icone del design, ma anche luoghi in stato di abbandono o in fase di trasformazione. Per l’imminente edizione 2025 del Salone del Mobile.Milano, in seno agli eventi del Fuorisalone, Alcova amplia il proprio intervento a Varedo, comune brianzolo a pochi chilometri da Milano, dove abiterà quattro architetture.
Accanto alle residenze storiche di Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi, già protagoniste dell’edizione del 2024, si aggiungono le Serre di Pasino e l’ex Fabbrica SNIA Viscosa di Varedo. Quest’ultima è un simbolo dell’industrializzazione italiana del Novecento, un luogo che un tempo pulsava di vita e di lavoro e che oggi, seppur in stato di dismissione, conserva un’identità architettonica e sociale di forte impatto.
Le installazioni di Alcova all’ex stabilimento SNIA Viscosa di Varedo
L’ex stabilimento SNIA offre uno scenario in cui il declino industriale si fonde con la pacifica riconquista della natura. In questo spazio verrà esposta l’installazione Under the Volcano di Ranieri, un’opera imponente che racconta la nuova collezione in pietra lavica creata da Francesco Meda e David Lopez Quincoces per l’azienda, situata ai piedi del Vesuvio.
Inoltre, Habitare presenterà una ricerca sui materiali del futuro, proponendo i progetti di alcune aziende e designer finlandesi selezionati. Il collettivo americano Decibel Made si esibirà dal vivo, realizzando oggetti con una grande stampante 3D, mentre 18 Drops of Sweat dei francesi Warm Weekend (Thomas Florès, Marlon Bagnou Beido), Mathias Palazzi e Robinson Guillermet darà vita a un vero e proprio hammam gonfiabile.
Cos’è l’ex stabilimento SNIA Viscosa di Varedo?
Le fondamenta della SNIA Viscosa di Varedo vanno ricercate nei primi decenni del Novecento, in un contesto di fermento per l’industria chimico-tessile nazionale. La SNIA (acronimo di Società di Navigazione Italo Americana) era stata fondata nel 1917 dall’imprenditore Riccardo Gualino come compagnia di navigazione. Esaurite le opportunità legate ai trasporti marittimi nel primo dopoguerra, Gualino decise di riconvertire le proprie attività in ambito tessile e chimico. L’azienda scommise sulla viscosa – chiamata anche raion – una fibra artificiale ottenuta dalla cellulosa, considerata all’epoca un prodotto innovativo e con prospettive di mercato.
Intorno al 1922, SNIA avviò con la società britannica Courtaulds una joint-venture per realizzare uno stabilimento di seta artificiale a Varedo, in Brianza. Da questa iniziativa nacque quello che sarebbe poi divenuto un polo produttivo. Già nel 1925, con la denominazione di SNIA Viscosa, l’azienda era un colosso del settore: vantava un capitale sociale di 1 miliardo di lire – una cifra notevole per l’epoca – e produceva 24.000 kg di filati artificiali al giorno. Ciò corrispondeva a circa il 68% della produzione nazionale e all’11% di quella mondiale.

La produzione annua di rayon toccò il picco di 9,5 milioni di kg proprio nel 1929
Nel 1927, SNIA acquisì il controllo totale del Gruppo Seta Artificiale Varedo, incorporando completamente lo stabilimento di Varedo e quello di Magenta. Nonostante la crisi economica del 1929, la fabbrica brianzola continuò la propria attività: la produzione annua di rayon toccò il picco di 9,5 milioni di kg proprio nel 1929, confermando la leadership dell’azienda sul mercato. Gli anni Trenta consolidarono il ruolo di SNIA Viscosa come attore chiave del tessile italiano: partecipò ai programmi autarchici del regime fascista e sperimentò nuove fibre, come la Lanital (derivata dalla caseina del latte). Parallelamente, lo stabilimento di Varedo continuò a espandersi e ad aggiornare i propri impianti produttivi, rimanendo all’avanguardia nella produzione di viscosa e fiocco di viscosa.
Il primo impianto italiano per la produzione di Nylon 6: Lilion
Nel secondo dopoguerra, con la ripresa economica italiana, l’impianto di Varedo conobbe una nuova fase di crescita. Tra il 1948 e il 1952, furono installati moderni filatoi continui per il rayon; nel 1954 fu avviato il primo impianto italiano per la produzione di Nylon 6 (denominato commercialmente “Lilion”), segnando l’ingresso del polo varedese nell’era delle fibre sintetiche. L’occupazione crebbe rapidamente, fino a raggiungere nel 1965 il massimo storico di circa 6.000 dipendenti diretti e altri 1.000 lavoratori dell’indotto.
A quel tempo, Varedo rappresentava uno dei maggiori fulcri dell’economia italiana nel comparto chimico-tessile: non solo alimentava le esportazioni, ma faceva da traino anche a tutta la filiera meccanotessile e ai servizi correlati. Era una città nella città, in cui il lavoro e la dimensione sociale del territorio si fondevano in un unico tessuto.
Sul piano sindacale e delle rivendicazioni operaie, lo stabilimento SNIA di Varedo fu un laboratorio
La presenza della SNIA Viscosa a Varedo ebbe un impatto sulla comunità locale, trasformandone l’assetto demografico e urbanistico. Tra gli anni Venti e i Sessanta del Novecento, migliaia di lavoratori – spesso provenienti da altre regioni italiane – si trasferirono in Brianza per cercare opportunità nella fabbrica. Questo fenomeno migratorio interno contribuì a formare un tessuto sociale eterogeneo, coeso attorno all’industria chimico-tessile.
Come tipico delle grandi imprese dell’epoca, la SNIA adottò forme di welfare aziendale “paternalistico”: costruì abitazioni per gli operai, aprì un asilo nido interno allo stabilimento, fornì spacci aziendali, impianti sportivi e strutture ricreative. Non lontano da Varedo, a Cesano Maderno, sorse un “Villaggio SNIA”, progettato per ospitare i dipendenti dell’azienda, con servizi e spazi di condivisione che esistono tutt’oggi.
Già a partire dagli anni Cinquanta, i lavoratori SNIA si mobilitarono per migliorare le proprie condizioni contrattuali. Il cosiddetto “autunno caldo” del 1969-1970 vide a Varedo alcuni tra i più duri conflitti industriali a livello nazionale: celebre rimase lo sciopero ad oltranza del maggio 1970, quando circa 600 operai furono sospesi dall’azienda e risposero occupando l’area con una tendopoli di protesta, seguiti da uno sciopero generale dell’intera zona. Queste lotte contribuirono a conquistare nuovi diritti e a fare da apripista per alcune normative nazionali sul lavoro e la tutela sindacale (come lo Statuto dei Lavoratori del 1970).

Economia e trasformazioni
Negli anni Sessanta, la SNIA Viscosa controllava diversi stabilimenti in tutto il Paese e impiegava circa 20.000 dipendenti, costituendo una delle realtà industriali più solide.
A partire dai primi anni Settanta, tuttavia, emersero segnali di crisi strutturale. L’aumento della concorrenza internazionale, l’evoluzione tecnologica nel settore delle fibre chimiche e le turbolenze della petrolchimica (specialmente dopo lo shock petrolifero del 1973) misero in difficoltà i produttori italiani di fibre sintetiche. Nel 1974, SNIA fu assorbita dal gruppo Montedison e, nel 1980, passò poi alla FIAT. Tali passaggi societari segnarono la graduale perdita di autonomia decisionale di Varedo, che si trovò a dover seguire strategie imposte “dall’alto”.
Nel 1982 fu chiusa definitivamente la produzione di rayon viscosa nello stabilimento, a causa sia di cali nella domanda sia di problematiche ambientali. La fabbrica sopravvisse concentrandosi sulle fibre sintetiche, ma la forza lavoro si ridusse. Gli anni Novanta videro ulteriori ristrutturazioni e, nonostante qualche tentativo di diversificazione (la fusione con BPD diede vita a SNIA BPD; poi fu creata la società Sorin Biomedica per il settore biomedicale), la situazione economica continuò a deteriorarsi. La chiusura definitiva dello stabilimento di Varedo avvenne nel 2003, con lo spegnimento delle ultime linee di produzione del nylon Lilion.
Architettura e design: un patrimonio di archeologia industriale
Dal punto di vista architettonico, l’ex SNIA Viscosa di Varedo costituisce un esempio di archeologia industriale lombarda. Il complesso – costruito e ampliato tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta del Novecento – presenta elementi tipici dell’architettura industriale razionalista: strutture in cemento armato, mattoni a vista, linee essenziali e modulari, funzionali alle esigenze produttive.
Gli edifici originari degli anni Venti e Trenta si distinguono per un linguaggio sobrio, privo di ornamenti superflui, in cui domina l’idea di efficienza e solidità. L’uso di ampie vetrate, tipico dei capannoni a shed, favoriva l’ingresso della luce naturale. Gli spazi interni erano organizzati secondo una logica di flussi produttivi, con ambienti aperti facilmente riconfigurabili in base alle necessità delle linee.
L’ingresso principale, con la facciata simmetrica e la ciminiera che si staglia sullo sfondo, è un “landmark” urbano. Sebbene oggi appaia abbandonato, con vetrate rotte e muri scrostati, l’insieme racconta ancora lo spirito di un’epoca in cui le fabbriche erano visti come luoghi di progresso e modernità.
Oltre all’eredità culturale, la lunga attività dello stabilimento ha lasciato una traccia ambientale: la storia di un dramma
Il dramma. La produzione di viscosa e di fibre sintetiche utilizzava, infatti, sostanze chimiche tossiche e inquinanti (solventi organici, acidi, basi forti, metalli pesanti) che nel corso dei decenni, complice una normativa ambientale meno rigorosa rispetto a quella odierna, possono aver contaminato terreni e falde acquifere.
Al momento della chiusura, e in particolare dopo il 2003, il sito fu quasi del tutto abbandonato. La totale assenza di vigilanza favorì l’ingresso di soggetti estranei e lo smaltimento illecito di rifiuti. Nel tempo, si accumularono all’interno dei capannoni in disuso circa 2.500 tonnellate di rifiuti, tra materiali chimici, macchinari abbandonati, fusti di sostanze ignote e detriti edilizi. Un quadro preoccupante, che ha imposto la necessità di una massiccia bonifica: prima di poter avviare qualunque forma di recupero, occorre infatti rimuovere i rifiuti in superficie, mettere in sicurezza i terreni e trattare le eventuali contaminazioni chimiche profonde.
Le istituzioni locali e regionali hanno inserito l’ex SNIA di Varedo nei piani di risanamento ambientale, richiedendo indagini approfondite su suolo e acque. Gli interventi di bonifica dovranno includere anche opere di caratterizzazione idrogeologica e chimica, in modo da individuare con precisione l’estensione degli inquinanti e adottare le soluzioni più adeguate. Parallelamente, nell’ottica di mitigare le piene del fiume Seveso (che attraversa la zona), si è previsto di realizzare vasche di laminazione in parte dell’area ex SNIA, soluzione che però necessita di un’attenta valutazione per evitare che diventi un accumulo di acque inquinate se non si interviene a monte sul risanamento del torrente.

Situazione attuale e prospettive di riqualificazione della ex SNIA Viscosa di Varedo
Con la chiusura della fabbrica, l’area è rimasta per anni in stato di degrado: tetti crollati, vetrate infrante, vegetazione spontanea e occupazioni abusive. La proprietà dell’immenso compendio industriale è passata attraverso lunghe procedure fallimentari: dopo l’insolvenza di SNIA, la società Nylstar (che aveva gestito le produzioni residue) è fallita anch’essa, generando un vuoto gestionale e un rincorrersi di aste deserte.
Soltanto nel 2019 si è arrivati a un’asta di aggiudicazione, in cui la società MG Sviluppo Srl si è fatta carico dei principali lotti dell’ex SNIA. La formalizzazione dell’acquisto si è completata nel 2020, non senza ritardi dovuti anche all’emergenza sanitaria Covid-19. Da quel momento, il Comune di Varedo ha potuto contare su un interlocutore definito, ponendo le basi per un progetto di rigenerazione urbana.
Il piano di riqualificazione prevede l’implementazione di diverse componenti integrate
In primo luogo, si ipotizza la creazione di un polo logistico e industriale, che preveda la nascita di un centro di distribuzione – con la prospettiva, tra l’altro, dell’ingresso di Amazon – e l’insediamento di attività produttive leggere, capaci di generare oltre 1.000 posti di lavoro. Parallelamente, sono in programma interventi mirati su infrastrutture e servizi: la realizzazione di un sottopasso ferroviario per migliorare la viabilità locale, la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri e la realizzazione di vasche di laminazione, ideate per mitigare il rischio idrogeologico legato alle piene del Seveso.
Nel masterplan approvato dalle amministrazioni locali si prevede altresì di destinare circa il 40% della superficie a verde e a servizi di pubblica utilità, con la creazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e spazi di aggregazione che favoriscano la socialità e la fruibilità dell’area. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la valorizzazione storica: si intende recuperare alcuni edifici di maggior pregio storico-architettonico, evitando la demolizione integrale di quanto resta, e al contempo è prevista la conservazione e digitalizzazione di archivi e documenti storici della fabbrica, al fine di tramandarne la memoria. In quest’ottica, è stata avanzata l’idea di dedicare una piazza ai “Lavoratori della SNIA”, in omaggio alle generazioni di operai che hanno contribuito allo sviluppo socioeconomico del territorio.
Infine, il cronoprogramma dei lavori è distribuito su più anni, con la stima di completare la maggior parte delle opere entro il 2027, compatibilmente con l’esito delle bonifiche e con le procedure autorizzative previste.
L’ex SNIA Viscosa di Varedo e Alcova: un nuovo sguardo sul patrimonio industriale
In questo scenario di riscoperta e (futura) trasformazione, si inserisce l’iniziativa di Alcova, che ha deciso di includere l’ex SNIA di Varedo fra i propri spazi espositivi. Ci si aspetta che il progetto Alcova instauri un dialogo tra l’heritage industriale e architettonico con il design contemporaneo, aprendo al pubblico luoghi normalmente inaccessibili.
Matteo Mammoli