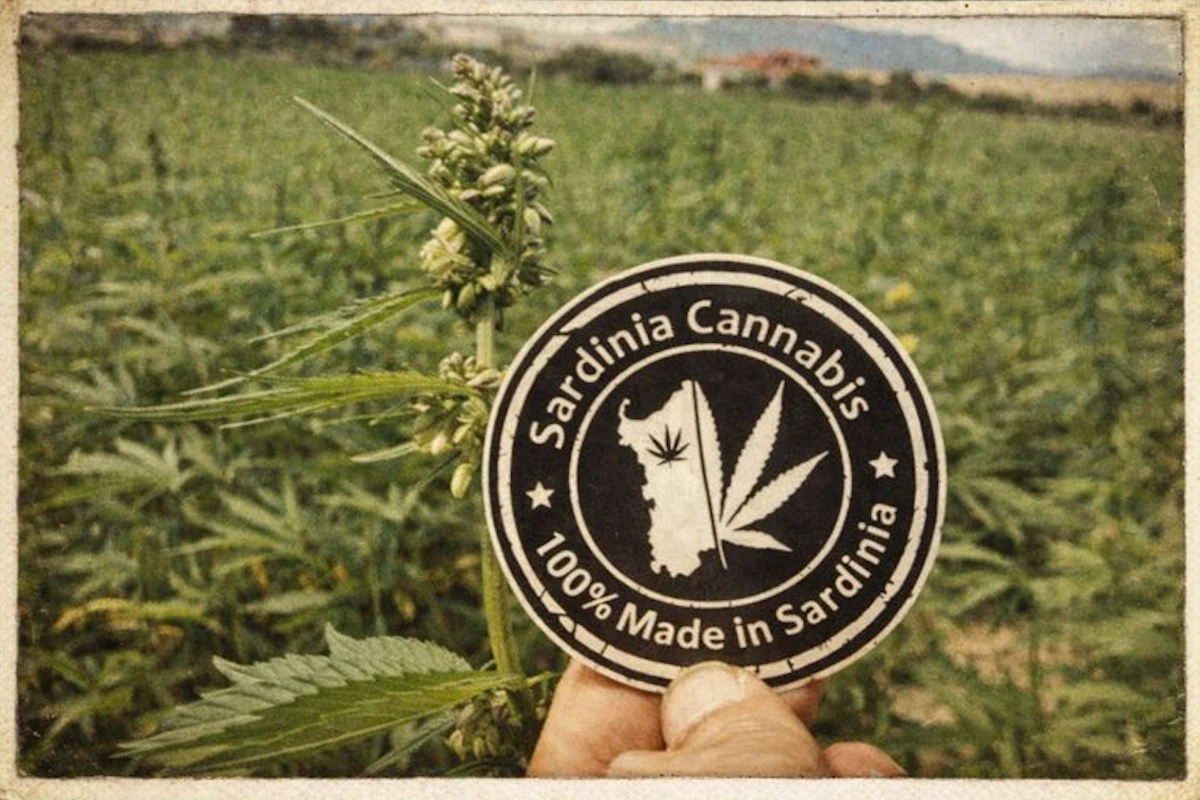Architettura, tempo e paesaggio: Alvisi Kirimoto
Dal nuovo percorso espositivo della Basilica di Massenzio alla Cantina Bulgari a Podernuovo, il lavoro di Alvisi Kirimoto tra valorizzazione del patrimonio archeologico, sostenibilità e dialogo con il contesto
Basilica di Massenzio, Roma – Il nuovo percorso espositivo di Alvisi Kirimoto
Lo studio Alvisi Kirimoto ha curato il progetto del nuovo percorso espositivo della Basilica di Massenzio a Roma, commissionato dal Parco archeologico del Colosseo. L’intervento si inserisce all’interno del programma di valorizzazione dell’area dei Fori Imperiali e riguarda il riuso contemporaneo di uno dei principali monumenti dell’antichità romana, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità e le modalità di fruizione pubblica.
Il progetto prevede tre elementi principali: la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale destinata a palco per eventi, il rifacimento della pavimentazione dell’intero complesso e l’installazione di due totem informativi con funzioni audio-video. Collocato nell’aula centrale, il palco ristabilisce la continuità del percorso trasversale tra le tre navate e può essere utilizzato per spettacoli, incontri e attività culturali, oltre a offrire punti di osservazione sui resti della Basilica.
L’intervento comprende inoltre il riordino del piazzale esterno con pavimentazione in terra stabilizzata e la predisposizione di accessi e rampe per migliorare la fruibilità. La struttura, realizzata con telaio in acciaio e piani modulari in multistrato di betulla, integra gradonate e parapetti metallici, garantendo versatilità d’uso e sicurezza. L’insieme delle opere è finalizzato a rendere la Basilica accessibile e funzionale per iniziative culturali contemporanee, mantenendo la leggibilità e l’integrità del monumento antico.
L’intervento alla Basilica di Massenzio si inserisce in una linea di ricerca che caratterizza diversi lavori di Alvisi Kirimoto, orientata alla relazione tra architettura, tempo e contesto. La capacità di dialogare con luoghi complessi, calibrando linguaggio e scala dell’intervento, emerge in opere di diversa natura e funzione: spazi culturali, edifici produttivi, strutture pubbliche e dispositivi temporanei. Tra questi, la Cantina Bulgari a Podernuovo rappresenta un caso significativo per comprendere come lo studio affronti il rapporto tra costruzione, paesaggio e processo produttivo, traducendo esigenze tecniche e territoriali in un organismo architettonico coerente e integrato.


Cantina Bulgari a Podernuovo: assetto, ciclo produttivo e rapporto con il paesaggio
La Cantina Bulgari a Podernuovo si trova a San Casciano dei Bagni e si imposta come una sequenza di setti in calcestruzzo pigmentato che seguono la pendenza del terreno, limitando gli sbancamenti e integrando il volume nella collina. Commissionata da Giovanni e Paolo Bulgari, concentra le funzioni lungo un corridoio centrale passante che ordina i percorsi e inquadra il paesaggio. La distribuzione rende leggibile l’intero ciclo produttivo: ricezione e lavorazione delle uve nelle aree a quota d’accesso; ambienti di affinamento e stoccaggio in parte interrati per stabilità termo-igrometrica; degustazione e rappresentanza in testata, con affacci controllati sui filari.
Le superfici vetrate assicurano continuità visiva tra produzione e paesaggio, ma sono dimensionate e schermate per gestire apporti solari e abbagliamento. Al livello superiore si trovano uffici e terrazze operative con vista su vigne e uliveti; il livello inferiore ospita la parte tecnica e produttiva, con percorsi separati per personale, visitatori e movimentazione merci. Il pacchetto edilizio comprende tetto verde, schermature metalliche e finiture in materiali locali (calcestruzzo pigmentato, laterizio tecnico, acciaio verniciato), con soluzioni passive per l’inerzia termica e la ventilazione dove possibile. L’impostazione privilegia manutenzione semplificata, accessibilità ai macchinari, aree di sosta per logistica e carico/scarico protette dalle intemperie.
«Un progetto per volta, come fosse il primo.» Con questa frase si apre il volume di Forma Edizioni Architetture scelte 2012–2025, che raccoglie oltre dieci anni di lavoro dello studio Alvisi Kirimoto. La dichiarazione definisce una pratica che evita la standardizzazione, adotta tempi coerenti con la complessità degli incarichi e parte dall’analisi del contesto.
Il tempo come materiale dell’architettura: metodo, fasi e verifica d’uso
Massimo Alvisi: «Junko ed io abbiamo avuto maestri come Massimiliano Fuksas e Renzo Piano e nei loro studi abbiamo lavorato a progetti che coinvolgono centinaia di persone e richiedono un’organizzazione complessa. Da quando abbiamo fondato il nostro studio abbiamo cercato una via più lenta e sartoriale. È una scelta di metodo che ci porta a considerare luogo, committente, momento storico e dimensione culturale. I nostri progetti non sono standardizzati: cambiano con contesto, materiali disponibili e mano di chi lavora con noi.»
L’assunzione del tempo come variabile progettuale riguarda sia la fase di sviluppo (analisi, prototipi, mock-up, prove in cantiere), sia la vita utile dell’opera. «Nella nostra slow architecture il tempo è centrale. La vita di un progetto non finisce con l’inaugurazione. Continua con chi lo abita, con la luce, con il paesaggio. La Cantina Bulgari: il cemento armato assorbe la luce, cambia con l’umidità e con i gesti quotidiani. Dopo tre anni, la ritrovi diversa.» Questo approccio include momenti di verifica post-occupazione, aggiustamenti puntuali e manutenzioni programmabili, con attenzione a costi di esercizio e accessibilità alle parti impiantistiche.
Architettura che non urla: scelta del registro e controllo dell’impatto
«Quando abbiamo fondato lo studio, abbiamo scelto di non affidarci all’architettura che strilla. L’urlo cattura l’attenzione, ma non sempre è la risposta giusta.» Il registro dell’intervento è calibrato sul luogo: segno più marcato dove serve riconoscibilità e presidio urbano; riduzione dell’impronta e maggiore trasparenza in contesti ambientali sensibili. La misura del gesto non è un principio astratto: deriva da programma funzionale, regimi di tutela, flussi d’uso, ombre e viste, interferenze con reti e infrastrutture esistenti.
«L’asilo e il Centro Civico di Grottaperfetta: un’architettura più visibile. In situazioni più sensibili – come The Dome alla Luiss, accanto a Villa Ada – forzare il linguaggio non avrebbe avuto senso. L’architettura deve anche sapersi fare discreta, mettersi in relazione, ascoltare. Preferiamo sedimentare e lasciare che l’architettura parli nel tempo.»
Grottaperfetta: asilo e centro civico come infrastrutture di quartiere
Il complesso di Grottaperfetta, a Roma, interviene in un’area residenziale con carenza di spazi pubblici. L’impianto prevede due volumi paralleli in cemento armato e mattoni faccia a vista. Le corti tra i corpi di fabbrica diventano spazi collettivi protetti, collegati a una rete di percorsi pedonali che si innestano sulle strade locali. I fronti sono scanditi da aperture regolari e inserti cromatici che organizzano ingressi e percorsi, con attenzione a orientamento, ombreggiamento e sicurezza.
L’asilo dispone le aule attorno a un patio per luce naturale e ventilazione trasversale; gli spazi di servizio sono collocati su fasce compatte per ridurre interferenze con le attività didattiche. Il centro civico integra biblioteca di quartiere, sale polivalenti e ambiti per associazioni. Le superfici esterne sono in materiali durevoli e facilmente mantenibili; le aree verdi di pertinenza includono zone d’ombra, sedute e attrezzature leggere. L’intervento funziona come presidio di prossimità: attiva percorsi, offre servizi e definisce un’identità leggibile senza ricorrere a effetti scenografici.



The Dome alla Luiss: padiglione trasparente nel margine di Villa Ada
The Dome si colloca sul limite di Villa Ada. L’obiettivo è fornire spazi didattici aggiuntivi senza alterare la percezione del parco. La soluzione è una struttura leggera in acciaio e vetro con cupola trasparente; l’impianto a campata libera consente configurazioni interne variabili (lezioni, incontri, piccoli convegni). La trasparenza riduce l’impatto volumetrico e garantisce illuminazione naturale; sono previste schermature e vetri selettivi per limitare i carichi estivi. I percorsi collegano il padiglione alle reti pedonali esistenti del campus, evitando barriere e garantendo accessi indipendenti per pubblico e servizio.
Gli interni adottano materiali acusticamente performanti dove necessario; gli impianti sono integrati nelle strutture secondarie per ridurre ingombri e facilitare la manutenzione. Il progetto opera per sottrazione: niente elementi superflui, attenzione alla reversibilità e a un cantiere con interferenze contenute sul parco.
Architettura a chilometro zero: sostenibilità tecnica, economica, sociale e culturale
«Non amo usare la parola “sostenibilità” perché spesso diventa retorica. Dovrebbe essere nel DNA di ogni progetto. Le forme sono almeno quattro: tecnica, economica, sociale e culturale.» La dimensione tecnica riguarda efficienza, durabilità, accessibilità alla manutenzione e prestazioni in esercizio. Quella economica include costi in ciclo di vita (energia, sostituzione componenti, pulizie, gestione). La dimensione sociale punta su processi partecipati, luoghi accessibili e attivazione di reti locali. Quella culturale attiene al rapporto con storia e abitudini del contesto, evitando soluzioni autoreferenziali.
«Un edificio deve dialogare con la storia e le abitudini del luogo. È sostenibile solo se queste dimensioni convivono.» In questo quadro, la “chilometro zero” non è slogan: significa impiegare materiali e competenze del territorio quando compatibili con prestazioni e capitolati, riducendo logistica pesante e tempi di approvvigionamento.

Il cantiere come laboratorio: dettaglio, mock-up e controllo qualità
Il cantiere è parte del progetto: i dettagli si rifiniscono con maestranze e fornitori, attraverso prove e campionature. «Il dettaglio non è mai uguale: dipende da chi lo realizza. In cantiere lavoriamo fianco a fianco con le maestranze, confrontandoci sulle soluzioni. Alcuni clienti vedono questa attenzione come eccessiva; per noi è parte del processo.» Questo metodo prevede mock-up di porzioni di facciata, test su giunti e finiture, regolazioni di cerniere e sistemi di ombreggiamento, verifiche di tenuta all’acqua e all’aria, piani di manutenzione per componenti esposti.
La gestione delle varianti è tracciata con cronoprogrammi e verbali, per evitare derive su tempi e costi. L’esito è un edificio in cui dettaglio e costruzione coincidono, con soluzioni replicabili e manutenzioni pianificabili.
Auditorium Parco della Musica, Roma: materiali e dispositivo urbano
«L’Auditorium Parco della Musica di Roma mostra la coesistenza tra innovazione e tradizione. Travertino e mattone romano convivono con tecnologia avanzata, soprattutto nelle sale.» Realizzato tra 1995 e 2002, il complesso comprende tre sale, cavea all’aperto e spazi di servizio. I volumi principali, rivestiti in piombo, sono disposti attorno alla cavea, che funziona come piazza pubblica e luogo di attraversamento urbano.
La progettazione ha combinato soluzioni acustiche dedicate con tecniche costruttive di tradizione romana (travertino, laterizio con giunti sottili) rilette in chiave contemporanea. L’uso di materiali durevoli e sistemi impiantistici integrati consente prestazioni stabili nel tempo. «Quell’esperienza conferma che innovazione e tradizione possono coesistere e produrre risultati duraturi.» L’Auditorium opera anche come infrastruttura urbana: connette percorsi, attiva funzioni culturali e definisce bordi chiari tra spazi pubblici e semi-pubblici.
TAM TAM al Fuorisalone 2025: dispositivo mobile e spazio riconfigurabile
All’interno della mostra Interni Cre-Action alla Statale di Milano, TAM TAM. Tempio, Azione, Movimento introduce un padiglione composto da sei colonne mobili. L’utente può modificarne la posizione per definire micro-ambienti temporanei (sosta, lettura, discussione). «Chi entra può muovere le colonne e creare il proprio spazio: un’azione che ridefinisce il luogo. È una riflessione sullo spazio della cultura oggi: aperto e riconfigurabile.» Il progetto sperimenta la dimensione performativa dell’architettura: non un oggetto compiuto, ma un set di regole semplici che abilita usi diversi.
Dal punto di vista tecnico, gli elementi sono dimensionati per resistere a spostamenti ripetuti e urti accidentali; le superfici sono scelte per limitare manutenzione e usura. La logica è quella del prototipo: leggere come reagisce il pubblico e tradurre l’esito in criteri per spazi culturali più flessibili.
Rigenerazione urbana per rammendi puntuali, intervista a Massimo Alvisi
Nel 2013 nasce il gruppo G124 di Renzo Piano sul tema delle periferie; tra i primi membri c’è Massimo Alvisi. «Da quell’esperienza sono arrivati strumenti normativi per la rigenerazione urbana. Oltre ai grandi interventi, contano i piccoli rammendi che incidono sulla vita quotidiana. Un esempio è Piazza ex Campari a Roma: oggi parcheggio, presto piazza di comunità. Il processo è graduale e il tempo resta un fattore decisivo.» L’idea è intervenire con opere mirate: spazi aperti attrezzati, connessioni pedonali sicure, illuminazione, cura dei bordi, supporto a funzioni di prossimità. Ogni piccolo intervento è misurabile per benefici d’uso, costi di gestione e manutenzione.
Lo studio Alvisi Kirimoto: ambiti, strumenti e organizzazione del lavoro
Alvisi Kirimoto, fondato nel 2002 da Massimo Alvisi e Junko Kirimoto, lavora in architettura, urbanistica e design. Il metodo integra modellazione fisica (The Hands Work), prototipazione, uso mirato del digitale e coordinamento con consulenti tecnici. Il processo tipico comprende: analisi del sito e delle norme, brief funzionale con il committente, studi di volume e ombre, mock-up di dettaglio, pianificazione del cantiere e piani di manutenzione. Obiettivo: edifici leggibili, efficienti in esercizio, coerenti con contesto e programma.
Elisa Russo