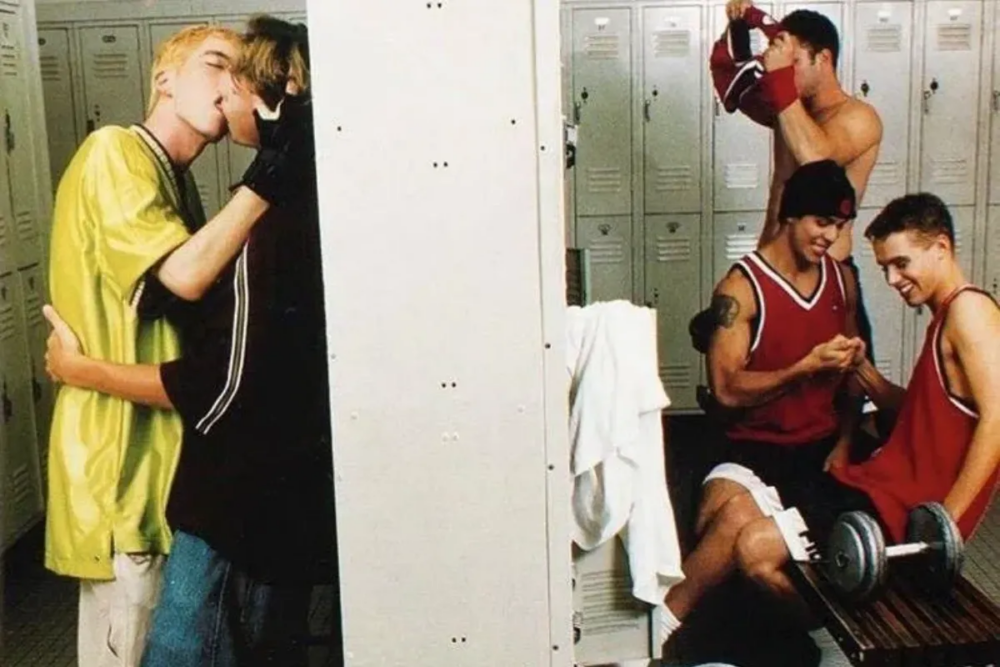Abitazioni borghesi tra crisi e trasformazione: architettura e obsolescenza
Le contraddizioni dell’architettura moderna, Allegra Martin: l’abitabilità delle ville con grandi metrature, la conservazione di edifici in cemento e la loro adattabilità
Fotografia di architettura, intervista ad Allegra Martin: interpretazione soggettiva e documentazione visiva
AM: Robert Adams parla di tre verità in fotografia, tra cui quella autobiografica. La fotografia può avere la valenza di documento, ma ha una natura ambigua: non riproduce il reale, ma una sua possibilità mediata dallo sguardo del fotografo. La fotografia di un’architettura è a sua volta un progetto, non la rappresentazione oggettiva di quell’edificio. Si tratta di una visione influenzata da fattori come l’identità del fotografo, le condizioni geografiche, l’editing operato dalla rivista su cui viene pubblicata.
Durante i miei viaggi in Europa da studentessa mi sono accorta che dal vivo gli edifici avevano dimensioni diverse rispetto a quelle percepite sui libri, oppure erano cambiati dal momento in cui erano stati fotografati. Con il passare del tempo un’architettura può danneggiarsi, cambiare funzione d’uso o essere trasformata. Mi sono chiesta: perché fotografare i progetti di un architetto come Carlo Scarpa, di cui esistono già lavori fotografici esaustivi? Perché, oltre all’interpretazione di ogni fotografo, l’architettura è un teatro in continua evoluzione e va fotografata costantemente.
Quando ho ricevuto la committenza per Atlante dell’architettura contemporanea, a ciascun fotografo selezionato è stata assegnata una lista di architetture moderne realizzate in Italia, catalogate dal Ministero. Alcune schede del censimento facevano riferimento alle foto dell’edificio appena costruito, che non corrispondevano più a quello attuale, oppure avevano cambiato destinazione d’uso, come il Centro Servizi Sociali per i dipendenti delle fabbriche Olivetti a Ivrea, progettato da Figini e Pollini, che oggi ospita una sede dell’Agenzia delle Entrate. È necessario fotografare le stesse architetture perché il vero tema delle città e del paesaggio è il loro cambiamento nel tempo.
Fotografare il cambiamento urbano: infrastrutture e trasformazioni del paesaggio
AM: Nel 2007 ho frequentato un laboratorio con Tim Davis sui cantinieri della TAV di Reggio Emilia, promosso dall’associazione culturale Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, fondata a Rubiera tra il 1989 e il 1990. L’obiettivo era documentare i mutamenti del paesaggio italiano, in questo caso quelli dovuti alla costruzione della linea ferroviaria veloce Milano-Bologna.
Con questo progetto mi sono chiesta per la prima volta chi avrei voluto essere attraverso la fotografia. Credevo di dover documentare i cantieri attraverso uno sguardo oggettivo. Tim Davis, invece, mi ha spinto a sperimentare un nuovo approccio, mettendo da parte il cavalletto e spostando la mia attenzione dai cantieri della TAV agli edifici e alle persone che sarebbero scomparse con l’avanzamento dei lavori. Ho capito che per rappresentare la trasformazione non dovevo focalizzami su un unico tema, ma potevo trovarne gli indizi ovunque.

Testo e immagine nella fotografia di architettura: come si completano
AM: Non mi interessa celebrare i progettisti o gli edifici che fotografo, ma raccontarne le variazioni nel tempo senza esprimere un giudizio. È un modo per conoscere e misurare lo spazio filtrato dalla mia visione.
Con Templi per lombardi laboriosi. Architetture di Mario Galvagni a Inveruno, insieme ai curatori Elisa Di Nofa e Francesco Paleari, abbiamo raccontato le stesse architetture con linguaggi diversi. Le quattro ville progettate da Mario Galvagni a Inveruno, fotografate da me e Paleari, sono le scenografie dei racconti di Emmanuela Carbé e Paolo Colagrande. Oltre alle fotografie che mostrano l’aspetto attuale delle architetture, abbiamo incluso una selezione di fotografie d’archivio delle famiglie che le hanno abitate, realizzate da uno studio fotografico locale. Infine abbiamo trovato delle foto realizzate da Galvagni dei cantieri e delle ville ultimate. Questi materiali hanno permesso di restituire una versione sfaccettata degli stessi edifici.
Nel caso del libro Dieci viaggi nell’architettura italiana, parte del progetto Atlante Architettura Contemporanea, curato da Matteo Balduzzi, abbiamo pensato a un diario di viaggio, in cui le campagne fotografiche sono accompagnate dai testi scritti dai fotografi coinvolti. Non essendo scrittori, avevo paura che il risultato fosse naif, ma grazie a questi piccoli racconti è emersa una percezione dello spazio che la fotografia da sola non può restituire. Il testo si interseca con le immagini accompagnandole, senza sovrastarle.

Case moderne in Italia: ricerca fotografica sulle architetture sperimentali
AM: Sto realizzando una ricerca sulle architetture italiane moderne a uso abitativo, caratterizzate da forme sperimentali. A Carbuta, Mario Galvagni ha trasformato una stalla nella sua casa studio, oggi abitata dalla figlia. L’edificio era quasi cieco, così Galvagni ha aggiunto delle orecchie attorno alle finestre per convogliare luce e aria. La villa progettata per l’artista Claudio Caffetto da Fausto Bontempi si distingue per gli incastri volumetrici di impronta espressionista e per la planimetria imperniata attorno a un corpo centrale. Di Casa Berrini, progettata da Umberto Riva a Taino (1966-69), mi interessava raccontare gli interventi di restauro e le aggiunte, come la piscina commissionata dai nuovi proprietari. La casa-studio progettata da Andrea Bruno insieme all’amico artista Ezio Gribaudo, nell’area di Borgo Po (Torino), è oggi sede dell’Archivio Gribaudo. L’edificio si distingue rispetto al contesto urbano: un volume compatto i cui ambienti emergono all’esterno attraverso operazioni di estrusione e sottrazione. Dall’interno, lo sguardo è orientato verso la città, visibile attraverso le vetrate del corpo scala e dalla terrazza sul tetto, da cui si scorge la Mole Antonelliana.
Le quattro case progettate da Galvagni a Inveruno sono state costruite per la medio-alta borghesia lombarda, da cui il titolo del volume Templi per lombardi laboriosi. Ciascuna riflette le esigenze della famiglia proprietaria. I primi due dei quattro casi hanno un’ampia metratura. Casa Belloli, commissionata da una famiglia di imprenditori, possiede spazi di rappresentanza dove ricevere i clienti durante le feste. Ogni dettaglio – arredi, porte, serramenti e tende – è stato supervisionato da Galvagni e realizzato da artigiani o imprese locali. Un edificio di questo tipo, concepito per poter intrattenere numerosi invitati, oggi forse non è più sostenibile.
Due delle ville di Inveruno, più contenute, sono ancora abitate dalle famiglie originarie. La prima villa è in mano agli stessi proprietari, ma non è più abitata. La seconda, dopo vari passaggi di proprietà, non essendo vincolata come bene culturale, è prossima alla demolizione. È stata lanciata una petizione per salvarla, ma il problema sono gli ingenti interventi di ristrutturazione, dal rifacimento del tetto all’adeguamento degli infissi.

Architettura moderna e obsolescenza: abitazioni borghesi tra crisi e trasformazione
AM: Gli antichi Romani distinguevano tra urbs, la città fisica come insieme degli edifici e infrastrutture, e civitas, la comunità dei cittadini come organizzazione politica e sociale. Il concetto di civitas è legato al tema dell’abitare, al cambiamento della società che comporta un adattamento dell’urbs. Un progetto fotografico deve tenere conto di entrambi gli aspetti.
Nel progetto Casa Maria Bottero/Umberto Riva, commissionato da Spazio e curato da Mariana Siracusa, l’obiettivo era raccontare non tanto la casa progettata da Umberto Riva, scomparso nel 2021, ma il modo in cui viene vissuta oggi da Maria Bottero. L’intento era restituire lo spazio nella sua quotidianità, con il maglione sulla sedia e i piatti nel lavello. La struttura della casa, rimasta invariata, è stata fotografata in passato, da Giorgio Casali a Gabriele Basilico. Il nostro obiettivo era raccontare lo stesso spazio come interno vissuto. Per il ritratto di Maria Bottero mi sono servite ore di osservazione. Volevo capire come si muoveva per ambientarla all’interno dello spazio. Preferisco che le persone siano a disagio, non in posa, in modo che non abbiano il tempo di restituire una propria versione costruita.
In Dieci viaggi nell’architettura italiana la presenza umana era limitata, sia per i tempi stretti, sia perché il progetto è stato realizzato a cavallo della pandemia. Quando fotografo un’architettura studio le figure umane che l’attraversano e cerco di ritrarle in un momento spontaneo. Uno degli aspetti chiave nel mio approccio è l’errore. Mi piace che la fotografia sia concepita come un predisporsi agli incontri fortuiti, al detour. Quando inizio un progetto ho delle idee in mente che non coincidono col risultato finale. L’aspetto più interessante del mio lavoro è la decostruzione del programma iniziale.



Fotografare l’architettura vissuta: errori, spontaneità e segni del tempo
AM: Più che i singoli architetti, mi interessa l’architettura nel suo insieme. Attraverso la fotografia, però, ho avuto occasione, prima con Mario Galvagni e Maurizio Sacripanti, e poi con Umberto Riva, di intercettare delle figure rimaste ai margini della storiografia. Attraverso il loro lavoro cerco di raccontare l’abitare moderno, toccando aspetti sociali, familiari o personali.
Nel mio lavoro su Figini e Pollini ho considerato due aspetti: da un lato il contesto storico in cui hanno lavorato – gli anni del fascismo e del boom economico – dall’altro la funzione dell’architettura rispetto alle esigenze del presente. L’Ivrea di Adriano Olivetti può essere considerata una città ideale, ma oggi il suo modello urbanistico, legato ai bisogni della fabbrica, sarebbe da ripensare. Nel 2020 sono tornata a Ivrea per una committenza UNESCO e mi sono trovata di fronte a una città che è diventata un museo a cielo aperto, popolato da architetture in gran parte dismesse. Tuttavia, estrapolando la città dal contesto, quel piano rispondeva al primo principio dell’urbanistica: regolamentare i bisogni di una determinata società.
Quando mi interfaccio con questi architetti moderni l’aspetto più affascinante è il progetto totale, quindi la cura dedicata dall’arredo fino alla scala urbana. La sfida della fotografia è tradurre questa urgenza di pensare a tutte le scale del progetto. Nell’architettura di oggi, invece, è raro trovare architetti che abbiano lavorato sia sull’edificio sia sugli interni, per motivi di budget o perché le figure professionali sono più separate. Un progetto che mi piacerebbe tornare a fotografare è il Centro Istruzione IBM di Novedrate (Como), disegnato da Bruno Morassutti, oggi sede di un’università telematica che, soprattutto negli arredi, è stato adeguato alle normative sulla sicurezza.
Urbanistica e società: come l’architettura moderna risponde ai bisogni collettivi
AM: Uno dei dilemmi delle teorie del restauro di fine Ottocento era la contrapposizione tra una visione conservatrice e una aperta al cambiamento: se cade una pietra dal Colosseo bisogna riposizionarla rispettando l’edificio originario, oppure lasciarla dov’è come testimonianza delle sue trasformazioni?
Il problema degli edifici che fotografo è che, a cinquant’anni dalla loro realizzazione, non sono più sostenibili. Oggi le case progettate nel periodo del boom economico per l’alta borghesia difficilmente risultano compatibili con le esigenze della stessa classe sociale, soprattutto per fattori energetici. Gli edifici in cemento, avendo raggiunto i settant’anni di vita, richiedono manutenzione.
Di recente, a seguito di un intervento di ripristino, ho fotografato una villa i cui volumi erano stati modificati negli anni Novanta. Mi sono chiesta: come si ristrutturano delle architetture alterate da precedenti proprietari? Il principio guida dovrebbe essere trovare un linguaggio che rispetti la struttura e, insieme, la renda attuale. In alcuni casi i vincoli storici congelano lo stato attuale, impedendo interventi su edifici che si potrebbero rendere fruibili. Non si dovrebbe aver paura di ristrutturare architetture di rilevanza storica, a condizione che l’architetto possegga le competenze per rispettare il preesistente. Oggi ammiriamo l’intervento radicale di Carlo Scarpa al museo di Castelvecchio, che invece all’epoca aveva sollevato polemiche.
Restauro dell’architettura moderna: sostenibilità e adattamento degli edifici esistenti
AM: Rispetto alle altre arti, l’architettura possiede un’utilitas: accoglie e protegge la vita. Abitiamo all’interno di edifici stratificati storicamente. L’architettura classica, oggi percepita come un simulacro, si è trasformata nel corso del tempo. La tipologia architettonica della basilica, prima di diventare un luogo di culto cristiano, nasce in epoca romana per ospitare attività commerciali.
Per una committenza dell’Ordine degli Architetti di Milano, nell’ambito del Festival FotogramMi (a cura di Giovanna Calvenzi), mi sono focalizzata sul quartiere di San Siro e sullo stadio, un esempio di architettura stratificata, oggi al centro di un dibattito per la sua riqualificazione. Anche il corpo quattrocentesco dell’Ospedale Ca’ Granda è stato ampliato negli anni Quaranta, su progetto di Liliana Grassi e Piero Portaluppi, per ospitare l’Università Statale. Di questo rapporto tra passato e presente è testimone la Torre Velasca, che riprende una tipologia architettonica ancestrale, quella della torre, inserita nel flusso delle sperimentazioni moderne dei grattacieli.
È necessario indagare questo aspetto della forma ibrida dei corpi architettonici, piuttosto che la conservazione di un’immagine originale ipotetica. L’architettura è un’arte politica, perché più di tutte le altre arti risente del luogo e del tempo. È il prodotto di una società che adatta gli edifici alle proprie esigenze.

Architettura e politica: edifici pubblici, trasformazioni e riuso urbano
AM: Sono cresciuta in una casa con libri e riviste di ogni tipo, come AD, Quattroruote, FMR: non comprendevo i testi, ma mi nutrivo delle immagini. Fin da piccola ho avuto un’inclinazione per le materie artistiche. Volevo studiare in una scuola come la Bauhaus. La facoltà di Architettura si è rivelata un compromesso tra tecnica, teoria e pratica artistica. Grazie agli incontri con fotografi come Guido Guidi, Lewis Baltz, Elger Esser e Armin Linke, ho iniziato a concepire la fotografia come strumento per esplorare lo spazio contemporaneo, l’architettura e il paesaggio.
Più che dagli autori italiani, la mia visione è stata influenzata dai new topographics come Robert Adams, Lewis Baltz, i Becher, Stephen Shore, e da artisti come Ed Ruscha. Uno dei libri più importanti per la mia formazione è stato Learning from Las Vegas di Robert Venturi, in cui la fotografia registra le forme della città senza confini della nuova era moderna.
È stato il cinema, però, a plasmare il mio immaginario. L’unico progetto al quale ho lavorato direttamente legato a un regista è stato Deserto rosso. Come nulla posso sapere della tua fame. Il cinema è stato più un esercizio di formazione visiva, stimolato dalla mia ossessione per quei registi che hanno anteposto l’immagine ai dialoghi: Michelangelo Antonioni, Krzysztof Kieślowski e Yasujirō Ozu. In Fino alla fine del mondo di Wim Wenders c’è questa utopia di utilizzare una macchina per tradurre in immagini gli impulsi cerebrali di una persona non vedente. Il desiderio di trovare uno strumento per sintetizzare le immagini interiori è lo stesso che mi spinge a utilizzare la fotografia per elaborare, nel mio caso, il dato reale.
Allegra Martin
Allegra Martin (1980) vive e lavora a Milano. Nel 2007 si laurea in Architettura con una tesi sul paesaggio veneto, studia fotografia con Guido Guidi, Lewis Baltz e Gerry Johansson. Collabora con Fondazione MAXXI, MiBAC, Unesco, Fondazione Feltrinelli/MAST, ICCD, Linea di Confine, Biennale di Venezia, i2A. Ha esposto in sedi italiane (Triennale, MAXXI, Macro, Biennale di Venezia, Forma, Viasaterna, Linea di Confine) e internazionali (SK Stiftung Köln, Galerie f5.6, IIC Copenaghen, i2A Lugano). È docente presso il Politecnico di Milano e IED Milano.
Gabriele Della Maddalena