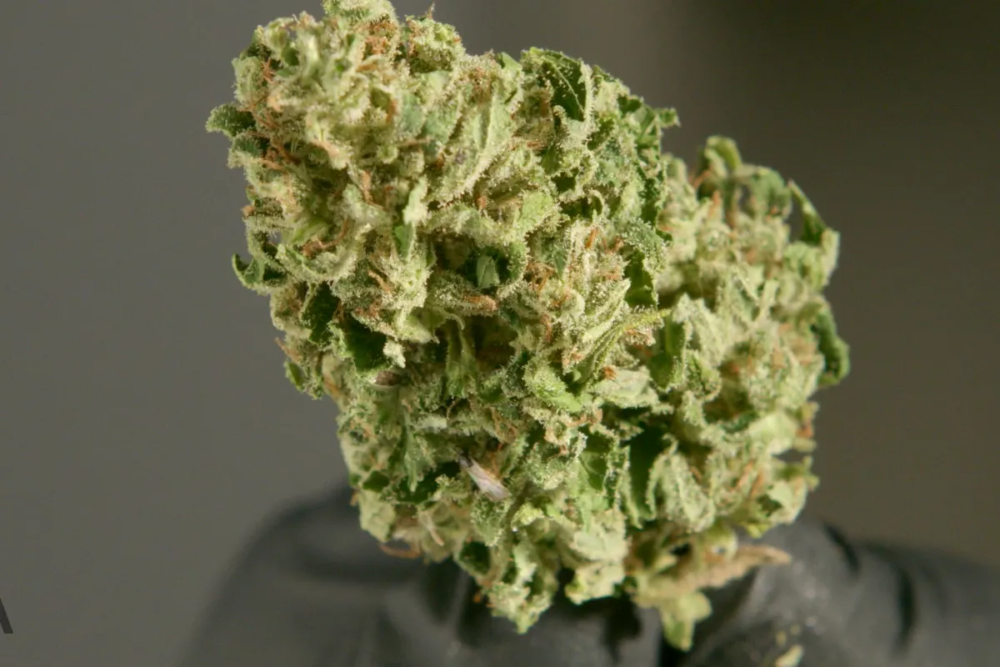Le bocche di porto di Venezia: Lio, Clodia e Malamocco, la laguna che resiste
Matteo de Mayda documenta le bocche di porto della laguna di Venezia, tra infrastrutture dimenticate, pressione turistica, trasformazioni ecologiche e resistenza del paesaggio
Lio, Clodia e Malamocco: immagini liminali di un’altra Venezia
Nebbia, luce piatta, orizzonti scomposti. I paesaggi di Matteo de Mayda si muovono tra mare e laguna, dentro le bocche di porto che collegano e separano Venezia dal suo mare. Il progetto fotografico “Lio, Clodia e Malamocco”, nato da una commissione dell’Università IUAV, è un esercizio di ribaltamento iconografico e spaziale. De Mayda, fotografo e veneziano d’adozione, sceglie di raccontare non la città dei ponti e delle calli, ma quella invisibile e sospesa, quella delle soglie idrauliche e simboliche.
«Ho deciso di muovermi lungo le cosiddette bocche di porto – Lido (Lio), Chioggia (Clodia) e Malamocco. Zone troppo spesso dimenticate ma di grande rilevanza. Si chiamano così perché consistono in tre varchi distinti dove il salato del Mare Adriatico incontra il dolce dei fiumi e dà vita alla tipica acqua salmastra propria dei territori lagunari. Questo aspetto di unione, di mescolanza tra elementi, mi ha sempre affascinato. Non solo da un punto di vista biologico, ma anche e soprattutto simbolico: si tratta di luoghi d’incontro, che permettono l’entrata e l’uscita dalla laguna, in un moto sia di accoglienza che di apertura verso il mare».
Le bocche di porto della laguna di Venezia: funzione idraulica, morfologia e fragilità ecologica
Le bocche di porto della laguna veneta sono tre: Lido-San Nicolò, Malamocco e Chioggia. Costituiscono i principali varchi idraulici che mettono in comunicazione la laguna di Venezia con il Mare Adriatico. La loro origine è naturale, ma sono state modificate sin dall’antichità per fini di navigazione e difesa. Già in epoca romana, il controllo dell’accesso marittimo alla laguna era strategico. In seguito, la Serenissima regolamentò l’assetto attraverso opere ingegneristiche, come le dighe e le barene artificiali, per garantire profondità costante ai canali e proteggere la città dalle maree. Oggi sono punti nevralgici per l’equilibrio idrogeologico della laguna e per il funzionamento del sistema MOSE, che regola l’ingresso delle acque in caso di alta marea.
Ognuna delle tre bocche ha caratteristiche morfologiche e funzioni distinte. La bocca di Lido è la più settentrionale e più vicina al centro storico; qui transitano la maggior parte delle navi passeggeri e da crociera. Malamocco, centrale, è invece la più profonda: accoglie il traffico commerciale e containerizzato, con un canale sottomarino che collega direttamente il porto industriale di Marghera. Chioggia, a sud, è più piccola e prevalentemente utilizzata per la pesca e il traffico locale. In tutte le bocche, l’acqua salmastra si mescola con quella dolce dei fiumi e dei canali interni, generando ambienti dinamici, soggetti a forti correnti, sedimentazioni mobili e continue variazioni chimico-fisiche.







Le bocche di porto sono oggi non solo soglie geografiche, ma zone di tensione tra interessi economici
Questi varchi, oltre a essere funzionali, ospitano un ecosistema complesso e fragile. Le zone di transizione tra mare e laguna sono habitat per diverse specie di uccelli migratori, pesci, molluschi e piante alofile. Nelle aree limitrofe si trovano canneti, barene, praterie di fanerogame marine e fondali sabbiosi, che svolgono un ruolo cruciale nella depurazione naturale dell’acqua e nella difesa contro l’erosione.
Tuttavia, la pressione antropica – portualità, traffico nautico, turismo – e gli interventi infrastrutturali come le dighe foranee e le paratoie mobili, alterano costantemente questi equilibri. Le bocche di porto sono oggi non solo soglie geografiche, ma zone di tensione tra interessi economici, tutela ambientale e trasformazioni climatiche in atto.
La laguna di Venezia nelle fotografie di Matteo de Mayda
Il lavoro si sviluppa attraverso un’immersione diretta nel paesaggio, esplorato a piedi o in bicicletta, con un approccio che si allontana dai protocolli rigidi per abbracciare la spontaneità dell’esperienza personale. Un elemento determinante è il gesto intimo e trasformativo che segna la produzione stessa del progetto.
«Proprio durante la produzione di questo lavoro ho disperso le ceneri di mia madre nella laguna. Questo evento ha necessariamente influenzato il mio stato d’animo e l’approccio allo scatto, caratterizzato da una dimensione intima e profonda».
È una fotografia che nasce quindi da una soglia non solo geografica, ma anche emotiva. Un atto di attraversamento e sedimentazione che si traduce in una grammatica visiva fatta di silenzio, sospensione, luce diffusa. De Mayda cerca volutamente l’assenza di contrasto: privilegia le giornate nuvolose, la foschia, il controluce. Il risultato è una serie di immagini che sembrano sospese nel tempo, fuori dalle coordinate precise di un “oggi”.
«Non amo il sole pieno, diretto. Prediligo le giornate nuvolose, la nebbia e la luce che appiattisce le figure. Mi piace avere ogni elemento sullo stesso piano, con poca profondità di campo. Questo linguaggio specifico gioca sicuramente un ruolo nella resa finale degli scatti, che restituiscono alcune sensazioni piuttosto che altre».
Paesaggi senza tempo: una fotografia non databile
Il progetto rifiuta l’estetica da cartolina e si oppone alla saturazione visiva che da decenni imprigiona l’immagine di Venezia. Come molte città turistiche, il capoluogo veneto è vittima di una sovra-rappresentazione iconografica: ogni scorcio è stato già immortalato milioni di volte, inquadrato sempre allo stesso modo, congelato in una versione estetizzata e commerciale.
«Tra i luoghi più fotografati e rappresentati in assoluto, Venezia gode di una fama planetaria che si basa quasi interamente sulla riproduzione delle stesse situazioni. L’iconografia classica da cartolina, che tende a congelare un luogo in una versione estetizzata ma anche svuotata, incombe da ogni parte».
Fotografare Venezia oggi, dunque, significa misurarsi con un paesaggio saturo, in cui la novità è difficile, ma necessaria. La risposta di de Mayda è una riscrittura silenziosa, che lavora sulla composizione, sulla luce, sulla sottrazione. È una sfida linguistica prima che estetica.
«Come fotografo sono abituato a lavorare sia su progetti personali che commissionati, ed è inevitabile, in particolare nelle commissioni, che talvolta mi debba interfacciare con luoghi iper-inflazionati e conosciutissimi. Ciò che non è facile fare (anche se diventa un’attività stimolante) è dare a tali luoghi una nuova vita, osservandoli da un’altra prospettiva».
Archivi, riferimenti pittorici e stratificazione temporale
L’approccio di de Mayda non si ferma all’osservazione. È un processo che include la storia dell’arte, la memoria culturale e il confronto con l’archivio. Nel tentativo di riformulare scorci iper-noti, il fotografo adotta strategie raffinate, come il dialogo con opere pittoriche del passato.
«Qualche tempo fa, per esempio, dovevo fotografare Campo Santi Giovanni e Paolo, località simbolica della città per il New York Times. Volendomi distaccare da un’immagine scontata, ho pensato a un dipinto di Canaletto – oggi in collezione alla Pinacoteca Agnelli di Torino – che raffigura proprio quello scorcio. Ho calcolato e provato a replicare la sua stessa prospettiva, la sua composizione, come in un dialogo tra passato e presente che fornisse al Campo una lettura inedita».
Questo dialogo con il tempo diventa una costante. Le immagini non raccontano solo un presente, ma aspirano a durare, a entrare in un archivio più vasto. Lo scopo non è la documentazione cronachistica, ma la costruzione di un paesaggio capace di attraversare il tempo.
«Il mio intento, quando scatto, è quello di produrre immagini che possano rimanere sospese nel tempo. Mi piacerebbe che guardandole si potesse pensare che risalgono a trent’anni fa come a oggi, in una ricerca di annullamento della dimensione spazio-temporale».








La natura come protagonista silenziosa
In questa prospettiva, anche la presenza umana è ridimensionata. L’uomo c’è, ma non è il protagonista. Le sue tracce si leggono in secondo piano, nei manufatti, negli oggetti, negli effetti indiretti. È una fotografia post-antropocentrica, in cui la natura riconquista lo spazio narrativo.
«Tendo a rappresentare di rado l’uomo in primo piano: se un paesaggio può risultare posizionato in una porzione di tempo ampia e indefinita, l’individuo rompe l’incantesimo. È inevitabile che la presenza di una persona all’interno di una fotografia generi domande e curiosità nell’osservatore, il quale è spinto a dare una connotazione al momento che è stato immortalato. Preferisco dunque che sia l’elemento naturale a prevalere».
Persino nei ritratti, l’interesse principale non è nel volto, ma nel contesto, nell’habitat, nell’insieme. De Mayda parla dell’uomo attraverso i suoi strumenti: un cantiere, un’imbarcazione, un banco che espone conchiglie. Tracce umane che non dominano, ma coesistono.
«Persino nei ritratti, che costituiscono in ogni caso parte del mio lavoro, cerco di evitare la mera foto di un viso, includendo invece il contesto in cui il soggetto si trova, il suo habitat».
Overtourism, affollamento e sensibilizzazione visiva
La Venezia di de Mayda non ignora il suo presente critico. Il progetto non è una fuga nel lirismo, ma una forma di consapevolezza visiva. La congestione fisica e visiva della città è affrontata anche frontalmente, con fotografie che mostrano code, assembramenti, situazioni di affollamento estremo.
«L’overtourism è senza dubbio una questione centrale. Spesso ho fotografato le code infinite e gli assembramenti, perché ritengo sia giusto sensibilizzare mostrando condizioni fuori controllo che sono all’ordine del giorno».
In questo senso, la fotografia diventa strumento politico e comunicativo. Mostrare è il primo passo per mettere in discussione.
Sinestesia e immediatezza sensoriale
“Lio, Clodia e Malamocco” si distingue anche per una componente sensoriale. Le immagini evocano odori, suoni, temperature. Parlano a tutti i sensi. È una fotografia che non si limita al visibile, ma che lavora per generare atmosfera.
«Gli scenari immortalati in “Lio, Clodia e Malamocco” parlano a tutti i cinque sensi. Evocano suoni, odori, sensazioni che vanno oltre il campo visivo, in un’esperienza quasi sinestetica».
L’assenza di narrazione rigida e la libertà d’azione permessa dal progetto hanno incentivato un processo più istintivo e personale.
«Generalmente mi preparo molto, studio i luoghi e lascio pochi elementi al caso, ma lì, mentre percorrevo a piedi o in bicicletta le bocche di porto, mi sono sentito libero di agire istintivamente seguendo le mie emozioni. In primo luogo perché era un lavoro che permetteva autonomia, in secondo – e più determinante – per il fatto che proprio durante la produzione del progetto ho disperso le ceneri di mia madre nella laguna».
Venezia come arcipelago: un ecosistema fragile da ascoltare
Il progetto si chiude con un invito alla consapevolezza ecologica. Venezia non è solo centro storico, ma un sistema fragile e interconnesso. La laguna è il vero cuore della città, spesso dimenticato o marginalizzato.
«Ho molto a cuore l’identificazione della città con la laguna, perché la rende ciò che è nel profondo. Collaboro anche con associazioni come We Are Here Venice che si occupano proprio di tutelarne e valorizzarne il patrimonio. È necessario spostare l’attenzione dal centro, riconoscere il sistema ambientale complesso che rende Venezia non un’isola, bensì un arcipelago».
Il paesaggio lagunare è un luogo di negoziazione continua, dove le forze naturali e antropiche si scontrano e si intrecciano. Fotografarlo significa riconoscere questa complessità, ascoltarla, restituirla senza semplificazioni.
«Mi interessa la ricerca, il confronto, e osservare come la natura si riappropri di certi spazi, trovando nuovi equilibri soprattutto in contesti industriali. La laguna in particolare è un territorio di negoziazione continua».
Martina Bonetti
Matteo de Mayda – biografia
Matteo de Mayda (1984, Treviso) è un autore visivo con base a Venezia. La sua pratica si concentra su tematiche socio-ambientali e si sviluppa in dialogo con materiali d’archivio e approcci scientifici.