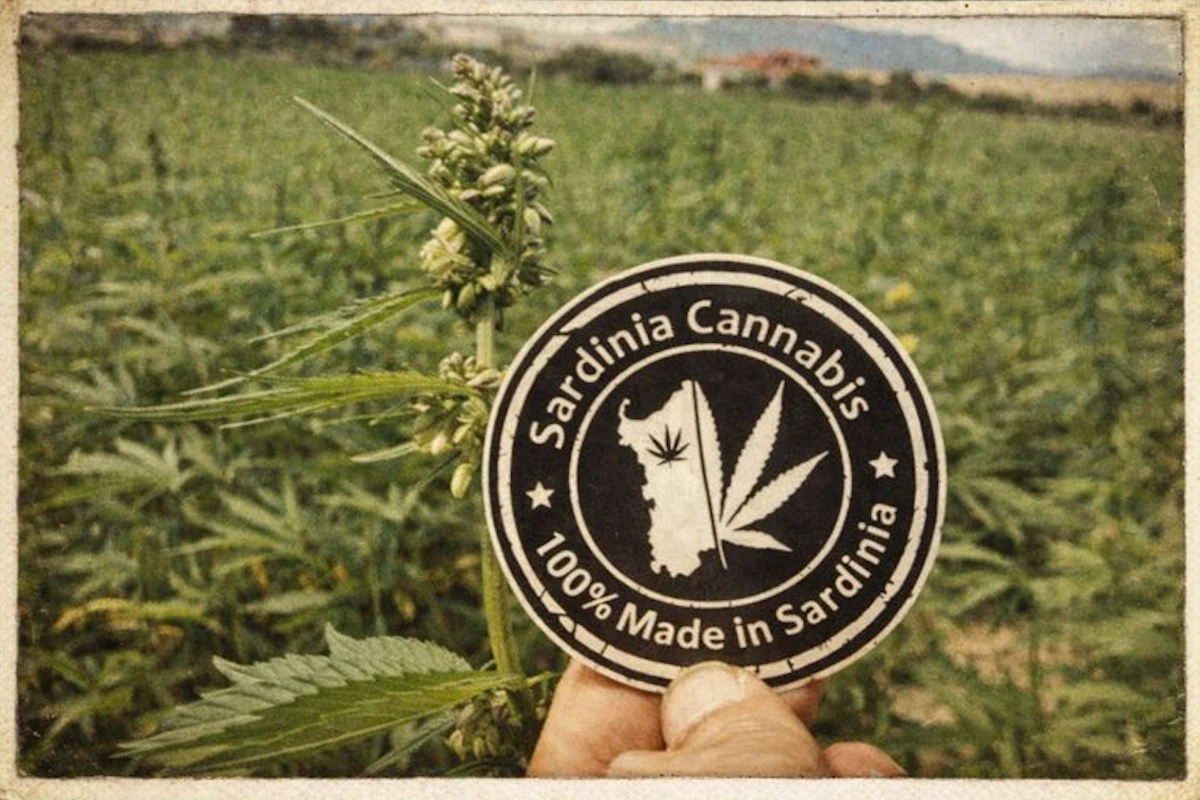Campeggi porta nel giardino di San Pietro in Gessate 24 sedie pieghevoli in tessuto
Non una rassegna cronologica, ma un mosaico di storie: Davide Biancucci racconta Soft Fold, la mostra in collaborazione con Campeggi che esplora la genealogia delle sedie pieghevoli in tessuto. La tela e il telaio come elementi chiave della trasformabilità
Soft Fold di Davide Biancucci in collaborazione con Campeggi a Milano San Pietro in Gessate: la mostra che celebra le sedie pieghevoli in tessuto
Il 2, 3 e 4 ottobre 2025 Campeggi presenta a Milano Soft Fold, una mostra allestita nel giardino della chiesa di San Pietro in Gessate. Il percorso riunisce ventiquattro sedie pieghevoli in tessuto, esposte in modo volutamente non sistematico. L’allestimento porta al centro dell’attenzione una tipologia di arredo che da sempre accompagna spostamenti, riti e momenti di lavoro. La piega diventa dispositivo che consente mobilità, risparmio di spazio e rapidità d’uso: la stessa struttura genera tanto archetipi senza tempo quanto prodotti di massa, unendo pezzi di prestigio e modelli industriali.
La curatela è di Davide Biancucci, designer nato nel 1991 con base a Milano, che concentra la propria ricerca sul rapporto tra tipologie storiche e bisogni contemporanei. Il suo lavoro attraversa oggetti industriali, progetti in edizione limitata e allestimenti, con un approccio essenziale e privo di ridondanze. «La ricerca e l’interesse verso questa tipologia di sedute nasce in modo spontaneo e involontario circa dieci anni fa. Da quel momento, girando per mercatini, negozi o aste di design, ho aggiunto man mano nuovi pezzi alla collezione che ogni volta mi colpivano per aspetti differenti», racconta il designer.
La definizione di folding canvas chair e successivamente il titolo della mostra, Soft Fold, nascono con l’intento di circoscrivere il campo a tutte le sedie pieghevoli che sfruttano la tela come superficie morbida, sostenuta da un telaio rigido che si apre e si chiude. Il sottotitolo esplicita i confini del progetto: “Non chronological, non ordinary, non exhaustive, non alphabetical, non comprehensive”. Non si tratta quindi di un’indagine sistematica, ma di una selezione guidata dall’istinto e da una sensibilità affinata negli anni.

Sedie pieghevoli da toccare e provare: l’esperienza interattiva della mostra Soft Fold di Davide Biancucci
Il pubblico può interagire con le sedute. «Abbiamo pensato fin da subito ad una mostra in cui il visitatore potesse toccare, provare e sedersi sulle varie sedute, a differenza di quello che succede nei musei dove tutto è cristallizzato ed è impossibile toccare qualcosa. Volevamo abbattere la distanza che spesso si crea tra visitatore e oggetto».
«Mi interessava mostrare le sedute nel loro insieme e far vedere come, pur avendo tutte delle soluzioni progettuali e formali differenti perché nate in epoche e contesti diversi, comunque condividono dei punti in comune e si rifanno ad un immaginario chiaro e condiviso. I miei occhi le percepiscono ognuna con una caratteristica che la differenzia dalle altre ma viste globalmente potrebbero appartenere tutte alla stessa famiglia».
Mehari di Campeggi: la nuova sedia pieghevole nata dalla ricerca e dal collezionismo di Davide Biancucci

«Desidero essere circondato da cose che mi piacciono e che catturano la mia attenzione. Le vivo nel quotidiano utilizzandole e provando a comprendere l’essenza della loro bellezza e del perché mi colpiscono. Quando poi mi trovo io a progettare cerco di riversare le stesse sensazioni nell’oggetto che sto disegnando».
Da questo approccio nasce la Mehari, disegnata per Campeggi: «È una sedia che è nata solo perché prima avevo avviato questa ricerca in autonomia e in questi anni ho vissuto utilizzando le sedie presenti in mostra cercando di capirle nella loro vera essenza. Quando poi è nata l’occasione di disegnarne una nuova tutte le riflessioni e le sensazioni che avevo maturato con la ricerca le ho potute condensare nella Mehari».
Campeggi: una breve storia dell’azienda di design e il legame con Vico Magistretti
Campeggi nasce alla fine degli anni Cinquanta in Brianza, un territorio che in quegli anni stava diventando uno dei principali poli produttivi del mobile italiano. La scelta di occuparsi fin dall’inizio di arredi trasformabili – divani letto, poltrone pieghevoli, complementi convertibili – colloca subito l’azienda in un filone preciso: quello della ricerca sulla flessibilità domestica, in sintonia con i mutamenti dell’abitare del dopoguerra.
Claudio Campeggi per decenni ha guidato l’azienda imprimendole un carattere sperimentale e ironico, cercando di fare del mobile trasformabile non solo un prodotto funzionale, ma anche un terreno di progetto capace di stimolare nuove idee. Accanto a lui hanno lavorato altri membri della famiglia, tra cui Marco Campeggi, contribuendo a dare continuità a un percorso iniziato dal padre.
La sede dell’azienda si trova ad Anzano del Parco, in provincia di Como, all’interno di uno stabilimento che unisce spazi produttivi e uffici con un’attenzione architettonica non comune per una realtà manifatturiera. L’edificio stesso riflette la volontà di legare funzionalità e qualità progettuale, come accade nei prodotti.
Un ruolo decisivo hanno avuto i designer che, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, hanno collaborato con l’azienda. Il dialogo con Vico Magistretti è stato rilevante: dal loro incontro nacquero progetti che hanno saputo rileggere la tipologia della sedia e della poltrona pieghevole con intelligenza e precisione formale.
Vico Magistretti: Tanganika, Regina d’Africa, Kenia, Piccy
«Uno dei maestri del design italiano che più ha lavorato sulla tipologia della sedie pieghevole è Vico Magistretti», osserva Biancucci. Il catalogo Campeggi mantiene in produzione alcuni suoi progetti. Architetto e designer milanese, Magistretti ha saputo unire rigore progettuale e leggerezza inventiva, portando nel quotidiano un’idea di design colta ma mai autoreferenziale. La sua capacità di lavorare sulle tipologie tradizionali, reinventandole con soluzioni ingegnose e un’estetica sobria, lo ha reso un protagonista della stagione d’oro del design italiano. In mostra ci sono quattro sedie: Tanganika, Regina d’Africa, Kenia, Piccy.
La Tanganika è una sedia costruita a partire da una logica molto semplice: due cavalletti in legno che sostengono un telo in tessuto teso, formando una seduta smontabile e leggera. Il nome evoca suggestioni africane, in linea con la serie di arredi che Magistretti dedicò a quell’immaginario geografico. La sua forza risiede nell’equilibrio tra l’elemento tecnico — la possibilità di piegare e trasportare la sedia con facilità — e un’estetica diretta, priva di orpelli.
La Regina d’Africa riprende lo stesso linguaggio costruttivo, ma lo declina in chiave più ampia e confortevole. Si tratta di una poltrona che mantiene la logica pieghevole e la seduta in tessuto, ma con dimensioni maggiori e proporzioni che la avvicinano a una lounge chair. È un oggetto che coniuga l’idea di leggerezza con quella di relax, mostrando come Magistretti sapesse tradurre un principio progettuale in varianti capaci di rispondere a bisogni diversi.
La Kenia si presenta come una poltroncina pieghevole compatta e maneggevole. Il sistema di chiusura “a ombrello” consente di richiuderla in pochi gesti, rendendola adatta sia a spazi domestici che a contesti temporanei o dinamici. L’aspetto è essenziale, con linee snelle e un uso calibrato dei materiali, ma dietro la semplicità si nasconde un’attenzione ingegneristica che caratterizza molte delle invenzioni di Magistretti.
La Piccy, infine, occupa un posto speciale nella produzione del designer. Progettata negli anni Quaranta, rappresenta uno dei primi esempi di seduta pieghevole moderna in Italia. Struttura in legno e tela si combinano in una forma compatta che richiama le sedie da campeggio, ma con un’eleganza e una precisione che ne hanno decretato la fortuna critica. Nel tempo è stata riproposta più volte, fino a diventare parte stabile del catalogo Campeggi come testimonianza delle radici del design italiano del dopoguerra.
La Fionda di Jasper Morrison per Mattiazzi e De Pas d’Urbino Lomazzi
La Fionda di Mattiazzi: è una sedia progettata da Jasper Morrison nel 2013 per l’azienda friulana Mattiazzi, specializzata nella lavorazione del legno. «Campeggi e Mattiazzi sono potenzialmente dei competitor ma sono andati oltre la competizione commerciale contribuendo insieme alla riuscita di un lavoro di ricerca tipologica che, fino ad oggi, non era ancora mai stato affrontato».
Il nome richiama la logica costruttiva della sedia: una struttura minimale in legno di frassino che sostiene un telo di tessuto sospeso, facilmente rimovibile e lavabile. L’ispirazione viene da una sedia da campeggio giapponese che Morrison aveva visto anni prima, di cui ha voluto reinterpretare la semplicità funzionale con materiali di alta qualità e una pulizia formale adatta all’arredo contemporaneo.
Il progetto riflette bene la filosofia di Morrison, che definisce il proprio approccio super normal: creare oggetti discreti, funzionali e radicati nell’uso quotidiano, senza ricercare forme iconiche o eccessivamente narrative. La Fionda, infatti, non punta sull’impatto visivo ma sull’essenzialità della struttura, la facilità di smontaggio e la leggerezza. La sedia può essere impilata orizzontalmente una volta rimossa la tela, un dettaglio che la rende pratica e versatile. In questo modo Morrison e Mattiazzi hanno trasformato un modello vernacolare in un oggetto raffinato, capace di dialogare tanto con l’artigianato quanto con la produzione industriale.
«Vorrei citare anche lo studio De Pas d’Urbino Lomazzi che tutti conoscono per i loro pezzi più iconici come il Guantone Joe o l’appendiabiti Sciangai, quando invece anche loro si sono confrontati diverse volte con la tipologia delle pieghevoli. Guardando all’estero possiamo dire che ci sono altri modelli che si inseriscono nel filone del design scandinavo».







Origini storiche delle sedie pieghevoli
La storia delle folding chairs parte da lontano. Nel Medio Regno egizio compaiono i primi sgabelli pieghevoli: il Metropolitan Museum conserva un esemplare con telaio a incrocio, datato tra l’XI e la XIII dinastia. Legno, cuoio e parti metalliche definiscono un arredo leggero e trasportabile, nato da una necessità pratica in contesti di corte e di spedizione.
Nel Nord Europa, l’età del Bronzo restituisce il caso di Guldhøj in Danimarca. La sedia pieghevole, rinvenuta in una tomba a tumulo e datata alla seconda metà del XIV secolo a.C., è descritta dal Museo Nazionale Danese come oggetto di prestigio. Il collegamento tra pieghevolezza e rango sociale emerge in modo netto.
Roma codifica la sella curulis: struttura a X, funzione itinerante, riservata a magistrati e generali. Il carattere mobile riflette un esercizio di potere “sul campo”.
Nel Medioevo e nel Rinascimento compaiono faldistorî e X-chairs. Il Met espone varianti note come Savonarola o Dantesca, in legno con elementi torniti, sedili e schienali in tessile o cuoio. La piega rimane segno di autorità e strumento liturgico.
La tradizione cinese introduce le jiaoyi, sedie pieghevoli documentate tra le dinastie Liao e Song. Fonti curate da Curtis Evarts e cataloghi d’asta le collocano in contesti formali e imperiali.
Dall’Egitto e Roma antica alla Plia di Giancarlo Piretti per Anonima Castelli
Nel XIX secolo si afferma la cultura del deckchair: sui ponti dei piroscafi e sulle spiagge la sedia pieghevole si regola e si stende. In Inghilterra John Thomas Moore brevetta nel 1886 sedie regolabili come la Waverley. La genealogia lega trasporto marittimo, tempo libero e arredo smontabile.
Negli Stati Uniti si registrano brevetti chiave: John Cram deposita una sedia pieghevole nella metà del XIX secolo; nel 1911 Nathaniel Alexander progetta una pieghevole per congregazioni con leggio solidale sul dorso della sedia davanti, pensata per allestimenti rapidi in spazi multiuso.
La director’s chair moderna si standardizza tra 1892 e 1893. Gold Medal Camp Furniture la presenta in occasione della World’s Columbian Exposition di Chicago, e presto diventa legata all’immaginario del cinema del XX secolo.
Dopo la Seconda guerra mondiale l’alluminio e le cinghie in tessuto diffondono le lawn chairs. Nel 1959 Fredric Arnold brevetta la pieghevole con telaio metallico e fasce tessili. Produzioni su larga scala portano la sedia pieghevole nei giardini e negli eventi.
Nel 1967 Giancarlo Piretti, per Anonima Castelli, introduce la Plia. Telaio in acciaio e scocche plastiche: la piega porta a uno spessore ridotto e a densità di stoccaggio elevata. Un’icona del design italiano entra nella vita culturale del Paese.

Materiali delle folding chairs: legno, acciaio, alluminio, polimeri e tessuti tecnici per l’outdoor
Faggio, teak e acacia compaiono nelle tipologie storiche e negli archetipi a X. Il legno consente riparazioni e sostituzioni di parti. L’acciaio offre resistenza e costi contenuti. L’alluminio unisce leggerezza e resistenza alla corrosione.
Polipropilene e polietilene ad alta densità, su telai in acciaio, definiscono lo standard per eventi: peso ridotto, lavabilità, costo unitario basso. L’esposizione a UV e calore degrada i polimeri non stabilizzati e può rilasciare micro e nanoparticelle. Schede tecniche e additivi anti-UV diventano requisito.
Cotone, canvas, reti tecniche: nelle tipologie “regista” e “safari” il telo si sostituisce e si lava. Per l’outdoor i produttori adottano reti come Batyline, con supporti in poliestere rivestiti in PVC e stabilizzanti UV.
Impatto ambientale delle sedie pieghevoli: analisi LCA, riciclo dei materiali, resistenza ai raggi UV e fine vita
Nel comparto arredo gli inventari LCA indicano materiali e processi come quota principale dell’impronta. Uso e trasporto pesano meno. Per una pieghevole la scelta di leghe o polimeri riciclati incide più della logistica. L’alluminio secondario riduce l’energia di oltre nove decimi rispetto al primario, secondo l’International Aluminium Institute. L’acciaio con alto rottame fuso in forni elettrici riduce energia ed emissioni rispetto ai cicli a carbone.
La plastica abbassa i chilogrammi per posto. Raggi UV e calore degradano PP e HDPE non stabilizzati e favoriscono micro e nanoplastiche. I capitolati richiedono additivi e ricette con protezione UV. La piega migliora la resa del trasporto. I report IKEA indicano una tendenza recente, con avvertenze sui confini di calcolo.
Una pieghevole riduce l’impatto quando adotta telaio metallico con alto riciclato, legno certificato e tracciato, polimeri riciclati con protezione UV. Ricambi per teli e piedini, assemblaggi reversibili ed EPD disponibili completano il quadro. Restano criticità su durabilità ai raggi UV dei polimeri, finiture metalliche e smontaggio a fine vita.
Outdoor e cultura del tempo libero: dalle deckchairs sui ponti delle navi alle sedie pieghevoli per spiagge, stadi ed eventi
Le sedie pieghevoli entrano nell’outdoor per una ragione storica. I ponti delle navi richiedevano arredi che si aprono e si ripongono facilmente. Le sdraio e le sedie da ponte passano poi alle spiagge e ai giardini pubblici. La parola deckchair rimane. La praticità decide: pesi contenuti, carichi compatti, montaggio veloce.
I produttori propongono basi e traverse per terreni erbosi. Nei noleggi la pieghevole standardizza spazi effimeri: stadi, manifestazioni, cinema all’aperto. La panca lascia posto a sedie che si numerizzano, si accoppiano, si legano in file. La cultura del tempo libero segna il Novecento: campeggio, spiaggia, cortili. Cultura e comunità si siedono temporaneamente.
Alessia Caliendo