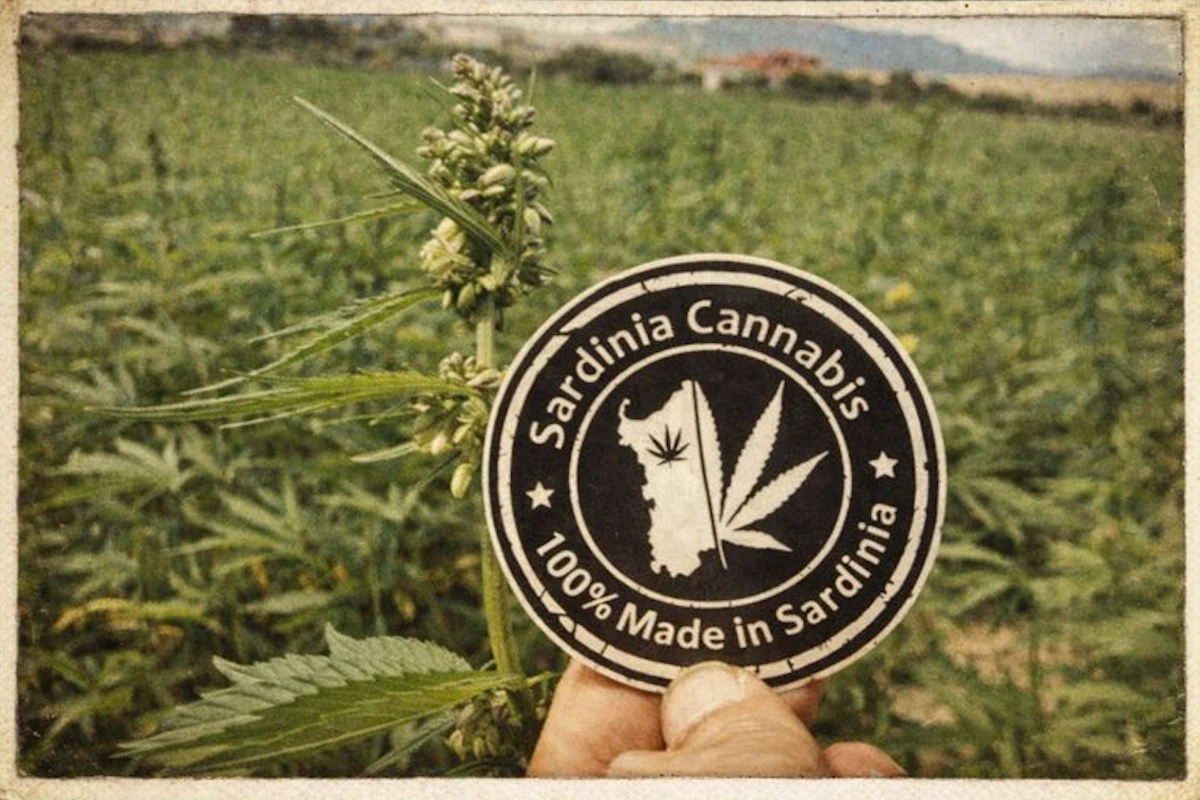L’eredità di Cerere, dea romana che incarna la ruvidità dei frutti della terra
Cerere, antica dea italica della terra e dei raccolti, poi assimilata dai romani al culto greco di Demetra, ritorna attuale con l’omonimo ristorante milanese che celebra la ruvidità delle materie prima
Cerere: una dea ruvida come i frutti della terra
Cerere è tradizionalmente considerata la versione romana di Demetra, dea greca dell’agricoltura. In realtà si tratta di una divinità che unisce culture e tradizioni differenti. Era già presente nel pantheon di popoli italici preromani come gli Osco-umbri. Anche noti come Sabelli, questi erano popoli indoeuropei – probabilmente dello stesso ceppo dei Latini – che abitavano l’Italia continentale nell’antichità.
Di origine indoeuropea è anche il nome Cerere, che deriva dalla radice -ker e significa “colei che ha in sé il principio della crescita”. La sua associazione con Demetra, a partire dal III secolo a.C., si deve alla somiglianza fra i riti con cui le due divinità venivano celebrate.
Cerere era una dea ruvida, come la terra che simboleggiava. Protettrice delle nascite, della fertilità e dei raccolti, era rappresentata come una matrona col capo contornato di spighe e in mano un cesto ricolmo di frutta e grano. Proprio da questa divinità che deriva la parola italiana “cereale”. Un aggettivo con cui nell’antica Roma si definiva il sacerdote preposto al suo culto – il flamine cereale – e le festività indette ad aprile in onore della dea, i Cerealia, adattamento dei misteri eleusini (Eleusi era la città greca sede del santuario di Demetra). Con i Cerealia i romani salutavano l’arrivo della primavera.
Dall’agricoltura alla maternità: una femminilità ruvida
Secondo alcuni miti romani ogni fiore, frutto o essere vivente era un dono gratuito di Cerere, emblema della madre terra, ma anche della maternità in senso lato. Secondo altri, di derivazione greca, fu proprio lei a insegnare agli uomini a coltivare la terra. Cerere incarnava una femminilità ruvida, con un’iconografia caratterizzata da forme abbondanti che alludevano alla gestazione e un’espressione austera come la vita nei campi.
In Grecia Cerere-Demetra era venerata soprattutto dalle donne, tanto che da alcune festività – come le Tesmoforie di Atene – gli uomini erano banditi. A Roma fu eretto nel V secolo a.C. un tempio in suo onore ai piedi del colle Aventino. Lì le venivano offerti in dono frutta, miele e sacrifici di buoi e maiali. Alcune iscrizioni marmoree rinvenute nell’area archeologica di Civitucola attesterebbero la presenza di un tempio dedicato al suo culto anche nella città di Capena, oggi un comune nell’area metropolitana di Roma. Una lamina metallica riportante l’iscrizione “Cerere(m) auliquoquibus” – interpretata come offerta alla dea – è stata ritrovata anche nei pressi dei tredici altari di tufo riemersi nell’area di Lavinium, città latina a sud della capitale.
Nei luoghi sacri a Cerere era anche usanza svolgere pratiche per purificare le abitazioni dopo un lutto familiare. Pur essendo la dea della vita, infatti, Cerere era anche collegata alla morte.
Cerere e Proserpina: l’eterno ciclo della vita e della morte
Secondo la mitologia romana, costruita sulla base di quella greca, Cerere ebbe con Giove una figlia, Proserpina. Mentre raccoglieva fiori sulle rive del lago Pergusa, a Enna, Proserpina fu rapita dallo zio Plutone, che sulla sua biga la condusse negli Inferi e la prese in sposa.
La disperazione di Cerere per la sparizione della figlia si rispecchiò nella natura, che smise di fiorire e dare frutti. Giove chiese, allora, al fratello Plutone di restituire Proserpina alla madre. Il dio degli Inferi accettò, ma prima di rimandare la ragazza in superficie le fece mangiare un chicco di melograno. Una volta condiviso il cibo dei morti, infatti, non era più possibile distaccarsi completamente dall’aldilà. Da allora Proserpina sarebbe vissuta per sei mesi all’anno negli Inferi e per i restanti sei in superficie con la madre. In quei sei mesi la gioia di Cerere era tanta che la terra tornava a essere fertile. Una spiegazione per il ciclo delle stagioni.
La terra che Cerere incarna è, dunque, simbolo di vita e di morte al tempo stesso. Per tre giorni all’anno – il 24 agosto, il 5 ottobre e l’8 novembre – i romani erano soliti scavare una buca nel terreno, chiamata Caereris mundus, per mettere in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti. Una pratica considerata delicata, perché gli Inferi avrebbero potuto attirare a sé i vivi. Pertanto, durante queste giornate venivano sospese le attività pubbliche, i comizi, le battaglie e gli arruolamenti.
Un ulteriore prova del legame di Cerere con i defunti sarebbe, secondo gli studiosi, l’aggettivo “cerritus”: letteralmente “invaso dallo spirito di Cerere”, ovvero posseduto.


Cerere: ruvidità e materie prime naturali nel cuore di Milano
Cerere è anche il nome del ristorante inaugurato a febbraio 2024 a Milano su iniziativa di Giorgia Codato e Mauro Salerno. Situato in via della Moscova, il locale propone una cucina creativa a partire da materie prime naturali: «Per noi Cerere rappresenta le materie prime che provengono dal suolo, dall’ecosistema, ma anche la nostra storia. Pur essendoci essendo cresciuti in posti differenti, abbiamo avuto un’infanzia simile, scandita dal lavoro nell’orto di casa, dai prodotti stagionali della terra e dai ritmi della tradizione contadina», afferma Giorgia.
Ritmi che vogliono reintrodurre nella frenesia metropolitana attraverso la ruvidità degli ingredienti naturali: «La materia prima che noi utilizziamo di solito è ruvida, non è liscia né perfetta. E pensiamo che questo aspetto materico sia ciò che la renda identitaria, con un gusto e un profumo unici e particolari. Pensiamo che più un ingrediente sia ruvido più sia personale e identitario, perché la bellezza la fa proprio l’imperfezione».
Cibo dalla terra: cura per la fragilità umana e l’ambiente
I proprietari di Cerere riassumono la loro filosofia nell’espressione «cibo dalla terra». Un principio che Giorgia, psicologa specializzata in disturbi alimentari, vede come una cura per la fragilità umana: «In un mondo in cui si ricerca la perfezione in maniera sempre più ossessiva, abbiamo deciso di tornare a guardare a terra per dimostrare che il cibo può e deve essere una cosa bella, non fare paura».
Secondo i dati aggiornati a marzo 2024 della Fondazione Umberto Veronesi, sono affette da disturbi del comportamento alimentare oltre cinquantacinque milioni di persone in tutto il mondo, di cui tre milioni in Italia.
Il ritorno alla terra è per Giorgia e Matteo anche sinonimo di sostenibilità. Fra gli arredi e gli oggetti di
design prevalgono elementi vintage e di recupero, dal carattere ruvido: «Le pareti sono in argilla spatolata grezza. Il pavimento in legno è stato recuperato da una villa veneta del milleottocento e ha un aspetto vissuto e imperfetto. Tutto ciò che c’è di cartaceo è riciclato e fatto con albumi e bucce di vinaccia».
Materie prime secondo il principio farm to fork
Per le materie prime da Cerere seguono il principio farm to fork. Prediligono materie prime stagionali da filiera corta e fornitori che operano secondo principi etici: «Il pesce che prendiamo è solo pescato all’amo. Utilizziamo poca carne e lavoriamo solo con allevatori che hanno pochi animali e li fanno pascolare all’aperto».
Diverse materie prime derivano dagli orti delle famiglie dei fondatori. In Veneto quello del padre chef di Giorgia, in Brianza quello del padre di Mauro. Quest’ultimo possiede anche degli uliveti in Cilento, da cui proviene l’olio utilizzato da Cerere. Frutta e verdura vengono dall’orto della proprietà situato fuori Milano. Pane, pasta, conserve e fermentati sono fatti in casa.
La cucina come trasformazione della materia prima
Cerere punta a coniugare la semplicità di ingredienti naturali e stagionali con la creatività di una proposta gourmet: «Quando un ingrediente è di qualità, non necessita di particolari manipolazioni. Delle nostre materie prime cerchiamo di utilizzare tutto. Con gli zuccheri derivanti dagli scarti delle verdure, per esempio, facciamo un fondo che di norma si realizza con la carne. Creare piatti gourmet a partire da materie prime grezze è proprio ciò che più motiva i nostri chef».
Il menù presenta, però, anche contaminazioni con cucine internazionali, frutto della presenza in cucina di Mario Garcia, sous-chef spagnolo che affianca l’executive chef italiano Roberto Cogni. Discorso analogo vale per la carta dei vini: «Crediamo tanto nell’Italia, molto diversificata fra il nord e il sud dal punto di vista sia gastronomico che vinicolo. Tuttavia, vogliamo permettere ai nostri clienti di sperimentare terroir differenti. Un vino comune come il pinot nero, per esempio, presenta due sapori differenti se coltivato in Trentino o in Oregon, pur essendo la vite di partenza la medesima».
Cerere
Cerere è un ristorante milanese che propone ricette gourmet realizzate con materie prime naturali di preferenza da filiera corta e piccoli produttori. Si trova in via della Moscova 24 ed è stato inaugurato a febbraio 2024 su iniziativa di Giorgia Codato – psicologa specializzata in disturbi alimentari – e Mauro Salerno. Il locale, arredato con materiali di recupero e oggetti vintage, dispone di ventiquattro coperti ed è aperto a pranzo e cena con diverse proposte di menù. I piatti cambiano a seconda della stagione per seguire i ritmi della terra.
Debora Vitulano