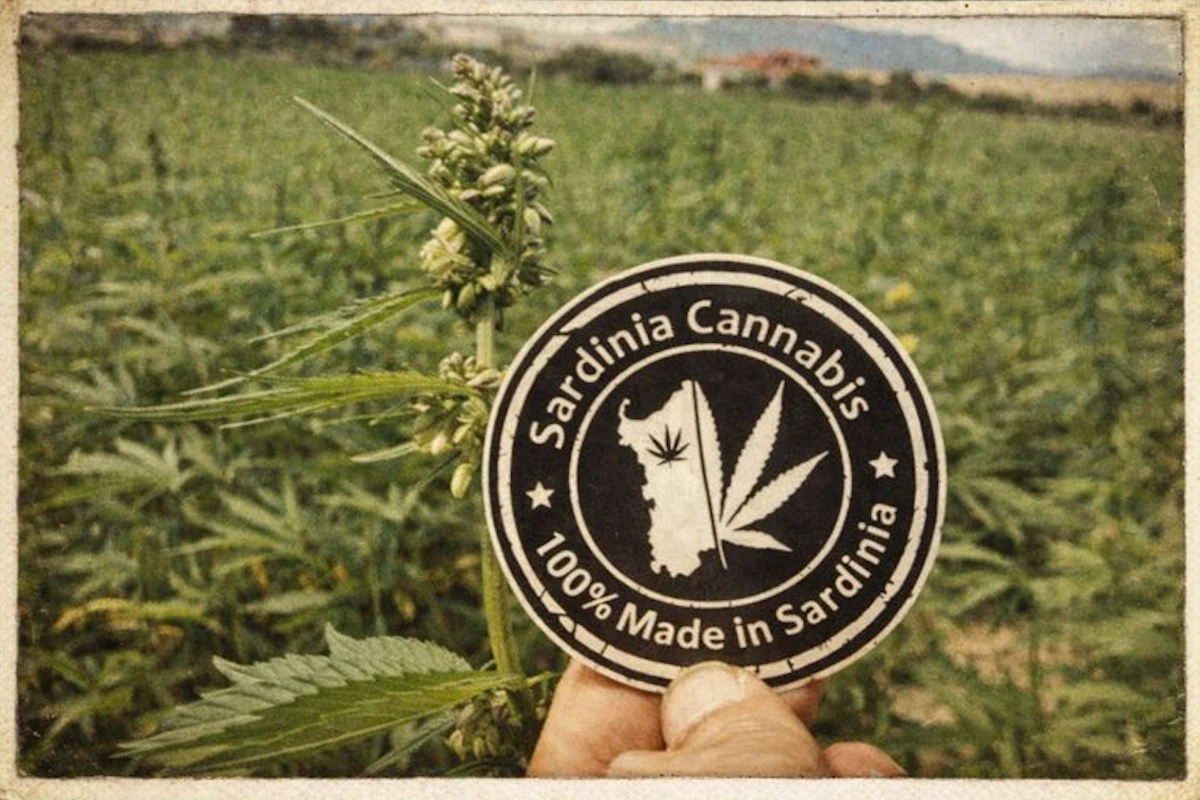“Chinese Espresso”: come i cinesi stanno rivoluzionando i bar italiani
Storie di migrazione, sfide economiche e il ruolo dei bar come spazi di convivialità interculturale – l’antropologa Grazia Ting Deng, autrice del libro Chinese Espresso, racconta la diffusione dei bar gestiti da cinesi in Italia
Lampoon in conversazione con Grazia Ting Deng, autrice di Chinese Espresso: Contested Race and Convivial Space in Contemporary Italy
A Milano, se si entra in una pasticceria in Galleria Vittorio Emanuele II, i clienti verranno sicuramente accolti da una hostess italiana pronta, non solo a servire la brioche, ma anche a regalare un assaggio di dolce vita. Tuttavia, basta andare in un bar nel quartiere queer di Porta Venezia, pagare le bollette in una tabaccheria di zona oppure trovare l’ultimo bar di Milano che, nel 2025, offre ancora uno spritz a cinque euro, per scoprire una realtà più complessa e multietnica.
Nel suo libro del 2024, Chinese Espresso: Contested Race and Convivial Space in Contemporary Italy, l’autrice e antropologa Grazia Ting Deng avvia un’indagine sui bar gestiti da famiglie cinesi, divenuti parte integrante dell’Italia contemporanea. Nel 2014, la sua ricerca l’ha portata a Bologna, dove ha seguito diverse famiglie provenienti dalla Cina che avevano deciso di aprire caffetterie nel cuore della città storica. Nel suo testo, Deng ricostruisce le vicende, le motivazioni e la quotidianità di questi “convivial bricoleurs”: un termine con cui l’autrice descrive affettuosamente gli imprenditori cinesi, in grado di creare e custodire un importante spazio di socialità all’interno dei loro bar.

Tiramisu all’ambasciata: Deng e gli studi di italiano in Cina
Annalise June Kamegawa (AJK): Oggi insegni alla Brandeis University, ma sei cresciuta in Cina e hai portato a termine il dottorato a Hong Kong. Come si scopre anche nel tuo libro, parli fluentemente italiano. Che cosa ti ha inizialmente avvicinata alla lingua e alla cultura italiana?
Grazia Ting Deng (GTD): «Dico sempre che ero molto giovane e curiosa quando ho deciso di specializzarmi in studi italiani. Avevo in mente delle idee e delle fantasie su “l’Occidente”. Così ho scelto di imparare questa lingua straniera insieme al suo universo culturale: calcio, moda, tutti quegli elementi stereotipati.»
AJK: Ma perché scegliere proprio l’italiano invece di un’altra lingua occidentale?
GTD: «A scuola avevo già studiato l’inglese, ma sono cresciuta nella Cina degli anni Novanta, diversa da quella di oggi, e non provenivo da una grande città come Shanghai o Pechino. L’inglese che ho imparato era finalizzato soprattutto agli esami nazionali.
Perché l’italiano? Qui entra in gioco il sistema degli esami nazionali in Cina. Ogni anno si stabiliscono dei piani, e tu hai un certo margine di scelta. Nel mio libro (Chinese Espresso) parlo di “contingenze storiche”. Anche nel mio caso è andata così. Studiare l’italiano è successo in quel momento specifico. Ero una studentessa, un’adolescente che voleva andare in una grande città per il college e aprirsi al mondo. E tutto è iniziato così.»
AJK: Com’erano le tue prime lezioni di italiano all’università? Avevi insegnanti madrelingua?
GTD: «Studiavo a Pechino. In facoltà c’era un’insegnante madrelingua di Roma, mentre tutti gli altri docenti erano cinesi. Si trattava della prima università in Cina a offrire la specializzazione in lingua italiana: un corso nato negli anni Cinquanta. Probabilmente, dal suo inizio, il totale di persone che avevano studiato italiano in Cina a livello accademico si contava ancora in poche centinaia.
Eravamo in pochi, quindi molto uniti. Al primo anno, la nostra insegnante organizzò diverse attività culturali con l’Ambasciata d’Italia in Cina. Fummo invitati all’Ufficio Culturale dell’ambasciata e fu lì che provai il tiramisù per la prima volta!»
Un fisarmonicista e il primo sguardo sul mondo del bar italiano
AJK: A parte il caffè, quale fu lo shock culturale più forte quando visitasti l’Italia per la prima volta?
GTD: «È un ricordo molto bello che non ho mai raccontato prima. Vivevo in un dormitorio nel centro di Trento, vicino al Duomo, al secondo piano di un edificio in un vicolo. Ogni mattina mi svegliavo con due elementi che mi rendevano tutto molto romantico.
Primo: il mio letto era rivolto verso la finestra e da lì potevo vedere il cielo azzurro e le montagne; spesso c’era la neve sulle Alpi. Uno spettacolo meraviglioso.
L’altro aspetto ancora più romantico era la fisarmonica. Ogni mattina, c’era un signore anziano che si metteva all’angolo della strada a suonare. A volte, quando andavo in Duomo o in biblioteca, se avevo qualche spicciolo, glielo davo.
Un giorno, però, mi accorsi che non stava suonando, ma era seduto al bar, come tanti pensionati italiani. Per me fu uno choc, perché nella mia esperienza in Cina andare in caffetteria è un lusso da classe media. Serve una certa disponibilità economica per poterselo permettere. Invece lui, che chiedeva monete suonando per strada, era lì a godersi il bar.
Mi resi conto che in Italia il bar è un luogo per tutti, un elemento culturale centrale: un luogo in cui persone di provenienze diverse condividono momenti della vita quotidiana.»

‘Ganjue’ come metodo di ricerca nei bar gestiti da cinesi
AJK: In Chinese Espresso, descrivi come la tua indagine si sia svolta lavorando dietro il bancone dei bar cinesi, oggetto stesso della tua ricerca. Racconti di quando hai preparato un cappuccino e un cliente abituale ti ha scherzosamente detto: “Sei proprio brava a fare i cappuccini senza schiuma!” e di come Letai ti abbia incoraggiata a esercitarti finché non avessi sviluppato “ganjue (sensibilità)” (Deng, 125-126). Questo approccio ricorda la modalità informale e familiare con cui i segreti del caffè vengono tramandati. Cosa hai trovato di più difficile nel preparare il caffè? E in cosa, invece, ti sentivi particolarmente capace?
GTD: «Fare l’espresso non era complicato, basta seguire i passaggi. Anche a casa, tutti possono provarci. Il cappuccino, invece, mi ha dato qualche grattacapo all’inizio. Non avevo la “ganjue”, non sapevo quando il latte fosse pronto. Fare la latte art era ancora più difficile.»
AJK: Io in Italia non ricevo quasi mai il latte art al bar.
GTD: «Infatti, lo menziono anche nel libro: non è affatto uno standard nei bar italiani tradizionali. Non so se gli italiani ci tengano poco, ma di certo non fa parte di una vecchia tradizione. Più di frequente accade nei bar gestiti da cinesi, dove a volte si dilettano a farlo.»

AJK: Hai avuto un cliente preferito durante la tua ricerca sul campo?
GTD: «Sì, era un uomo che non era solo un cliente, ma anche collaboratore del bar. Prima della pensione faceva il commerciante di vini. La famiglia cinese che gestiva il bar lo conosceva dai tempi in cui gestiva un ristorante cinese.
Quando aprirono il bar, la famiglia non aveva ancora la cittadinanza italiana, quindi decisero di collaborare con lui per registrare la tabaccheria (legalmente separata dal bar). Ufficialmente, il bar era a nome della famiglia, mentre la parte di tabacchi – annessa al bancone – era intestata all’italiano. Non era forse la procedura più ortodossa, ma di fatto lui era sempre presente e gestiva i tabacchi, aiutava con la burocrazia, e soprattutto giocava a carte con i clienti.
Partecipò persino al matrimonio del figlio del proprietario, e ricordo che si commosse. Aveva visto crescere quei ragazzi giorno dopo giorno. Era un rapporto interculturale molto solido, basato sulla fiducia.
Al di là di ciò che mostrano i media, ho visto tanta solidarietà a livello locale, soprattutto tra alcune famiglie immigrate e certi italiani. Esiste questa forma di appoggio reciproco che contrasta il clima di ostilità più ampio che spesso appare a livello nazionale.»
Migrare dalla Cina all’Europa e scegliere “Made in Italy”
AJK: Nel tuo libro citi una barista cinese che racconta come abbia scoperto che “non tutti i laowai [italiani] sono ricchi” e “non tutti sono brave persone”. Molti baristi cinesi che hai intervistato ti hanno parlato di precedenti aspettative positive, un immaginario di un’Europa sviluppata con “solo rispettabili bianchi occidentali”, poi abbandonato una volta entrati nel business dei bar. (Deng, 179). Oltre alla prospettiva di mobilità economica, quali pensi siano le ragioni culturali che portano a scegliere l’Italia?
GTD: «Non credo che questi migranti economici abbiano scelto l’Italia per ammirazione della cultura italiana. A partire dagli anni Ottanta, l’Europa è diventata un’opportunità immaginaria per tanti cinesi della provincia di Zhejiang (nella Cina sud-orientale), che volevano emigrare. Spesso non facevano distinzione fra Italia, Francia o Germania: l’idea era genericamente “Europa”.
Poi, è chiaro, tutto dipende dalle connessioni: se hai parenti o amici a Parigi, vai a Parigi; se li hai in Italia, scegli l’Italia. Molti arrivarono inizialmente senza documenti, sperando di regolarizzare la propria posizione con il tempo.
L’obiettivo era stabilirsi e far venire poi la famiglia, per avviare una piccola attività. E, in effetti, l’Italia offriva diversi percorsi di regolarizzazione ogni tot anni, fino ai primi anni Duemila. Era un paese in cui era più facile ottenere i documenti necessari.
Inoltre, il sistema produttivo del “Made in Italy” è fatto di piccole aziende a conduzione familiare, con molti laboratori artigianali spesso informali. Per molti immigrati cinesi, queste realtà offrivano l’opportunità di trovare lavoro, anche se non ufficialmente dichiarato. Ciò li ha spinti a rimanere qui.»

Chi può permettersi di essere un artigiano? L’artigianalità nella società contemporanea
AJK: Hai parlato dei ruoli mutevoli di artigianalità e manodopera in Italia e di come i migranti contribuiscano a settori come la moda, il design e l’alimentazione. Sappiamo che a volte l’opinione sul valore di un prodotto varia a seconda di chi lo realizza. Nel tuo libro citi Pierre Bourdieu, secondo cui il gusto diventa un’arma sociale per difendere gerarchie, escludendo chi non possiede quel “capitale culturale” (Deng, 115). Come credi che la globalizzazione influenzi il nostro concetto di “artigianale”? L’ascesa della manodopera cinese lo metterà in discussione oppure lo rafforzerà?
GTD: «È una questione complicata. Nell’epoca pre-capitalista, l’artigiano aveva la sua bottega, tramandava le competenze al figlio o all’apprendista. Era una produzione su piccola scala. Oggi esiste ancora, ma in misura ridotta.
Al giorno d’oggi, quando pensiamo a un artigiano, spesso ci viene in mente Armani: un marchio di lusso con una forte retorica del fatto a mano. Ci mostrano le mani che cuciono, le lavorazioni su pelle, un’idea di abilità specializzata ed “elevata”. Ma se guardiamo al passato, l’artigiano poteva essere il fabbro, un lavoro sporco, con scarso prestigio.
Oggi l’artigianalità è spesso un valore promozionale sfruttato dai brand. Non tutti possiedono le risorse o il “capitale culturale” per rivendicare quella narrazione. Chi decide cosa merita di essere tutelato e cosa no? È una forma di performance: come fare e soprattutto mostrare di fare artigianato.
Nel quartiere Monti di Roma, ad esempio, un tempo operaio e pieno di botteghe artigianali, si vede oggi un cambiamento: alcuni vengono riscoperti e “valorizzati”, altri scompaiono o vengono inglobati in processi di gentrificazione. Quindi c’è tutta una gerarchia sulle diverse tipologie di lavoro. E i brand globali con più risorse possono permettersi di esaltare certi aspetti di artigianalità a scapito di altri.»
AJK: Nel tuo libro, accenni anche ai figli di immigrati cinesi nati o cresciuti in Italia che desiderano tornare in Cina, ora che il Paese è economicamente più forte dell’Italia.
GTD: «È vero, alcuni tornano in Cina. È una possibilità che si è aperta, ma non è accessibile a tutti. Chi è cresciuto qui teme di non poter reggere i ritmi di una Cina che cambia troppo velocemente. Ci sono genitori che dicono: “I nostri figli, cresciuti in Italia, non possono competere laggiù, è un mercato troppo competitivo”. Però la Cina resta un richiamo, una “radice immaginata”.
Una differenza recente è che oggi molti ritengono fondamentale saper parlare il mandarino. Sempre più famiglie cinesi in Italia mandano i figli a studiare in Cina, per brevi periodi, scuole estive o addirittura percorsi universitari. È un cambio di prospettiva notevole.
Chi è arrivato da bambino negli anni Ottanta, di solito non aveva modo di ricevere un’istruzione in mandarino. Ora invece quasi tutti i ragazzi di origine cinese in Italia ne sono fluenti.»

Courtesy dell’autrice
“In Italia il caffè è veloce”: il nuovo sguardo di Deng sul bancone
AJK: Ultima domanda: quando vai al bar per un caffè, cosa cerchi in particolare?
GTD: «Guardo prima di tutto la qualità dell’espresso. Ora so che un buon espresso ha la crema in superficie, l’olio. Negli Stati Uniti, invece, noto che i baristi impiegano tantissimo tempo a prepararlo, mentre in Italia sono 30 secondi! Perché impiegarci così tanto?»
Grazia Ting Deng
Grazia Ting Deng insegna antropologia alla Brandeis University. Il suo libro del 2024, Chinese Espresso: Contested Race and Convivial Space in Contemporary Italy, è stato pubblicato da Princeton University Press e selezionato per il Gourmand Book Awards 2024, categoria caffè. Ha lavorato anche come traduttrice tra italiano e cinese, traducendo letteratura contemporanea e libri per l’infanzia.
Le citazioni riportate provengono da “Chinese Espresso: Contested Race and Convivial Space in Contemporary Italy” (Princeton University Press, 2024) di Grazia Ting Deng, riprodotte per gentile concessione della casa editrice.