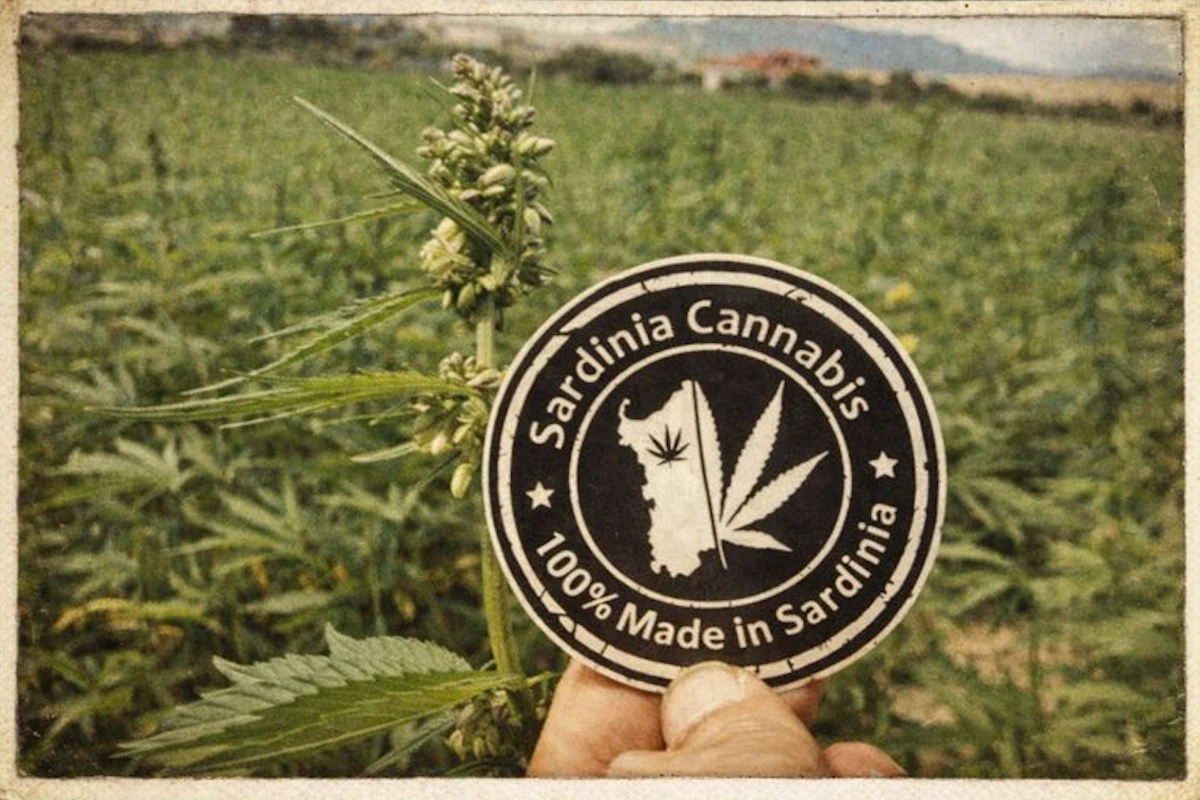Colonialismo, identità nazionali ed ecologia – il design oltre l’uomo dei Formafantasma
Lo studio Formafantasma compie 15 anni – Andrea Trimarchi e Simone Farresin guardano al design sotto diverse angolature: scienziati e umanisti insieme. È questo a fare la loro fortuna
15 anni di Formafantasma – intervista ad Andrea Trimarchi e Simone Farresin
Quindici anni fa nasceva Formafantasma. Poche volte uno studio di design è diventato un caso così in fretta come quello fondato da Andrea Trimarchi e Simone Farresin. Definirli designer e basta non è corretto: progettisti e ricercatori è forse più adatto. Formafantasma, nato in Olanda dopo la fine dei loro studi alla Design Academy di Eindhoven, adesso lavora tra Milano e Rotterdam, indagando – come da manifesto – sulle «forze ecologiche, storiche, politiche e sociali che formano la disciplina del design di oggi».
Trimarchi e Farresin – il primo siciliano e il secondo veneto – hanno fatto quel salto di specie che dalla nicchia del design del prodotto commerciale, pur senza mai abbandonarlo, li ha portati all’intersezione con altre discipline, moda e cultura in senso lato in testa. Sono queer, senza farne la loro unica bandiera. Sono tanto scienziati quanto umanisti: è anche questo a fare la loro fortuna. Non a caso sono tre anni che la Signora Miuccia Prada – che spesso indossano – li ha voluti per organizzare Prada Frames, simposio di discussione su vari temi che si tiene durante il Fuorisalone. Nel 2022 si parlava di design e legname, nel 2023 di scarti, nel 2024 del concetto e del valore degli spazi domestici.
Formafantasma x Flos – SuperWire
All’ultima Design Week di Milano Trimarchi e Farresin erano un po’ ovunque. Con Flos ad esempio hanno presentato SuperWire, sistema di illuminazione a LED ingegnerizzato da zero e pensato per uno dei temi più vicini alla filosofia dello studio: il riuso. «È un lavoro che è durato quattro anni. Il progetto di ingegnerizzazione è stato complicatissimo. Abbiamo disegnato una lampadina modulo esagonale componibile in varie combinazioni. Ogni prodotto ha viti dappertutto, che permettono di togliere l’elemento di vetro e sostituirlo a casa. Qui i tubicini puoi sganciarli e riordinarli. Con i LED di solito questo non succede», spiega Farresin. Trimarchi precisa: «I filamenti che abbiamo utilizzato non si trovano sul mercato. Il progetto è partito da lì, poi si è sviluppa la lampada. La base è stata pensare a una nuova tecnologia. In futuro potrà essere utilizzata da Flos come ditta, magari per altre lampade».


Riciclo, riuso, norme Ue e polemica in Italia – «Abbiamo un governo di imbecilli»
Il riuso in Italia è un tema che continua a tener banco nel dibattito – anche – politico. Il governo si è battuto a lungo contro le nuove norme europee per limitare la diffusione degli imballaggi, ancora da approvare in via definitiva, perché troppo sbilanciate a favore di sistemi di riuso invece che di riciclo: siamo più forti sul secondo che sul primo. L’ultima versione è più morbida delle prime e lascia più spazio al riciclo, ma a Palazzo Chigi c’è sempre maretta. Bruxelles «danneggia le imprese italiane, aumentando burocrazia e costi», ha sintetizzato il vicepremier Matteo Salvini.
Per Farresin «abbiamo un governo di imbecilli». Il lavoro che sta facendo l’Ue, dice, «è creare regole generali poi da implementare nei vari Paesi. Non credo proprio che si danneggi la filiera produttiva. E se siamo nel mezzo di una crisi climatica è inutile pensare alla filiera produttiva per poi morire in altro modo. Tra l’altro innovazione, che sia tecnologica o di altro tipo, è da sempre un volano per l’economia. Penso appunto a quello che è successo con le fonti luminose con l’introduzione dei LED. Credo che serva del tempo per adattarsi ai cambiamenti, ma opporsi è miope e irresponsabile».
Il punto, dice Trimarchi, è che «entrambe le opzioni vanno considerate». A volte è meglio il riciclo, altre il riuso. «Dipende dall’uso che si fa della materia e anche della sua durata. Ci sono ancora molti casi in cui l’usa e getta è l’unica opzione. Lo step dovrebbe essere uso, riuso, riciclo. Buoni esempi ci sono, pensiamo a un caso un po’ diverso, al mondo della moda, con piattaforme come Vestiaire Collective che vanno a lavorare con il riuso». Vero – aggiunge Farresin – «ma ci sarebbe poi da vedere tutto il discorso della distribuzione e della spedizione..».
La figura del designer in Italia e in Olanda
Da subito il lavoro di ricerca e indagine di Formafantasma si è incentrato su questi temi. Oggi se ne discute molto, quando lo studio ha aperto meno. O comunque «solo in parte, in maniera ben diversa», evidenzia Farresin. «Ricordo un corso – dice Tremarchi – all’Accademia di Eindhoven che si chiamava ‘Timeless Necessity’. Per quell’esame avevamo fatto un decalogo di cosa significasse per noi. Poco fa lo abbiamo riguardato e abbiamo notato che quei 10 punti sono un po’ quello che abbiamo fatto con lo studio». Rispetto ai primi anni di formazione in Italia – quelli all’ISIA di Firenze – era la prospettiva a essere diversa. «Qua ci veniva chiesto: come fai a produrre questo oggetto? Come lo disegni? In Olanda era: chi vuoi essere come designer? Quali sono le sfide? E le criticità? Per noi erano tutte di tipo climatico-sociale».
Il design tra colonialismo e pratiche di estrazione
I filoni di indagine che sarebbero arrivati nel tempo erano chiari fin dagli studi. «Il nostro progetto di laurea andava a vedere identità nazionale e immigrazione. Erano anni di grandi sbarchi a Lampedusa», ricorda Trimarchi. Nel 2010, alla Gallery Libbie Sellers di Londra, espongono Moulding Tradition, una serie di ceramiche ispirate dalla tradizione siciliana delle Teste di Moro. La riflessione era: se prima chi veniva dall’Africa aveva contribuito a far grande la cultura dell’Isola, nel tempo era diventato solo un immigrato, un pericolo per la società. L’anno dopo, Colony, una serie di coperte in lana mohair, guardava invece all’influenza coloniale italiana nei principali territori africani passati sotto il controllo di Roma: Libia, Etiopia ed Eritrea.
Più di recente, nel 2020, è partito un progetto che ancora oggi Trimarchi e Farresin citano spesso come summa del loro lavoro. Cambio, commissionata dalle Serpentine Galleries di Londra e poi in mostra al Centro Pecci di Prato, ha esplorato un’altra sfumatura della colonizzazione. Ha scavato nella governance dell’industria del legno attraverso i secoli, analizzando la relazione tra estrazione e produzione. «La pratica di industrializzazione dell’Occidente – dice Farresin – si è sempre basata su pratiche di estrazione coloniale».
«Tutte le discipline che producono qualcosa in qualche modo sono collegate all’estrazione delle risorse. Che è una forma di colonialismo. Noi abbiamo sempre guardato alla relazione tra il dove si produce un oggetto, chi lo produce, qual è il suo impatto, politiche di estrazione e politiche di lavoro. Uno dei pezzi più importanti dentro Cambio era la Economic Botany Collection di Kew Gardens. Economic sta già nel nome. Era uno strumento con cui l’Impero britannico poteva andare a fare estrazioni in Sud America, in India. Una collezione pazzesca di legni rari che venivano poi messi a disposizione dei produttori», spiega Trimarchi. «È ovvio – aggiunge Farresin – che noi progettisti possiamo fare relativamente poco a riguardo. Ma essere consapevoli delle radici della propria cultura è fondamentale per sentirsi responsabili delle scelte che vengono fatte».

Formafantasma – il design oltre l’uomo e il concetto di funzionalità
Un altro capitolo di ricerca dello studio getta lo sguardo ancora più in là. «Il design non può occuparsi solo dell’uomo» è uno dei concetti che più sta plasmando la ricerca di Formafantasma. Nel breve termine, lo sbocco pratico sembra ovvio: scegliere e utilizzare materiali in modo che l’ecosistema ne risenta il meno possibile. Ma cosa significa nel medio-lungo periodo?
«La questione è elementare in linea di principio, ma molto complessa da implementare nel quotidiano. Parlando di ecologia, è ormai consapevolezza profonda che la vita sul pianeta dipenda dalle coabitazioni di specie diverse. La visione che il design ruoti – o debba farlo – solo intorno all’uomo è miope. È chiaro che da esseri umani la nostra prospettiva è antropocentrica, ma per la sopravvivenza abbiamo bisogno di vedere come la nostra specie si relaziona con altre. Intanto si può pensare a progetti di rewilding», dice Farresin. Trimarchi cita quando detto dalla critica di architettura Beatriz Colomina, ospite dell’ultimo ciclo di Prada Frames: «La casa durante il Modernismo è stata pensata come un modo per isolare l’uomo da un ambiente naturale percepito come pericoloso, per ‘sigillarlo’. Solo che questo ha creato problemi di tipo igienico-batterico. Diciamo che è un percorso molto lungo, riguarda la filosofia e il ruolo dell’uomo nel mondo, ma non possiamo certo continuare a tenere in conto solo il nostro punto di vista».
Questo ci allontana dall’idea del design solo come disciplina immolata alla funzionalità? Sì e no, secondo Farresin: «La funzione è essenziale. Il vero punto è chiedersi cosa significa. Pensiamo a quando si arreda casa o ci si veste la mattina. Non è che si consideri solo la funzione in sé dei vestiti. Ci sono questioni legate all’autorappresentazione, alla cura di se stessi, all’amore verso le persone che ci circondano. La funzione è preponderante. Solo che non va interpretata in modo banalizzante come è stato fatto per un sacco di tempo».
Accessibilità e rappresentazione culturale nel design
Altri elementi di criticità che colpiscono ancora il design sono quelli delle barriere all’ingresso che ne ostacolano l’accessibilità, a partire dalla formazione, e dell’apertura a culture diverse dall’Occidente. Discorsi che si legano. Farresin: «È vero che adesso in Italia tutto quello che è pubblico sta andando a puttane, ma ricordiamoci che perlomeno l’Unione europea ci ha permesso di studiare dove vogliamo a un prezzo decisamente accessibile. Noi veniamo da famiglie molto umili e abbiamo avuto questa possibilità grazie all’istruzione pubblica, sia in Italia che in Olanda. Altrove non succede».
E soprattutto nel design questo si nota. Se all’ultima Biennale la presenza di una nuova generazione di artisti, architetti e produttori dall’Africa e da Paesi lontano dal West, al Fuorisalone era quasi tutto in mano a Europa e Stati Uniti (insieme a Giappone, Corea del Sud e Brasile). Da un lato c’è una carenza insita nel sistema: «La domanda è anche come la Fiera, le aziende, le istituzioni possono aiutare a creare accessibilità. Dipende se questo progetto totale come la settimana del Design – un evento carissimo – vuole maturare e diventare culturale oltre che economico», dice Farresin. Dall’altro c’è un problema di prospettiva. «Il design a oggi è una disciplina ancora molto vecchia. Per fare un esempio: la diversità nella moda è qualcosa di intrinseco, nel design ancora manca».
Formafantasma
Simone Farresin (1980) e Andrea Trimarchi (1983) sono i fondatori di Formafantasma. Lo studio lavora tra prodotto commerciale e progetti di indagine sulle sfumature sociali, storiche, politiche, sociali ed ecologiche del design. Hanno insegnato alla scuola di Design MADE in Sicilia e alla Design Academy di Eindhoven per il master di GEO-Design.
Giacomo Cadeddu