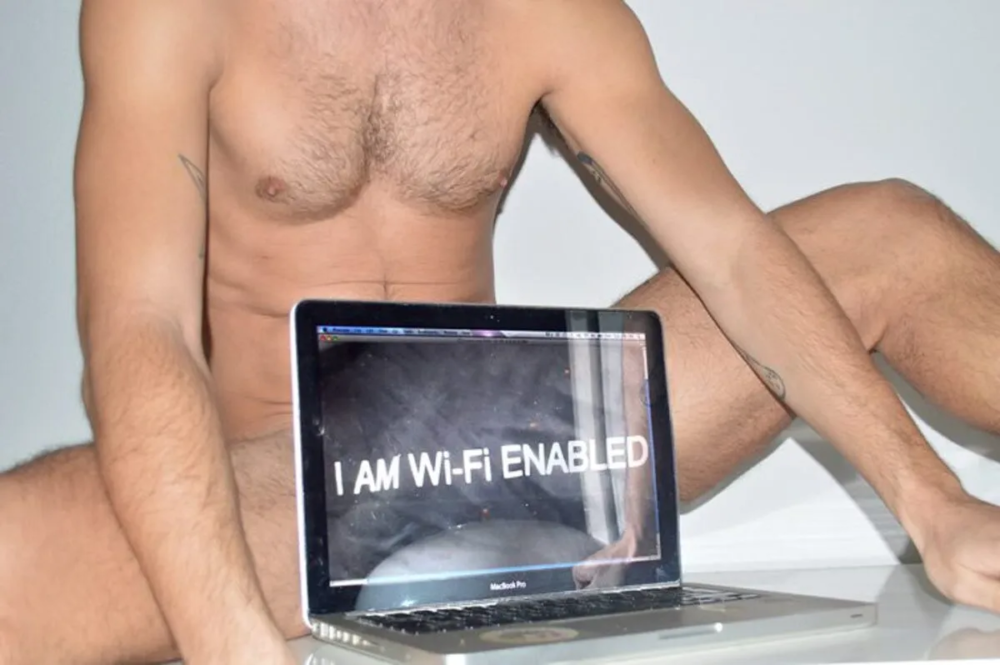Galerie Philia al Giardino Corsini con Future Relics – nuovi esiti dell’eredità medicea
Designer contemporanei indagano gli archivi rinascimentali fiorentini, reinterpretando simboli e tecniche medicee per dar vita a “reliquie” destinate al futuro – Future Relics
Future Relics al Giardino Corsini al Prato, Firenze, fino al 21 novembre 2024
Il giardino Corsini al Prato è un locus amoenus nel centro di Firenze. Concepito per isolarsi dal contesto urbano, offre uno spazio di quiete e riservatezza all’interno di un palazzo risalente alla fine del Cinquecento, progettato da Bernardo Buontalenti e ampliato nel corso del Seicento. Come in ogni giardino all’italiana, le aiuole geometriche, i viali simmetrici e le statue introducono un senso di ordine e di controllo della natura. Tra gli alberi e le piante secolari si trovano gli agrumi, che durante i mesi invernali sono ospitati nella Limonaia.
Racchiuso da mura e strutturato con geometrie, il giardino richiama la tradizione medievale dell’hortus conclusus – un luogo di rifugio, meditazione e purezza. Uno scrigno che protegge le bellezze al suo interno, come una teca protegge la reliquia. Non è un caso che Galerie Philia abbia scelto Palazzo Corsini al Prato per presentare la mostra Future Relics, a cura di Ygaël Attali (curator & co-founder of Philia) e Jemma Elliott–Israelson, visitabile fino al 21 novembre.
La limonaia di Palazzo Corsini, con le sue travi in legno e le ampie vetrate che consentono alla luce di filtrare teatralmente, è la scenografia per le opere di sei designer internazionali chiamati a creare opere ispirate al patrimonio culturale della Firenze dei Medici. In collaborazione con Shifting Vision e con ricercatori e accademici specializzati nei tesori medicei, i designer hanno esplorato gli archivi della Firenze rinascimentale per indagare il concetto di “reliquia futura”.

La definizione di reliquia – e l’ossimoro della “Reliquia del futuro”
Una reliquia è un oggetto conservato e venerato per il suo legame con il passato, spesso associato a figure religiose. Resti fisici di santi o oggetti a essi collegati, come frammenti di ossa, indumenti o oggetti personali, considerati sacri e dotati di poteri spirituali. Oltre al significato religioso, una reliquia può essere qualsiasi oggetto o artefatto che rappresenta e preserva il valore simbolico e la memoria di un’epoca, un luogo o una cultura. Un oggetto che porta con sé il peso del passato, un collegamento tangibile a tradizioni, usi o conoscenze che potrebbero andare perdute.
Future Relics è un ossimoro che esplora la possibilità di creare “reliquie” per un tempo ancora da venire. Ogni designer, attingendo a tecniche e ispirazioni diverse, ha creato pezzi che reinterpretano l’eredità medicea, fondendo l’arte con la funzione per formare una categoria unica di design da collezione. Il progetto invita a immaginare come gli oggetti di oggi potrebbero risuonare come “reliquie” del futuro, combinando il funzionale e l’artistico in modi che potrebbero essere apprezzati per generazioni. Non si tratta di semplici opere d’arte: sono progetti da collezione con uno scopo, creati per essere apprezzati e utilizzati, forse per diventare i preziosi manufatti di domani.
I sei designer selezionati da Galerie Philia: Andrés Monnier, Elsa Foulon, Kar Studio, Laura Pasquino, Morghen Studio e Pierre de Valck
Fondendo tradizione artigianale e approccio sperimentale, Morghen Studio (il duo milanese formato da Rodolfo Viola e Roberto Tarter, specializzato nell’illuminazione) presenta un’interpretazione moderna della colonna autoportante, un elemento chiave adottato dal Rinascimento fiorentino dall’antichità classica. L’installazione contiene riferimenti alla Porta del Paradiso di Ghiberti, alla Pietà di Michelangelo (sia finita che incompiuta) e al Tondo Doni, riflettendo la passione dei Medici per i mosaici in pietra dura.

Kar Studio, proveniente dalla Cina, ha concepito una sedia ispirata al trono di Cosimo de’ Medici. Incorporando modellazione in argilla impastata a mano e fibra di vetro, la sedia presenta quattro pietre di giada cinesi agli angoli della base, richiamando i quattro elementi classici – Terra, Acqua, Aria e Fuoco – presenti sia nell’iconografia rinascimentale sia nella filosofia cinese, che include anche il metallo come quinto elemento.

La ceramista Laura Pasquino, basata ad Amsterdam, ha proposto una serie di opere scultoree influenzate dalla formula della porcellana medicea, rintracciata negli archivi che documentano il laboratorio ceramico di Francesco I de’ Medici negli anni Sessanta del Cinquecento, concepito per imitare la porcellana cinese.

Pierre de Valck si è ispirato a un baule mediceo scoperto al Palazzo Pitti per creare una cassetta nuziale in bronzo patinato con una serratura in roccia meteorica. Quest’opera rimanda ai doni scambiati in occasioni sociali significative durante il periodo mediceo, evidenziando come questi oggetti rafforzassero i legami sociali e le alleanze interculturali dell’epoca.

La ceramista francese Elsa Foulon presenta “Reliquia del Futuro,” un armadio scultoreo laccato, realizzato con legno e porte in ceramica intarsiate con pepite di pirite, ispirato ai reliquiari del Rinascimento italiano. Quest’opera esplora il concetto di reliquia e le prospettive contemporanee su ciò che scegliamo di proteggere oggi.

Quali erano le “reliquie” dei Medici? Il Tesoro dei Granduchi
Si può comprendere l’ampiezza e la diversità del patrimonio mediceo visitando il Tesoro dei Granduchi, situato al piano terra e al mezzanino di Palazzo Pitti. Qui, negli spazi dell’Appartamento d’estate della famiglia de’ Medici, affrescati per celebrare il matrimonio tra Ferdinando II de’ Medici e Vittoria della Rovere, si possono ammirare gioielli, vasi, piatti e altri oggetti d’arredo in oro, argento, pietre preziose, pietre dure, avorio e ambra.
Tra gli oggetti che raccontano la storia della corte medicea spiccano i vasi di Lorenzo il Magnifico e le creazioni manieriste della fine del Sedicesimo secolo. Non mancano i gioielli cinquecenteschi appartenuti ad Anna Maria Luisa, l’ultima erede dei Medici, cammei antichi e rinascimentali, e il celebre “Tesoro di Salisburgo”, portato a Firenze nel 1815 da Ferdinando III di Lorena.
La collezione del museo si arricchisce di gioielli realizzati tra il XVII e il XX secolo da manifatture europee e italiane. Tra le opere esposte, spicca una raccolta di porcellane orientali e maioliche europee, tutte influenzate da modelli asiatici, che si uniscono alla celebre collezione di porcellane cinesi e giapponesi avviata dai Medici nel XV secolo.
La ricchezza dei Medici
Nel 1469, con la morte del padre, Lorenzo de’ Medici si trovò in possesso di un’eredità valutata a 237.988 fiorini. A quel tempo, un lavoratore guadagnava tra i 10 e i 20 fiorini all’anno, mentre una famiglia benestante viveva dignitosamente con circa 150-200 fiorini annuali. Questa ricchezza collocava i Medici tra le famiglie più influenti d’Europa.
Cosimo spese generosamente per erigere palazzi, ville, chiese e monasteri. Piero si dedicò alla raccolta di manoscritti, gemme, gioielli e oggetti preziosi, registrando ciascun pezzo con la sua valutazione nell’inventario che compilò nel 1465. Lorenzo perpetuò la tradizione familiare, dedicandosi a diversi interessi e investendo somme considerevoli in progetti edilizi.
Tutti i Medici, da Cosimo a Lorenzo, assunsero pittori, scultori, muratori, architetti, fabbri, orafi e copisti, mentre si cimentavano nel fare regali – come cavalli, gioielli e altri beni di lusso – a figure potenti come il Re di Napoli e il Duca di Milano. Ogni membro della famiglia, uomini e donne, giovani e anziani, offriva il proprio sostegno, sia attraverso atti di carità che con piccoli sussidi, ai bisognosi, ai clienti, ai seguaci e agli ammiratori, a vario titolo.
Il modello organizzativo del banco Medici
La prosperità della famiglia derivava principalmente dalla banca fondata nel 1397 da Giovanni di Bicci, che si espanse rapidamente in tutta Europa, diventando una delle principali istituzioni finanziarie del continente. Le abilità strategiche di Giovanni e di suo figlio Cosimo, come la scelta oculata dei collaboratori e la creazione di relazioni influenti, in particolare con la Curia romana, furono fondamentali per il successo della banca. Sotto la gestione di Cosimo, la banca generò enormi profitti, in gran parte grazie ai servizi offerti al Papato, che costituivano fino al 63% degli introiti.
Ogni filiale operava come un’entità indipendente, limitando i rischi finanziari. Questa struttura conferiva alla banca flessibilità e resilienza, distinguendola da altre organizzazioni concorrenti, come quelle dei Bardi e dei Peruzzi, che fallirono a causa dell’insolvenza di un singolo cliente. Con uffici disseminati in tutta Europa, i Medici ampliavano le loro attività non solo nel settore del credito, ma anche nel commercio di beni come lana, spezie e allume.
Dopo la morte di Cosimo nel 1464, la banca cominciò a mostrare segni di difficoltà, in particolare a causa di prestiti non restituiti da nobili inglesi e problemi di gestione nelle filiali di Londra e Bruges. La situazione peggiorò ulteriormente sotto la direzione di Lorenzo, portando a una lenta decadenza di quella che era stata una delle più potenti istituzioni finanziarie del Rinascimento.
L’influenza globale dei Medici
Il potere dei Medici tuttavia non si limitava al controllo politico e finanziario della città: si estendeva su scala internazionale, in gran parte grazie ai legami matrimoniali, alle collaborazioni economiche e al sostegno di progetti culturali che seppero alimentare in vari paesi. Attraverso matrimoni strategici, i Medici cementarono rapporti con alcune delle dinastie d’Europa.
Caterina de’ Medici andò in sposa al futuro re di Francia, Enrico II. Questo matrimonio non solo fece di Caterina la regina di Francia, ma rafforzò l’influenza fiorentina alla corte francese. La sua posizione permise di introdurre in Francia elementi della cultura italiana, come nuove ricette culinarie e innovazioni nella moda, influenzando così il gusto e gli usi della corte parigina. Da regina e poi da reggente, Caterina sfruttò le proprie origini medicee per promuovere il mecenatismo e per assicurarsi sostegno politico nelle delicate questioni interne francesi.
Maria de’ Medici sposò invece Enrico IV di Francia. Anche grazie a lei, l’influenza medicea si consolidò ulteriormente in Francia, creando un clima favorevole per l’arrivo di artisti e architetti italiani alla corte francese. Maria portò con sé uno stile di vita raffinato e uno spirito di mecenatismo che rafforzarono i legami culturali tra i due paesi.
Oltre alle alleanze matrimoniali, i Medici costruirono relazioni diplomatiche attraverso doni preziosi e gesti di generosità che contribuirono a rafforzare la loro reputazione internazionale. Cosimo I de’ Medici inviò regali sontuosi al sultano dell’Impero Ottomano, come tappeti, stoffe pregiate e opere d’arte, nel tentativo di mantenere buone relazioni commerciali con il mondo islamico. Questi doni non erano solo simboli di amicizia, ma rappresentavano anche un mezzo per assicurare alle navi fiorentine il libero accesso ai porti del Mediterraneo orientale, fondamentale per il commercio e la prosperità economica di Firenze.
Simili regali di valore artistico e culturale furono inviati anche alla corte papale e ad altre dinastie italiane ed europee. Le opere d’arte, i libri e le collezioni di oggetti esotici erano parte di una strategia sottile con cui i Medici si presentavano come patroni delle arti e della conoscenza, consolidando così il loro status di famiglia illuminata e benestante agli occhi delle altre potenze europee.

Philia: un crocevia di design contemporaneo e arte moderna
Dal 2015, Philia ha trovato la sua voce nel panorama internazionale del design contemporaneo e dell’arte moderna, rappresentando una nuova generazione di designer e artisti, sia emergenti che affermati. Fondata da due fratelli animati da una passione profonda per l’arte, la letteratura e la filosofia, la galleria si distingue per un approccio rizomatico e transculturale, che combina elementi provenienti da diverse tradizioni in un mosaico di creazioni uniche.
La selezione delle opere non segue le mode passeggere; al contrario, Philia abbraccia un curatela non gerarchica che mette in primo piano la qualità estetica. Ogni pezzo esposto non è solo un oggetto, ma una storia che trascende il tempo e lo spazio, catturando l’essenza dell’artigianato e dell’innovazione. Dalla sedia minimalista a sculture organiche, la galleria non si limita a uno stile specifico, ma celebra la diversità del design.
Scoprire e promuovere nuovi talenti è un obiettivo centrale per Philia, che offre a designer come Elsa Foulon (Francia), Andres Monnier (Messico) e Pierre de Valck (Belgio) piattaforme internazionali per presentare le loro opere. Questa galleria non si ferma alla scoperta di volti nuovi; lavora anche con nomi affermati come Cristián Mohaded (Argentina) e Rick Owens (USA), contribuendo a definire la nuova generazione di design collezionabile del XXI secolo.
Con gallerie a Ginevra, New York, Singapore e Città del Messico, Philia vanta una presenza internazionale significativa. Oltre ai suoi spazi permanenti, la galleria è nota per le esposizioni temporanee di gruppo che mettono in luce l’innovazione e la creatività del panorama artistico contemporaneo.