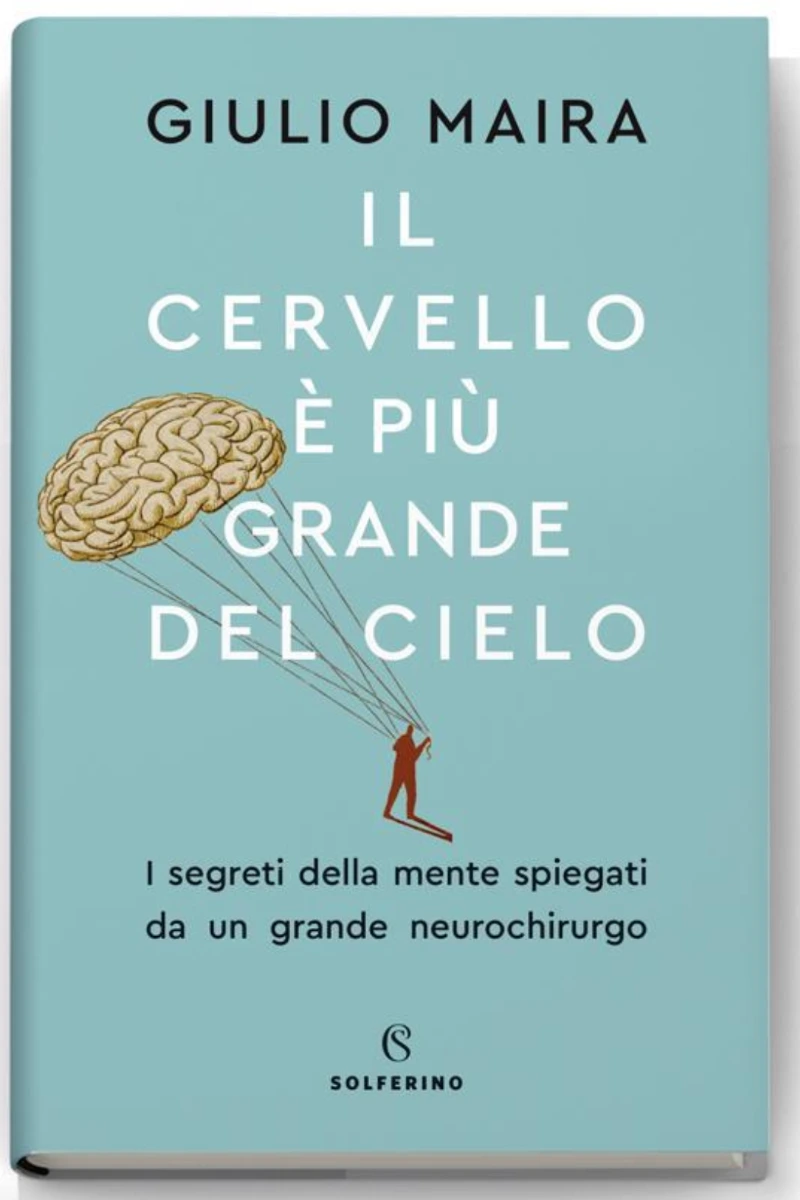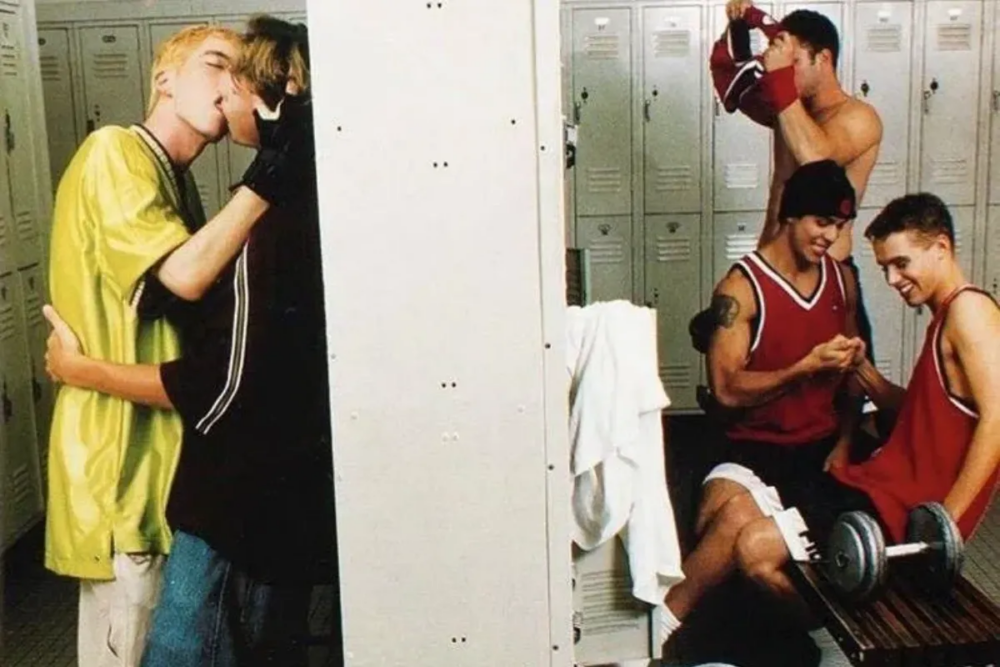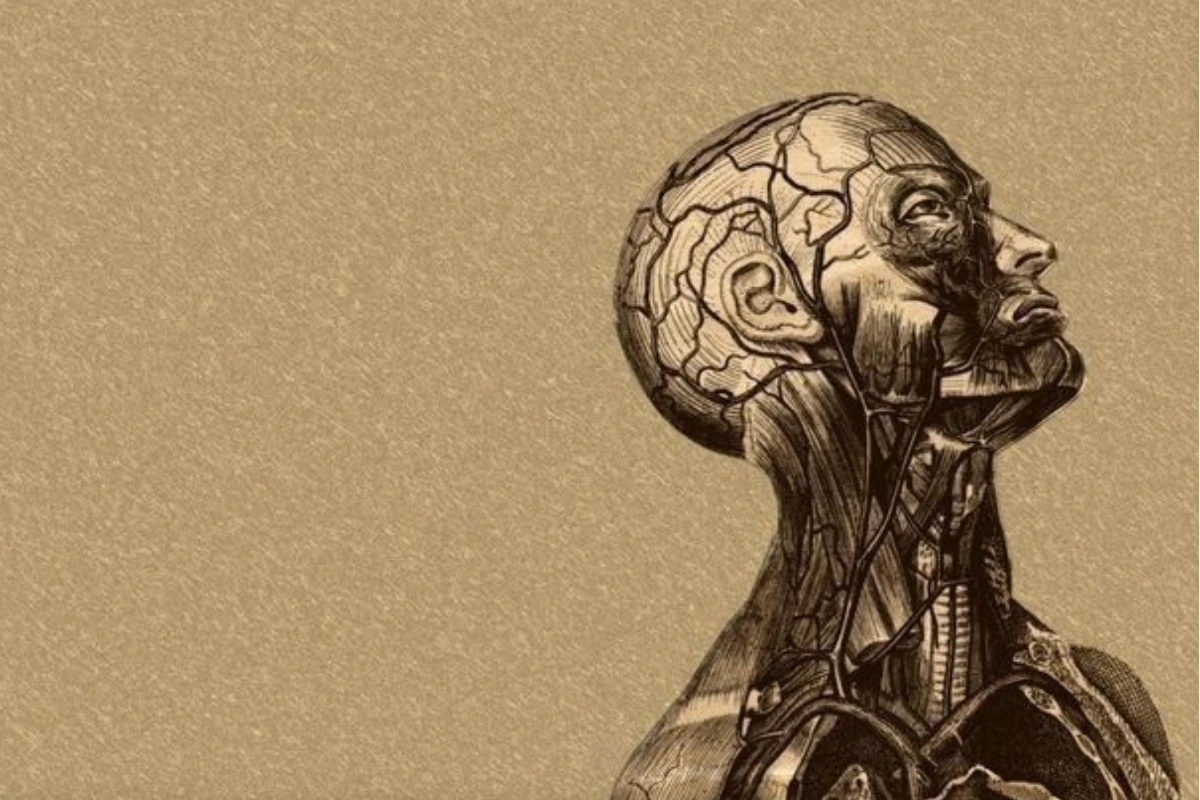
Il limite come risorsa: Giulio Maira sul futuro tra mente umana e algoritmi
Tra neuroplasticità, memoria ed emozione, l’intelligenza umana resta un territorio non replicabile: così il cervello diventa l’ultimo archivio vivente e creativo
Nella conversazione con Giulio Maira, architettura e neuroscienza si intrecciano per immaginare città e menti capaci di evolvere in armonia
Nella mente, come nelle città, nulla resta fermo. Le connessioni si formano, si spezzano, si riorganizzano. Anche il cervello, come l’architettura, è un sistema vivente, capace di adattarsi, archiviare, ricostruirsi.
È da questa immagine condivisa che nasce il dialogo tra il neurochirurgo Giulio Maira e l’architetto Carlo Ratti, pubblicato nel secondo numero della rivista della Biennale di Venezia, La forma del caos. Un confronto voluto dal presidente Pietrangelo Buttafuoco, per riflettere su cosa possa essere oggi un archivio ideale, tra biologia e digitale.
«Scienza e architettura sembrano mondi distanti, ma condividono una finalità comune: creare benessere», spiega Maira. «Prevenire le malattie significa creare condizioni di benessere non solo fisico, ma anche sociale e civile. In questo senso, il lavoro di un neuroscienziato e quello di un architetto si avvicinano.»
«Le città sono una forma di archivio vivente», continua. «È possibile immaginare una convergenza tra archivio biologico e archivio digitale? È una domanda che tocca la nostra vita quotidiana, perché biologia e digitale sono ormai fondamentali nella progettazione delle città.»
L’errore come motore della conoscenza: la differenza tra intelligenza umana e artificiale
Nel dibattito sull’intelligenza artificiale, si tende a contrapporre la razionalità delle macchine all’imprevedibilità dell’intelligenza umana. Ma, secondo Giulio Maira, è proprio l’errore – e la capacità di gestirlo – a rappresentare un valore essenziale.
«La ricerca è costruita sull’errore, sull’adattamento, sull’esplorazione di territori ignoti. La macchina procede per logica, cerca il percorso più efficiente. L’essere umano, invece, sa riconoscere l’errore, sa tornare indietro, ha coscienza di sé e di ciò che fa. E questo fa la differenza.»
Lentezza, intuizione e coscienza: il pensiero umano come risorsa rigenerativa
La velocità di calcolo è spesso vista come il vantaggio principale delle macchine. Ma per Maira, il vero valore sta nel limite umano, nella lentezza, nell’intuizione.
«Non possiamo competere con la rapidità dell’IA. Se cerchiamo di sincronizzare il nostro pensiero con quella velocità, rischiamo un cortocircuito. Non si tratta di opporre intelligenze, ma di capire come possano lavorare insieme.»
Cita il caso di AlphaGo, il sistema creato per il gioco strategico del Go: «AlphaGo ha battuto i campioni umani grazie alla sua potenza di calcolo. Ma è stato l’ingegno umano a concepirlo e a intuire che quelle logiche potevano essere applicate altrove. Così è nato AlphaFold, che oggi aiuta a prevedere il ripiegamento delle proteine: un passo cruciale per comprendere la struttura della vita.»
Educare alla comprensione profonda: l’intelligenza non è solo accesso ai dati
Il punto non è l’accesso all’informazione, ma la qualità della comprensione e la formazione del pensiero critico. L’educazione, secondo Maira, resta lo strumento centrale per imparare a usare l’IA in modo consapevole.
«In passato, per fare una ricerca bisognava andare in biblioteca. Era un processo lento, ma formativo: ti obbligava a pensare, a organizzare. Oggi l’accesso è immediato, ma bisogna insegnare che la risposta fornita da un sistema non è la fine, ma solo l’inizio.»
In medicina, l’intelligenza artificiale può offrire strumenti straordinari: «Uno studio della University of Pennsylvania ha utilizzato l’IA per analizzare migliaia di risonanze magnetiche, individuando variazioni minime impossibili da percepire a occhio nudo. Così si possono prevedere malattie neurodegenerative in anticipo. Ma la macchina non sa cosa significano quei dati. È qui che la mente umana resta insostituibile.»
Tecnologia e limite cognitivo: l’alleanza possibile tra cervello e intelligenza artificiale
Il cervello umano contiene circa 87 miliardi di neuroni, eppure non è infinito. Alcune funzioni possono essere delegate alla tecnologia, liberando spazio per il pensiero superiore, la creatività.
«Con l’intelligenza artificiale si rischia di andare più veloci di quanto comprendiamo. È per questo che serve un’alleanza, fondata sul rispetto della dignità umana, della natura e dell’equilibrio ecologico. Tutte le discipline devono cooperare per integrare l’IA in un disegno etico e sostenibile.»
Apprendimento, emozione, identità: perché ogni cervello è unico e irripetibile
Uno dei confini più netti tra uomo e macchina, per Maira, è la formazione dell’identità cognitiva. Nessun cervello è uguale a un altro.
«Nasciamo con un cervello piccolo, che dobbiamo costruire con l’apprendimento. Ogni esperienza lascia un segno, forma nuove sinapsi. Ma ricordiamo solo ciò che ci emoziona. Senza emozione non c’è memoria, senza memoria non c’è apprendimento. Ecco perché ogni cervello è unico, e perché l’intelligenza umana è un territorio irripetibile.»
Sostenibilità cognitiva: il cervello come ecosistema rigenerativo
Sostenibilità non è solo ambiente, ma anche equilibrio mentale. Il cervello è l’organo più plastico del corpo umano, capace di rimodellarsi continuamente.
«Alla nascita non esiste un’area del cervello dedicata alla lettura. Ma, con l’esperienza, il cervello riesce a crearla. Questo ci rende unici tra le specie viventi. Il machine learning può apprendere, ma non immaginare. Non può creare ciò che prima non esisteva. Noi sì.»
Una vita per il cervello: tra memoria privata e responsabilità pubblica
Nel suo libro Le farfalle dell’anima, Maira intreccia la storia personale con la vocazione scientifica. Un racconto che diventa anche riflessione etica.
«Mio padre e mio nonno erano chirurghi. Ho respirato la medicina fin da bambino. Poi ho incontrato un grande professore di fisiologia che mi ha fatto innamorare del cervello umano. Oggi porto avanti questo percorso anche con la Fondazione Atena, per promuovere la ricerca e la cultura della prevenzione. Perché la scienza ha senso solo se restituita alla società.»
Giulio Maira
Giulio Maira è stato direttore dell’Istituto di Neurochirurgia dell’Università Cattolica di Roma, neurochirurgo dello Stato Vaticano e membro del Consiglio Superiore di Sanità. Attualmente fa parte del Comitato nazionale per la sicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del Consiglio.
Ha fondato e presiede la Fondazione Atena, che promuove la cultura della prevenzione e sostiene la ricerca nelle neuroscienze. Per il suo impegno scientifico e civile, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana.