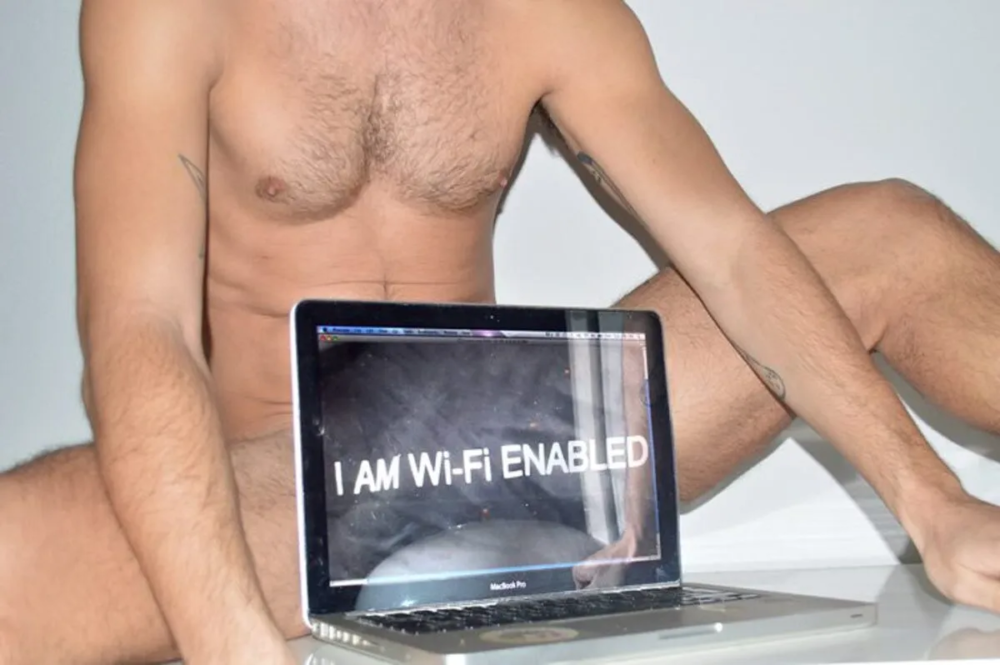La casa senza muri di Petrit Halilaj in un paesaggio condiviso
Intervista a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente di Fondazione Arte CRT: la seconda edizione di RADIS a Dogliani con Petrit Halilaj – «Reversibilità e minimo impatto»
Lampoon in conversazione con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. RADIS: dal monumento all’opera viva
Con Radis parlate di “patrimonio diffuso”. Quali strumenti operativi — convenzioni con i Comuni, piani di manutenzione, fondi vincolati, assicurazioni — ne garantiscono gestione e cura nel tempo?
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo: «Siamo legati al concetto di “patrimonio diffuso”, introdotto negli anni ’80 da Vera Comoli, architetta, docente, studiosa e storica dell’urbanistica, principale referente della scuola torinese impegnata su questi temi. Dobbiamo a lei una visione del territorio come sistema culturale collettivo, nel quale a contare non è tanto il singolo “monumento” ma un insieme di relazioni vive che legano storia, arte, architettura, memoria, manufatti e cittadinanza.
Oggi non parliamo più di monumenti ma di opere, nel caso di Radis di installazioni site-specific, concepite dagli artisti e dalle artiste in stretto rapporto con il paesaggio, con i luoghi e chi li abita. Radis è un’iniziativa cardine nella politica culturale promossa dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, un progetto distintivo del programma 2024-2027 avviato nel corso della mia presidenza.
Con Radis, la Fondazione Arte finanzia e produce opere d’arte per lo spazio pubblico che entrano a far parte della sua collezione “diffusa” sul territorio. Concesse in comodato d’uso permanente al territorio in cui si collocano, sono opere che entrano nella vita degli abitanti: diventano spazi per sviluppare i progetti educativi destinati alle scuole, svolgono un ruolo importante nella cultura locale e funzionano come catalizzatori turistici.
La concessione è un “affido” che comporta un’assunzione di responsabilità da parte del ricevente ed è registrata da un accordo scritto in cui vengono stabiliti tutti i termini del comodato: le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione, la gestione, la fruizione. Sia il comodante – la Fondazione – che il comodatario – l’ente pubblico o privato a cui l’opera viene affidata – sottoscrivono le proprie responsabilità, preventivamente concordate in sede di stesura del contratto».
Una casa senza muri per guardare meglio: l’opera di Petrit Halilaj tra UNESCO e turismo lento
FJC: Dogliani, Borgata Valdibà: l’opera di Petrit Halilaj sostituirà l’ex scuola con una “casa senza muri”. Quali valutazioni d’impatto paesaggistico e d’uso avete impostato rispetto alla prossimità dell’area Unesco e al turismo lento?
SPRR: «L’opera che Petrit Halilaj ha progettato per Borgata Valdibà è un nuovo capitolo della serie Abetare, alla quale l’artista sta lavorando da quasi quindici anni. Il titolo della serie riprende il nome in albanese dell’abecedario.
Al posto della vecchia scuola della borgata, abbandonata dagli anni ’70, Halilaj costruirà una casa di fantasia, un perimetro di sculture, i cui profili in acciaio piegato riproducono in grande formato i disegni e gli scarabocchi tracciati dai bambini e dalle bambine sui banchi delle scuole delle Langhe e dei Balcani, raccolti dall’artista. Il risultato è un’installazione che rende visibile l’immaginario e la fantasia infantile.
L’opera, aerea, porosa e leggera, disegna e incornicia il paesaggio, non lo nasconde ma lo esalta, offrendo alle persone in visita nuove vedute sulla campagna e sul panorama del Monviso e delle Alpi.
Petrit Halilaj ci offre dunque una posizione per guardare, pensare, ricordare, immaginare, con un’opera che invita a fermarsi e sostare, perfetta per assecondare il ritmo di un turismo lento e consapevole, il passo giusto per attraversare i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio Unesco».

Quando un’opera diventa infrastruttura sociale: sostenibilità culturale come coesione, programma educativo e appartenenza
FJC: Cosa significa per Lei “sostenibilità culturale”? Quali responsabilità ne derivano per istituzioni e territori?
SPRR: «Nel caso di Radis, la sostenibilità culturale è strettamente correlata proprio al concetto di “patrimonio diffuso”, di cui parlavo prima, secondo un approccio che non considera l’opera d’arte pubblica come una presenza isolata ma come un fulcro di relazioni e attività.
Ci interessa produrre nuove opere d’arte, commissionate ad artisti italiani e stranieri delle ultime generazioni, già affermati nel sistema internazionale. Vogliamo che l’opera, oltre al valore estetico, sia portatrice di valore sociale: uno strumento identitario e di coesione della comunità.
L’investimento della Fondazione mira al rilancio e alla continuità nel tempo: un esempio è il programma educativo per le scuole del territorio con cui accompagniamo la fase di presentazione dell’installazione permanente. Concepite da operatori locali, le attività “allenano” insegnanti e studenti all’utilizzo immaginifico e conoscitivo dell’opera, un “esercizio” che pensiamo possa entrare a far parte delle attività extrascolastiche e proseguire in autonomia.
La responsabilità delle istituzioni locali consiste prima di tutto nella consapevolezza del potenziale culturale e sociale dell’opera, un valore di cui è fondamentale continuare a prendersi cura, prestando attenzione alla comunicazione, alla promozione e alla conservazione».
L’eleganza del ruvido: opere scomode che incoraggiano una mentalità aperta
FJC: Lampoon ha fatto del ruvido un manifesto — imperfezioni, materia che respira, limpidezza, stile di vita. Esiste una ruvidità anche nella sua pratica istituzionale — zone d’attrito con il gusto, con il consenso locale, con l’economia dei grandi eventi — che sceglie deliberatamente di non levigare?
SPRR: «Mi interessa molto il concetto di ruvido: amo le opere e le ricerche artistiche che sanno essere ruvide, scomode, che sanno prenderci in contropiede e disturbare le nostre abitudini mentali, spostando anche solo di qualche millimetro i pensieri troppo fissi e rigidi.
Nella mia pratica istituzionale non cerco la levigatezza ma mi preme essere chiara e incisiva, comunicando con precisione le intenzioni, i programmi, comprese le questioni aperte e i temi più problematici».
Cartografia delle relazioni: la scelta di luoghi e artisti per bilanciare comunità locale e scena internazionale
FJC: Con quale processo scegliete artisti e siti per RADIS? Come bilanciate richieste delle comunità e posizionamento internazionale?
SPRR: «Il processo di scelta è affidato a Marta Papini, curatrice della prima e di questa seconda edizione di Radis, le cui proposte sono sottoposte al Cda della Fondazione Arte CRT per la scelta finale. Il lavoro preliminare della curatrice si articola su un doppio binario: quello del luogo e quello dell’artista, in una selezione incentrata sull’analisi della loro potenziale reciprocità.
Da un lato, quindi, la curatrice compie una serie di studio visit finalizzate ad approfondire le ricerche dei singoli artisti, privilegiando quelli che hanno già realizzato opere per lo spazio pubblico o all’aperto. Dall’altro fa ricerca sul territorio, incontrando i rappresentanti delle istituzioni e le comunità, facendo leva sulle loro esperienze e conoscenze, al fine di individuare un luogo adatto.
La scelta è compiuta prestando attenzione alla ricerca dell’artista, alla sua risonanza sulla scena dell’arte internazionale e al suo curriculum. Petrit Halilaj è un artista che, fra le varie mostre, ha esposto alla Biennale di Berlino nel 2010, ha rappresentato la Repubblica del Kosovo, sua nazione di origine, alla Biennale di Venezia nel 2013 ed è protagonista della personale all’Hamburger Bahnhof di Berlino, aperta dall’11 settembre 2025 a maggio 2026.
Giulia Cenci, autrice dell’installazione le masche a Rittana, realizzata nel 2024 per la prima edizione di Radis, ha esposto in istituzioni nazionali e internazionali tra cui la Biennale di Venezia del 2022, la High Line di New York, il MUDAM di Lussemburgo, il MAXXI di Roma e il Centro Pecci di Prato».
Contare per contare davvero: distribuzione del budget e impatti verificabili per la collettività
FJC: Collezione, Internazionalizzazione, Professioni, Spazio Pubblico, Educazione e Comunità: come ripartite il bilancio tra acquisizioni, commissioni e sviluppo di competenze? Quali indicatori pubblici rendiconterete e con quale cadenza?
SPRR: «La collezione è il centro dell’identità istituzionale della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT: conferita in comodato alla GAM, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, e al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, realizza l’idea di un patrimonio appartenente a una fondazione privata, disponibile alla collettività.
L’attività di acquisizione assorbe circa il 35% del budget complessivo; la restante parte è suddivisa nei progetti di arte nello spazio pubblico, di sostegno al sistema dell’arte contemporanea piemontese e nei progetti di educazione e formazione specialistica.
Al termine di ogni edizione, riferiamo pubblicamente gli esiti dei singoli progetti in termini di numero di partecipanti, provenienze, ricadute socio-economiche e/o occupazionali».

RADIS: reversibilità, materiali certificati e tutela della biodiversità nei contesti sensibili
FJC: In contesti tutelati, quali criteri tecnici guidano la progettazione di opere permanenti (materiali, fondazioni, suolo, biodiversità, fine vita dei componenti)?
SPRR: «La progettazione in contesti tutelati si fonda sui principi di reversibilità e minimo impatto.
I materiali, in particolare, vengono selezionati privilegiando elementi durevoli, resistenti e certificati, capaci di garantire stabilità a lungo termine, ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione, essere quanto più possibile smaltiti in maniera sostenibile e in linea con gli standard di sicurezza.
Le fondazioni delle opere realizzate nell’ambito di Radis sono progettate con sistemi leggeri e non invasivi, rispettando la morfologia del suolo e consentendo, se necessario, la rimozione dell’opera senza lasciare tracce permanenti.
Posizionamento e scala dell’intervento vengono attentamente valutati per non interferire con habitat e specie locali, garantendo così un’integrazione coerente e rispettosa nel contesto».
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo: prestiti, coproduzioni e allestimenti riutilizzabili
FJC: Esiste una soglia ecologica oltre la quale un prestito non è giustificabile? State introducendo priorità territoriali, coproduzioni o allestimenti riutilizzabili per ridurre trasporti e rifiuti?
SPRR: «Collaboriamo soprattutto con grandi musei come la GAM e il Castello di Rivoli. Entrambi sono sensibili alle questioni ambientali e, come tutti i musei contemporanei, avvertono l’importanza della riflessione sulla sostenibilità dei prestiti e della movimentazione delle opere.
Per quanto riguarda le coproduzioni, proprio nell’ambito di Radis abbiamo attivato la collaborazione con la Fondazione CRC, che oltre a partecipare alla produzione dell’opera permanente, è a fianco della Fondazione Arte CRT nella realizzazione della mostra che ogni anno accompagna l’inaugurazione dell’installazione permanente.
Come già nella prima edizione del programma, le opere delle nostre due collezioni d’arte contemporanea si uniscono in una sede temporanea, con trasporti provenienti da Torino e da Cuneo, per offrire al territorio una mostra collettiva di alta qualità per opere e temi affrontati».
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo su pratiche di governance e sostenibilità sociale: dal MoMA e dalla Tate al CIMAM di Torino
FJC: Dalle Sue esperienze nei consigli internazionali (MoMA, Tate) e in CIMAM, quali pratiche di governance e di sostenibilità sociale ritiene adattabili al contesto italiano? E quali richiedono una revisione per funzionare qui?
SPRR: «I grandi musei internazionali sono fonte di ispirazione. Penso, per esempio, all’impegno della Tate Gallery che riconosce all’arte e ai musei un ruolo unico nella creazione del cambiamento sociale e che nel 2023 ha ospitato il primo summit sulla sostenibilità COP dei musei.
Penso al MoMA che, a proposito della Sustainability Mission, dichiara: “Crediamo che il nostro lavoro intellettuale e culturale sia inseparabile dai sistemi biologici e climatici che governano il pianeta. Mentre la realtà della crisi climatica continua a trasformare società e tradizioni in modi imprevisti, più che mai sono necessarie nuove narrazioni e metodi per tracciare un percorso di speranza, resilienza, innovazione ed empatia con il pubblico”. Rispetto al tema ecologico, segnalo per esempio la Gallery Climate Coalition, un’associazione internazionale che fornisce linee guida sulla sostenibilità ambientale per il settore artistico.
Dal 28 al 30 novembre 2025, Torino sarà sede dell’Annual Conference del CIMAM, l’International Committee for Museums and Collections of Modern Art, ospitata dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, dal Castello di Rivoli e dalla Fondazione Torino Musei e sostenuta dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e dalla Fondazione CRT. Intitolata Enduring Game: Expanding New Models of Museum Making, la conferenza coinvolgerà 300 delegati da tutto il mondo e sono certa che produrrà indirizzi anche sul tema della sostenibilità sociale.
In attesa dei risultati possiamo fare affidamento al sondaggio “Sostenibilità climatica, sociale ed economica”, condotto dal CIMAM nel 2022. Questo documento indica lo sviluppo sostenibile nell’unione tra “Qualità educativa” (raccomandando la ricerca, la formazione e la collaborazione tra tutti i dipartimenti del museo), la “Parità di genere” (creando un ambiente di lavoro che abbracci tutti i generi e tutte le identità) e la “Riduzione delle diseguaglianze” (garantendo pari accesso a tutti i settori della comunità e riconoscendo il museo come punto di riferimento per la difesa dei diritti umani fondamentali e come spazio di discussioni che rendano visibili i gruppi a rischio di esclusione o rappresentanza).
Sono orientamenti utili e adottabili anche nei nostri musei e nei nostri centri espositivi, molti dei quali, soprattutto negli ultimi anni, hanno compreso l’importanza di allinearsi con queste politiche. Penso sia necessario recepirle adattandole al proprio specifico contesto, reinterpretandole alla luce della propria fisionomia istituzionale, delle proprie missioni e comunità di riferimento».

Aperto, la città delle competenze: standard, accesso equo e formazione per le professioni dell’arte contemporanea a Torino
FJC: In che modo la linea “Professioni” entra nei bandi e nei contratti dei progetti della fondazione? Come nasce e si sviluppa il programma Aperto?
SPRR: «Nel programma 2024-2027 della Fondazione Arte CRT, abbiamo introdotto il tema delle professioni, partendo dalla considerazione che una città come Torino, ritenuta una delle capitali dell’arte contemporanea, possa aspirare a diventare anche una città di riferimento per le professioni dell’arte contemporanea.
Abbiamo quindi investito sulla formazione, sviluppando Aperto. Avviato nel 2024, è un programma di alta formazione che offre ogni anno un ciclo di seminari intensivi e gratuiti, destinati a laureati, dottorandi, giovani professionisti, artisti e artiste di età compresa tra i 22 e i 35 anni e accessibili tramite open call.
I seminari sono organizzati da istituzioni del territorio con una comprovata expertise in ambito formativo (Castello di Rivoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, gli spazi indipendenti Almanac, Cripta747, Mucho Mas!, Artissima). Dedicati a temi, teorie e pratiche riguardanti le diverse professionalità dell’arte contemporanea, i seminari riguardano gli ambiti delle practice-based research, della storia delle mostre, della formazione artistica, della scrittura per l’arte, dell’allestimento, della produzione e del management culturale, approfonditi da docenti esperti, italiani e stranieri (per il ciclo del 2024 ne abbiamo invitati in tutto 54).
I risultati della prima edizione hanno confermato che Aperto risponde a una diffusa e impellente domanda formativa. Le sei open call ad accesso gratuito dell’edizione del 2024 hanno raggiunto un’ampia platea di giovani che aspirano a ricoprire ruoli nel settore, come attestano le 372 application pervenute e il numero di partecipanti selezionati: 111 da tutta Italia.
Crediamo nella continuità e abbiamo confermato la seconda edizione di Aperto, avviata lo scorso luglio con il seminario Raccontare le mostre, organizzato dal Castello di Rivoli e dal CRRI, il Centro di Ricerca del museo, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino».
Laboratori di sostenibilità ambientale: il parco d’arte a San Licerio e l’Isola di San Giacomo. Convivenza tra cultura e natura
FJC: Dalla mostra Greenwashing (2008) al progetto di San Giacomo in laguna: come è cambiata la Sua agenda ambientale e quali impegni quantitativi adotta oggi su energia, trasporti, materiali, rifiuti e rendicontazione pubblica?
SPRR: «Dal 2008 a oggi la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha fatto passi concreti, soprattutto grazie al contributo di Asja Energy, l’azienda di mio marito Agostino Re Rebaudengo, che produce energia pulita da fonti rinnovabili. Continuiamo a realizzare mostre e progetti che affrontano con serietà il tema dell’emergenza climatica ed ecologica, sicuramente una delle sfide più grandi del nostro tempo.
Lo abbiamo fatto, per esempio, nell’estate 2022 con Training for the Future, un progetto ideato dall’artista Jonas Staal in collaborazione con Florian Malzacher. Per tre giorni, la Fondazione si è trasformata in una “palestra” di attività e workshop che hanno coinvolto oltre 100 partecipanti tra i 15 e i 29 anni (provenienti da associazioni culturali e di militanza, da scuole, licei, istituti, accademie e università), in una pratica utopica e collettiva di immaginazione del futuro, intitolata We Demand A Million More Years.
Nello stesso anno, nella mostra Qualcosa nell’aria, abbiamo esposto El Martillo, una scultura gonfiabile del collettivo Tools for Action, originariamente realizzata per una manifestazione per la giustizia climatica in Messico nel 2010. Il 29 luglio 2022, la scultura è uscita dalle sale della Fondazione e, su invito di Fridays For Future Italia, ha accompagnato la manifestazione di Torino Climate Social Camp, sfilando per le strade della città. Sono convinta che la collaborazione con le giovani generazioni sia cruciale. Così come sono convinta che a questo tipo di proposta debba corrispondere una coerenza di condotte sul piano concreto.
In questa direzione, abbiamo posto in atto una serie di misure sul piano della sostenibilità. Nella sede della Fondazione a Torino sono state sostituite le tradizionali caldaie per il riscaldamento invernale con un impianto di microcogenerazione ad alto rendimento che ha ridotto le emissioni di NOx del 60% e quelle di CO₂ del 30%. Inoltre, la Fondazione è stata collegata alla rete di teleriscaldamento di Torino, una rete tra le più grandi ed efficienti d’Europa.
Per incrementare ulteriormente l’efficienza è stato installato un cappotto per l’isolamento termico che ha significativamente elevato la classe energetica dell’edificio. Un’ulteriore riduzione dei consumi elettrici è stata conseguita aggiornando il sistema illuminotecnico a LED, sostituito alle precedenti lampade al neon e alogene. Siamo in attesa dell’autorizzazione per realizzare sulla copertura un impianto fotovoltaico da 200 kW che, abbinato a un accumulo e a pompe di calore, aumenterà ulteriormente l’efficienza.
Le due sedi della Fondazione dedicate al rapporto tra arte/cultura/natura sono il Parco d’arte Sandretto Re Rebaudengo, sulla Collina di San Licerio a Guarene (poco distante da palazzo Re Rebaudengo che è stata la nostra prima sede, aperta nel 1997) e la sede di San Giacomo nella laguna veneziana. Il Parco d’arte ospita attualmente diciassette grandi sculture e installazioni permanenti, collocate su uno dei versanti della collina, tra i filari di una vigna di Nebbiolo, il viale con il frutteto di pere Madernasse e migliaia di piccole piante e arbusti, messi a dimora per consolidare il terreno e catturare le emissioni di CO₂.
L’isola di San Giacomo a Venezia aprirà nel 2026 e ospiterà mostre, residenze artistiche e public programme. È stata progettata con la stessa visione: grazie all’energia del sole e a un sistema di accumulo elettrico saremo completamente autosufficienti e a emissioni zero.
In questo modo, coerentemente con gli impegni assunti più di quindici anni fa, continuiamo a lavorare per rendere la Fondazione non solo un luogo di cultura ma un laboratorio di sostenibilità ambientale».