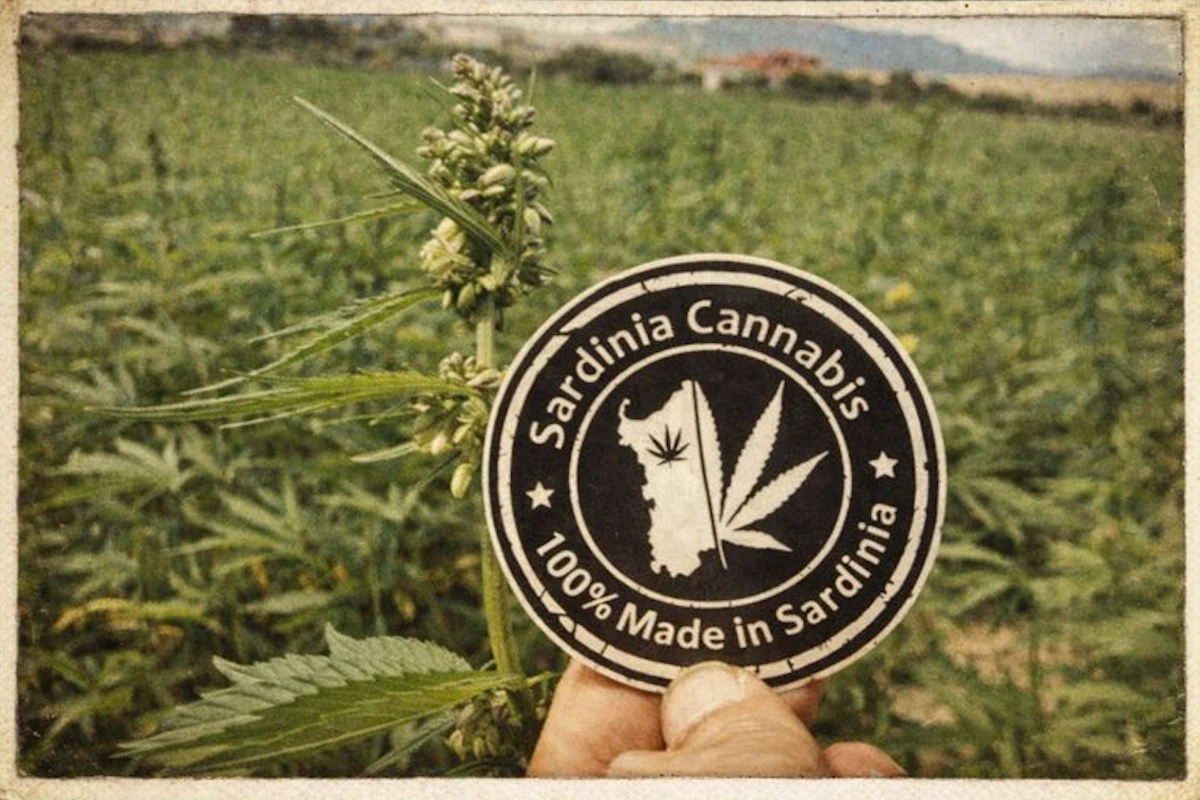Dalla cittadinanza attiva al verde urbano: le nuove frontiere milanesi
Da Milano Attiva a Forestami, passando per il corridoio verde Green Circle 90/91 supportato da Armani: il futuro urbano di Milano tra partecipazione civica, riforestazione e rinaturalizzazione infrastrutturale
Sostenibilità urbana a Milano: tra partecipazione pubblica, forestazione e progetti ibridi
Negli ultimi anni, Milano ha moltiplicato gli sforzi per rendere la sostenibilità un elemento strutturale delle sue politiche urbane. A partire da strumenti partecipativi digitali, passando per progetti di forestazione urbana e rinaturalizzazione infrastrutturale, fino alla sperimentazione di forme ibride di governance che coinvolgono cittadini, enti pubblici e imprese private. La città si configura sempre più come un laboratorio a cielo aperto, in cui si intrecciano urbanistica, cittadinanza attiva e capitale naturale.
Urbanistica di Milano: la piattaforma Milano Attiva
Lanciato nell’autunno 2023 dal Comune di Milano, Milano Attiva è un portale digitale aperto che raccoglie proposte spontanee da parte di cittadini, comitati, associazioni e gruppi informali per la gestione e rigenerazione degli spazi pubblici. Si tratta di una call permanente senza vincoli tematici né scadenze, valutata ogni quattro mesi da una Cabina di regia istituita da Palazzo Marino.
L’ambizione è quella di semplificare l’accesso alle progettualità civiche, attivando un processo di urbanistica partecipata capace di coniugare co-design, prossimità e cura dei beni comuni. I progetti spaziano dalla pedonalizzazione temporanea (playstreet) alla trasformazione dei cortili scolastici in spazi multifunzionali, dagli orti urbani all’uso transitorio di immobili sfitti.
Sebbene si ispiri a esperienze consolidate in altre città italiane – come i patti di collaborazione torinesi o il Regolamento dei beni comuni di Napoli – Milano Attiva mantiene un’impostazione verticale: la valutazione finale delle proposte spetta all’amministrazione comunale e mancano indicatori pubblici su criteri di selezione, risorse stanziate e impatto generato.
Forestazione urbana: tre milioni di alberi entro il 2030 con Forestami
Parallelamente alla piattaforma Milano Attiva, si sviluppa Forestami, un progetto di forestazione urbana avviato da una ricerca del Politecnico di Milano e promosso da Comune, Città metropolitana e Regione Lombardia con il sostegno di numerose fondazioni e università. L’obiettivo è la messa a dimora di tre milioni di alberi entro il 2030 per incrementare del cinque percento la copertura arborea dell’area metropolitana, migliorare la qualità dell’aria e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.
Nel 2025 Forestami si è dotato di una fondazione autonoma di Terzo Settore per rafforzare la governance e attrarre fondi privati. I progetti avviati si fondano su un mix di criteri ecologici e sociali: aumentare la biodiversità, favorire la resilienza climatica, migliorare l’infiltrazione dell’acqua piovana e rigenerare il suolo urbano.
Rigenerazione urbana con Armani: Milano Green Circle 90/91
Uno degli interventi più recenti, nati sotto l’egida di Forestami, è il progetto Milano Green Circle 90/91, promosso dal Comune di Milano e sostenuto dal Gruppo Armani. Il progetto, ideato dall’agronoma Laura Gatti, interessa il tracciato della filovia 90/91 e prevede la rinaturalizzazione di uno degli assi infrastrutturali più trafficati della città.
Il primo tratto, già concluso, va da piazzale Brescia a piazza Bolivar: sono stati piantati trecentocinquanta nuovi alberi e oltre sessantamila arbusti ed erbacee perenni, con l’obiettivo di aggiungerne altri trecento entro il termine dei lavori previsti per il 2026-2027. Le specie selezionate – tra cui sorbo, melocotogno, rosa rugosa e salvia bianca – contribuiscono a incrementare la biodiversità e mitigare l’inquinamento atmosferico. Gli interventi includono anche microinvasi per la raccolta dell’acqua piovana, tessuti pacciamanti biodegradabili e una revisione della gestione degli arbusti esistenti in collaborazione con i manutentori comunali.
L’iniziativa si distingue anche per l’impatto sociale: il cantiere è stato affidato alla cooperativa Il Giardinone, che impiega persone con fragilità fisiche o psichiche, con l’obiettivo di coniugare inclusione lavorativa e cura del territorio.
Durante il Salone del Mobile 2025, il Gruppo Armani ha promosso una campagna di sensibilizzazione: un’Ape car elettrica brandizzata Emporio Armani è stata posizionata in via Manzoni con la distribuzione di vasi riciclati e cartoline piantabili. «Milano Green Circle non è una dichiarazione di intenti, ma qualcosa di tangibile» ha dichiarato Giorgio Armani. «La mia speranza è quella di contribuire alla realizzazione di una Milano che sia davvero a misura d’uomo, nella quale stare bene».

Moda e urbanistica: la geografia simbolica di Armani a Milano
Giorgio Armani ha radicato il proprio immaginario non solo nel linguaggio estetico della moda, ma nella struttura stessa della città. La scelta di concentrare quartier generale, spazi espositivi e progetti filantropici in un perimetro ridotto — da via Bergognone a via Manzoni, passando per via Borgonuovo — costruisce una geografia simbolica in cui lo stile si traduce in assetto urbano. Non è casuale che Milano Green Circle 90/91 si sviluppi lungo una linea tangenziale che circonda questi luoghi, come a estendere spazialmente un’estetica minimale e ordinata a un ambito metropolitano.
L’estetica sobria di Armani si confronta, con Milano Green Circle, con un linguaggio progettuale che ha a che fare con la terra, con il suolo, con l’umidità e la gestione della materia organica. La moda si ibrida con il paesaggismo urbano e la silhouette di un trench viene messa a confronto con la chioma di un carpino. Il passaggio è denso di implicazioni: si tratta di trasporre un’estetica disciplinata su una superficie disordinata, quella urbana, in cui crescono erbe spontanee e si accumulano acque meteoriche.
Verde integrato, servizi ecosistemici e design del microclima urbano
La rinaturalizzazione della 90/91 rappresenta un tentativo di rendere il verde parte integrante del sistema infrastrutturale. Non solo alberature, ma soluzioni multifunzionali in grado di migliorare l’assorbimento degli inquinanti, ridurre il rumore urbano, rigenerare il suolo e offrire habitat per gli impollinatori. Secondo Forestami, i benefici derivanti da questi interventi rientrano nella categoria dei servizi ecosistemici: apporti essenziali al benessere umano forniti da ecosistemi naturali o semi-naturali.
Milano Green Circle interviene anche sul microclima urbano. Le specie arboree selezionate – frassini, carpini, querce – rispondono a esigenze specifiche: capacità di ombreggiamento, resistenza allo stress idrico, attrazione di insetti impollinatori. La configurazione vegetale non è, quindi, decorativa, ma funzionale alla costruzione di un’infrastruttura termica in grado di ridurre l’isola di calore. L’intervento si articola in una logica performativa del verde, in linea con i principi del landscape urbanism.
Il progetto incorpora dispositivi di ingegneria verde che suggeriscono un’attenzione alla manutenzione e alla resilienza nel tempo. Dalla fitodepurazione dei bacini temporanei alla pacciamatura con fibre naturali, ogni elemento è progettato per integrarsi con il ciclo stagionale e con le pratiche di cura comunitaria. La forestazione diventa occasione per costruire un rapporto di prossimità tra cittadini e ambiente urbano, sottraendo il verde alla logica della spettacolarizzazione e riportandolo a una dimensione quotidiana.
Dalla riqualificazione urbana all’acqua potabile: le iniziative di Armani
Oltre al progetto Green Circle 90/91, il Gruppo Armani ha promosso una serie di iniziative che rafforzano il suo legame con il territorio milanese, operando all’intersezione tra moda, cultura, sport e sostenibilità. Nel 2022, A|X Armani Exchange ha avviato un intervento di riqualificazione di cinque playground pubblici per lo street basket, situati in aree periferiche e semicentrali della città, come Parco Sempione e la Barona. In collaborazione con Mapei e il Comune di Milano, i campi sono stati rinnovati con materiali tecnici e nuovi pattern grafici, trasformandosi in spazi pubblici accessibili e riconoscibili.
Il rapporto con la città si articola anche attraverso l’Armani/Silos, spazio espositivo inaugurato nel 2015 in via Bergognone, che ospita mostre tematiche dedicate alla moda, all’architettura e alla fotografia. Da Milano Armani coordina anche il progetto globale Acqua for Life, volto a garantire l’accesso all’acqua potabile in comunità vulnerabili.

Ecologie minime e nuove soglie urbane
Il progetto Green Circle, patrocinato da Armani, mette in evidenza una dimensione progettuale marginale ma strategica: quella degli spazi interstiziali. Marciapiedi allargati, aiuole dimenticate, parcheggi dismessi o sottoutilizzati—aree residuali che sfuggono alla pianificazione codificata—diventano dispositivi attivi di rigenerazione ecologica. In queste soglie urbane, la forestazione urbana si muove attraverso addizioni minime, con logiche di intervento incrementale: singole alberature, isole di biodiversità, pergolati o micropaesaggi vegetali capaci di generare un impatto sistemico su scala di quartiere.
Accanto al Green Circle, la piattaforma Forestami ha promosso una molteplicità di interventi distribuiti, estendendo il principio della forestazione anche a contesti periurbani e infrastrutturali. Tra questi, il rimboschimento di fasce marginali lungo le tangenziali e i sedimi ferroviari, la creazione di boschi lineari a bordo strada, e la piantumazione di alberi in parcheggi scolastici e cortili condominiali. Alcuni progetti pilota—tra cui quelli realizzati in prossimità di ospedali e residenze per anziani—indagano il rapporto tra vegetazione, benessere psicofisico e microclima urbano, introducendo metriche legate alla salute pubblica all’interno delle strategie ambientali. La forestazione, in questo senso, assume un ruolo performativo: non solo estetico o compensativo, ma capace di attivare trasformazioni ambientali, sociali e percettive attraverso micro-innesti nei vuoti della città costruita.
Orti condivisi come infrastrutture civiche
Gli orti condivisi attivi nei quartieri di Quarto Oggiaro, Niguarda, Chiaravalle e nel Parco delle Abbazie rappresentano un’altra espressione di ecologia urbana a base comunitaria. Non si tratta soltanto di spazi coltivati, ma di infrastrutture civiche che mirano a rafforzare il tessuto sociale nei contesti periferici, spesso segnati da discontinuità nei servizi e nell’offerta di spazi pubblici qualificati. La gestione è affidata a reti ibride composte da residenti, associazioni locali, cooperative e talvolta istituti scolastici, che si coordinano attraverso patti di collaborazione con il Comune.
In alcuni casi, gli orti sono integrati in percorsi di educazione alimentare, laboratori con le scuole, tirocini per soggetti fragili o iniziative intergenerazionali, generando economie di prossimità non monetarie. La produzione agricola, limitata per estensione e finalità, diventa così un pretesto per costruire relazioni, rafforzare l’identità dei luoghi e presidiare territori marginali senza ricorrere a dispositivi di controllo formale, promuovendo nel contempo pratiche alimentari sostenibili.
Gestione integrata delle acque e riapertura dei Navigli
Nel campo della gestione idraulica, Milano sta sperimentando un approccio integrato che combina ingegneria ambientale, rigenerazione urbana e mitigazione climatica. Tra gli interventi figura il progetto di riapertura parziale dei Navigli, che prevede il disvelamento progressivo di tratti tombati del sistema storico-canale, in un’ottica di restauro idraulico e riqualificazione paesaggistica. Parallelamente, sono in corso opere di rinaturalizzazione delle sponde lungo corsi d’acqua minori come il Lambro e il Seveso, caratterizzati da elevata vulnerabilità idrogeologica e da un forte impatto antropico.
Questi interventi puntano ad aumentare la permeabilità dei suoli, favorire l’assorbimento delle acque meteoriche e ripristinare corridoi ecologici interni alla città, anche attraverso l’introduzione di fasce tampone vegetate e bacini di laminazione. L’approccio privilegia soluzioni basate sulla natura e si inserisce in una strategia più ampia per contrastare gli effetti delle bombe d’acqua e contenere i picchi di piena nei quartieri più esposti, in particolare nelle zone a nord-est della città.

Comunità energetiche e smart city
In ambito energetico, Milano sperimenta modelli cooperativi di produzione e condivisione dell’energia. Le comunità energetiche, costituite da condomini, cooperative e imprese sociali, generano energia rinnovabile in situ per l’autoconsumo e lo scambio locale. Un esempio è il progetto Sharing Cities nel quartiere di Porta Romana, dove sono stati testati edifici efficientati, mobilità elettrica condivisa e un sistema intelligente per la gestione dell’illuminazione pubblica.
Un altro intervento in corso riguarda la rigenerazione energetica degli edifici pubblici attraverso il programma Reinventing Cities, promosso da C40 Cities in collaborazione con il Comune. Il progetto prevede la riqualificazione di spazi abbandonati o sottoutilizzati, come ex caserme e scuole dismesse, secondo criteri di bioedilizia, produzione energetica da fonti rinnovabili e autosufficienza termica. Tra i casi selezionati figura l’area di Piazzale Loreto, oggetto di una trasformazione urbanistica volta a riconnettere l’asse nord della città con il centro mediante una piazza verde, ciclabile e accessibile.
Nel quartiere Adriano, alla periferia nord-est della città, è stato inoltre avviato il progetto Adriano Community Center, un centro polifunzionale a impatto zero, costruito in legno, che ospita servizi sociosanitari, spazi per la formazione e attività culturali. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra Comune, fondazioni private e cooperative sociali e rappresenta un modello replicabile di edilizia integrata al tessuto sociale.
Un ulteriore tassello è costituito dal progetto Climate-Resilient Schools, promosso in collaborazione con Legambiente e l’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio. Si tratta di un piano per la trasformazione climatica di edifici scolastici attraverso tetti verdi, sistemi di ombreggiamento, ventilazione naturale e spazi didattici all’aperto. L’obiettivo è duplice: ridurre l’impatto delle ondate di calore sui più giovani e trasformare le scuole in presidi ambientali nei quartieri.
Sostenibilità urbana a Milano
Milano promuove una sostenibilità urbana policentrica attraverso strumenti partecipativi come Milano Attiva, progetti di forestazione come Forestami e interventi di rigenerazione infrastrutturale come il Milano Green Circle 90/91. La città sperimenta orti condivisi, comunità energetiche, edilizia scolastica resiliente e nuove forme di governance ambientale.