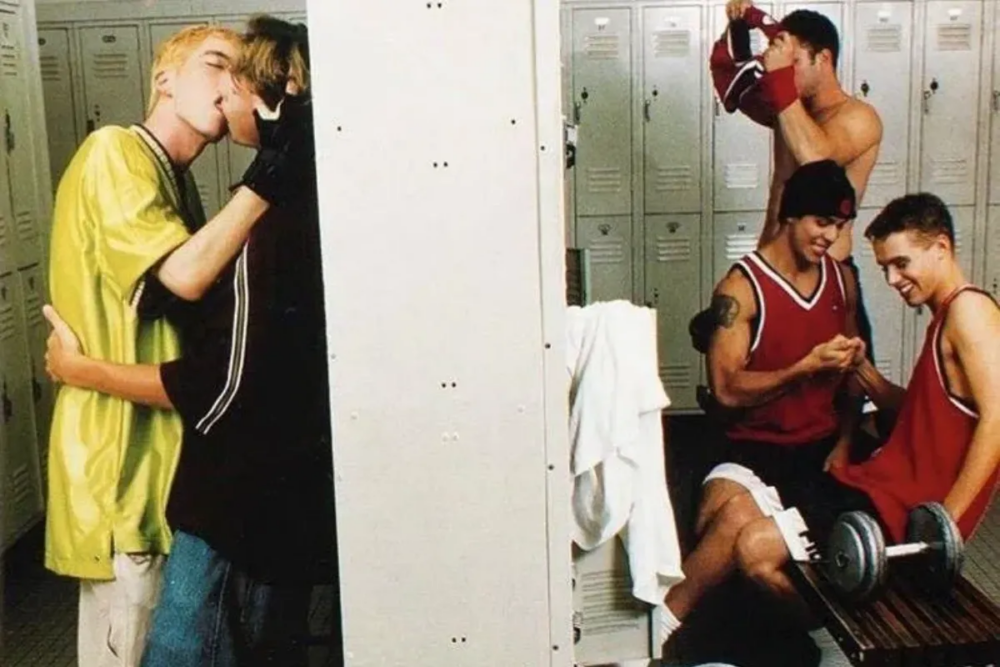La storia della Monaca di Monza resta attuale: dalla clausura alla corona
Marianna di Leyva, monaca e contessa di Monza fu condannata a essere murata viva da Federico Borromeo: la storia di una donna colpevole e vittima, e la corona degli imperatori
La Monaca di Monza fu murata viva per 14 anni: strati di starti fecali, igiene nel Seicento
La Monaca di Monza fu murata viva. Visse per quasi quattordici anni in una cella rettangolare: un lato contava poco più di un metro, l’altro poco più che due. Non c’era porta – solo una fessura tramite la quale le davano cibo per mantenerla in vita.
Convisse con i suoi escrementi, in quei pochi metri cubi – non c’è traccia di tanto, ma si può supporre che sempre tramite fessure al pavimento secchiate d’acqua a terra potessero essere gettate, di tanto in tanto, per evitare accumulo eccessivo. La donna fu lasciata lì a imputridire insieme a strati di suoi scarti. Il pensiero di tale tortura porta i brividi – rimangono le domande: come riuscì, a inizio Seicento – secolo di igiene scarsa e medicina approssimativa, di pestilenze – a sopravvisse agli inverni, allo sporco, a germi, virus? Si può supporre perse la dentatura. Ne uscì e continuò a vivere per altri 25 anni in uno stato di demenza intellettiva.
Marianna de Leyva e Federico Borromeo, arcivescovo di Milano
Marianna de Leyva era stata accusata con più capi – il più grave l’omicidio, dove però non si poté sapere su fu solo complice o se levò la mano. Ruppe il voto di clausura, ebbe amante e progenie – almeno due pargoli di cui una bambina riuscì a crescere. Il suo amore fu criminale: Giampaolo Osio colpì a morte almeno due suore del convento. A dare condanna alla nobile monaca fu l’arcivescovo di Milano, Federico Borromeo, nipote del Santo Carlo – nessun santo dovrebbe mai porre così tanto dolore a una donna la cui esperienza umana fu critica.
Lombardia e Ticino: la famiglia Borromeo, Carlo e Federico – gli spagnoli, gli austriaci, Napoleone e i Savoia
La famiglia Borromeo era una dinastia sovrana delle terre intorno al Lago Maggiore, oltre che titolare di signorie e proprietà a Milano e nei suoi dintorni. Nel corso della storia, la famiglia riuscì a barcamenarsi tra i vari conquistatori. I Borromeo si potrebbero intendere oggi come facili voltagabbana, ma più probabile che non avessero possibilità di agire diversamente, pena fallimenti, miserie e morte. Ebbero ruoli di spicco sotto gli Spagnoli e sotto gli Austriaci. Ospitarono Napoleone all’Isola Bella. Mantennero rispetto dai Savoia – fino a un documentario sul caso di morte dell’Isola di Cavallo, prodotto da una discendente del ramo cadetto, Beatrice Borromeo. Il video si chiude con una la voce fuori campo, senza approfondimento o inquisitoria, quando il principe Savoia si riferisce a Juan Carlo di Spagna quale equivalente omicida.
Nessuno tra i Borromeo raggiunse il soglio pontificio. Carlo Borromeo, cardinale, fu protagonista della Controriforma che bene fece alla Chiesa Cattolica durante la crisi aperta da Lutero in Germania. Carlo Borromeo pose le basi per la ricchezza e la laboriosità di tutta la Lombardia, implementando la rete fluviale che se ne partiva dal Ticino, fiume emissario del Lago Maggiore di cui era signore. Rinforzò la ramificazione dei navigli commerciali e dei canali agricoli imbastiti da Ludovico il Moro qualche decennio prima. Cardinale fu anche Federico, che salì al soglio del Duomo di Milano nei primi decenni del Seicento, e che ebbe a che fare con Marianna de Leyva, la Gertrude del Manzoni, monaca e contessa, signora feudataria di Monza.
Il Seicento è spesso inteso come secolo oscuro. La dominazione spagnola in Italia, a Milano prende i toni del viola, del nero – forse anche per come li dipinse il Manzoni ne I Promessi Sposi. Fu il secolo in cui esplosero le guerre di religione che oggi appaiono più grave di quelle medioevali perché arrivarono dopo il Rinascimento, ovvero dopo che la civiltà conobbe un’epoca di avvicendamento scientifico e razionale per il quale le torture sarebbero dovuto apparire non più concepibili.
Il Viceré di Madrid e il Papa: la Chiesa, la strada e il Palazzo
Il tempo è la tortura peggiore. Porre un essere umano in un loculo di pochi metri cubi, murarlo li dentro a vita, dovrebbe andare contro la professione del Vangelo. Non è questo il foglio per disquisire di massime storiche – vale solo soffermarsi su come la pena inflitta alla monaca rispondeva in realtà a una guerra di presunzione tra la Chiesa di Milano e il governatore spagnolo a Viceré di Madrid. Erano tempi quelli in cui si dibatteva ancora se fosse il Re a dover cedere il passo al Papa, o se fosse il Papa a dover adattarsi alle decisioni di un Re. Il delitto era compiuto da una donna di chiesa e così apparve più grave e drammatico rispetto a un crimine compito da un uomo mondano. Dentro il Convento la regola si voleva supporre raggiungesse una chiarezza tale da dare esempio ai poveri peccatori persi per le strade. Federico Borromeo si vide chiamare in causa dallo scandalo: la sua Chiesa era marcia quanto il Palazzo – solo che il Palazzo era per definizione corrotto, mentre la Chiesa si vantava in purezza.

Marianna di Leyva, Contessa di Monza e Palazzo Marino
La pena per l’anima che infangava la Chiesa fu ancora più emblematica di qualsiasi pena inflitta ai condannati dal tribunale del Re. Non soltanto: qui si trattava di punire una donna nobile, scelta da Dio per doppia grazia, cattolica e aristocratica. Marianna de Leyva era monaca ed era contessa, figlia di conte, signora di Monza. La Chiesa non avrebbe potuto perdere l’occasione di dimostrare al governatore che, quelle poche volte chiamata a redarguire, la Chiesa era pronta a punire i suoi figli con una potenza per la quale il Re stesso doveva provare timore.
Il processo a Marianna, Monaca e Contessa di Monza, fu accanimento. L’attenzione era trasversale – il popolo, il governo, la curia. Un caso così celebre che due secoli dopo, il Manzoni ne fece un romanzo dentro il romanzo, riuscendo con tali capitoli a dare un contesto politico, temporale, e di costume che difficilmente il resto della finzione avrebbe potuto costruire.
In questi giorni, e per i prossimi mesi, Palazzo Marino a Milano è coperto da un’impalcatura. La facciata frontale su Piazza della Scala è compieta, quella laterale è sotto restauro – per tale lavoro Diego Della Valle ha contribuito al finanziamento. Camminando lungo il cantiere, sulle paratie a livello d’occhio umano, un disegno a cartone infantile ripercorre la storia del palazzo. Un’occasione sprecata, come molte altre: le cronache sono approssimative, pensate per quei turisti che sommariamente vogliono informarsi tra uno svago e l’altro e liquidando quei poveri pochi che invece vorrebbero saperne di più – e non dico molto di più, dico quel minimo che possa permettere una didascalia la cui serietà sia idonea a una sede istituzionale quale l’ufficio del sindaco di una metropoli europea. Tanto è, c’è sempre il motore americano di Alpha, ovvero Google, che può aiutare a comprendere la storia italiana.
Alessandro Barbero, Carlo Magno e gli editori
Troviamo consolazione nell’ammirare il successo di Alessandro Barbero – come se potessimo tornare a respirare: non esistono solo i social media. I libri qualcuno continua a leggerli. Arriva questo professore pronto alla pensione che ci parla delle ragioni che portarono al primo conflitto mondiale; che ci parla dell’incoronazione di Carlo Magno e che riempie i teatri con le sue lezioni. Non esiste solo un intrattenimento a frase breve, istantaneo e leggero. C’è gente ancora che vuole approfondire, che entra nel dettaglio, che non si annoia se gli viene chiesto di stimolare la conoscenza, di provocare la cultura. Gli editori pensano che il loro lavoro sia quello di promuovere libri tramite i social media; cercano libri e prodotti editoriali che a tale promozione siano idonei, anzi, che di tale promozione siano catalizzatori. Tutto deve essere veloce e immediato e comunicabile – il linguaggio deve essere quello di una didascalia perché bisogna cogliere un’attenzione che è labile. Stupido io che credo ancora ai collegamenti complicati e complessi, alla scrittura che conduce il flusso di pensiero, alla tempesta di un romanzo fiume.
La famiglia Marino, il Conte di Monza, il feudo ai Durini
Palazzo Marino era proprietà della famiglia Marino, alla quale è dovuto anche il nome di una tra le vie alberate di Milano, via Marina. Virginia Marino, l’unica erede, sposò Martino de Leyva, aristocratico spagnolo, che aveva ottenuto dal sovrano sia il titolo di Principe di Ascoli, sia il titolo di Conte di Monza. Palazzo Marino fu portato in dote alla famiglia di Leyva. Quando Virginia morì di peste decise che ad ereditarlo sarebbe stata sua figlia, Marianna, con usufrutto al padre. Sembra la storia di Cenerentola, ma con fine pessima. Il padre di Marianna, il conte, si risposò; fece altri tre figli e mandò Marianna in convento così che il palazzo e tutta la ricchezza potessero andare ai maschi di secondo nozze.
Marianna fu titolare del feudo, per una regola secondo cui avrebbe legiferato a circolo di due anni, alternandosi ai due fratelli. Il titolo e il rango passavano, due anni a testa, su tutti gli eredi. I fratelli di Marianna vendettero il feudo di Monza ai Durini – nel 1652 il Re di Spagna riconobbe il passaggio del titolo, e alzò ad aristocratica una famiglia di commercianti di tessuti che arrivavano da Como. A Milano, parte da piazza San Babila, la Via Durini, con il palazzo Durini che può dare segno delle risorse abbienti dei nuovi conti. La Contea di Monza potrebbe quindi apparire come una banale operazione finanziaria e commerciale, senza supremazia storica che ne possa valere il rispetto e la reverenza. Questo se non fosse che nella sua cattedrale, nel Duomo di Monza, non fosse tutt’oggi custodita la corona che più di altre corone ha segnato la storia d’Europa.
La Corona Ferrea, Teodolinda, la Lombardia e la Monaca di Monza
La Corona Ferrea deve il suo nome a una struttura metallica circolare a cui sono saldate le placche dorate e decorate con pietre. La leggenda vuole che questa struttura sia stata ottenuta fondendo e rimodellando uno dei chiodi della croce di Gesù, e per questo è trattata quale sacra reliquia. Le ultime analisi scientifiche hanno decretato che di ferro, nel gioiello, non v’è traccia.
Pazienza – la leggenda persisterà secondo la fede cattolica così come ha fatto per quasi due millenni. Henry Melville in Moby Dick parla della corona di ferro di Lombardia – mentre è uso considerarla la corona di Teodolinda regina dei Longobardi. Passò per le mani di Carlo Magno, anche se non si è sicuri che mai la indossò. I sovrani tedeschi del Sacro Romano Impero la usarono come emblema di autorità, e così la casa di Asburgo fino a Ferdinando che al Sacro Impero pose fine. La Corona Ferrea fu di Napoleone – quando disse che Dio gliela diede, e nessuno mai gliel’avrebbe tolta. I Savoia, Re d’Italia, furono incoronati con la Corona Ferrea.
La Corona appare sia nello stemma del Regno d’Italia, sia nello stemma della famiglia Durini. Qualche mese fa ero in metropolitana di mattina, e una classe di ragazzini alle elementari stava tornando da una lezione fuori sede che aveva avuto luogo al Museo di Monza. La feci anche io quando ero un bambino – la maestra ci portò in gita a vedere la Corona. Uno dei ragazzini, poco distante da me, disse a un suo compagno che la Monaca di Monza era sua zia. Mi fece sorridere – e gli rivolsi parola, gli chiesi come mai, la Monaca era sua zia, come faceva a saperlo? Il bambino mi guardò un poco sgomento, infastidito e incuriosito, che un adulto gli desse retta.