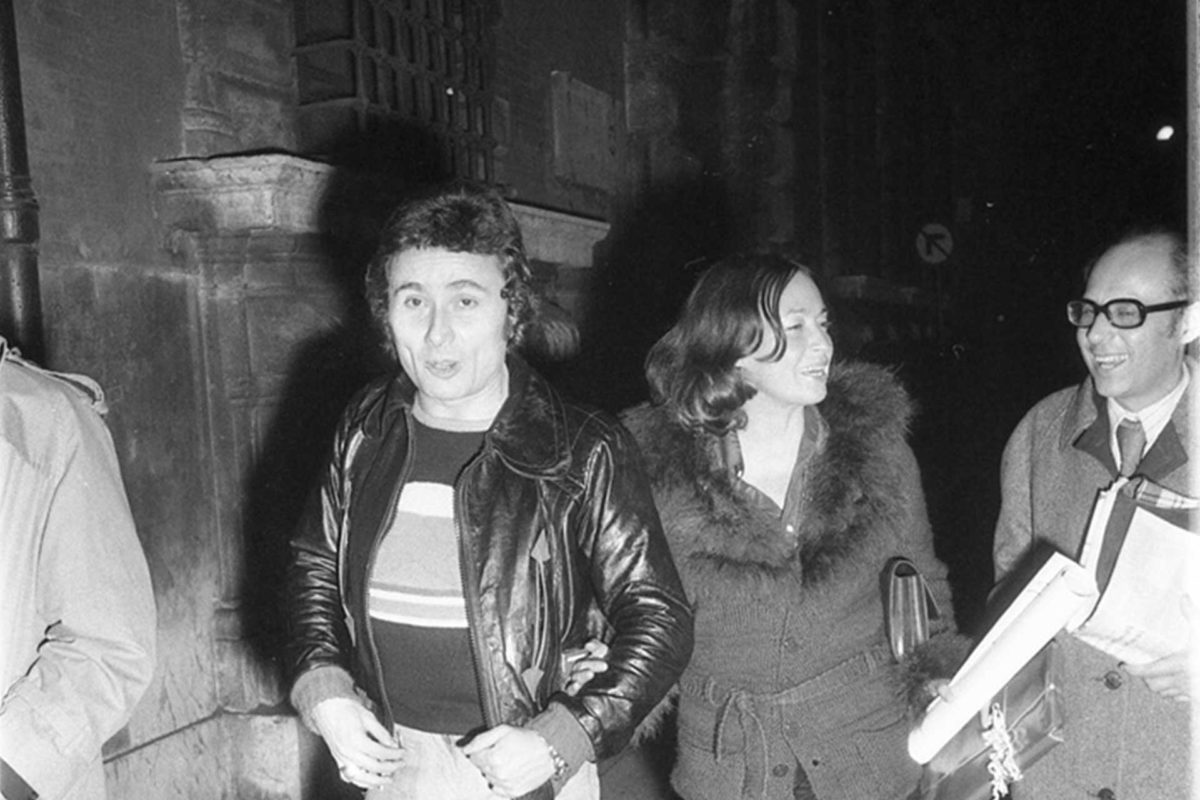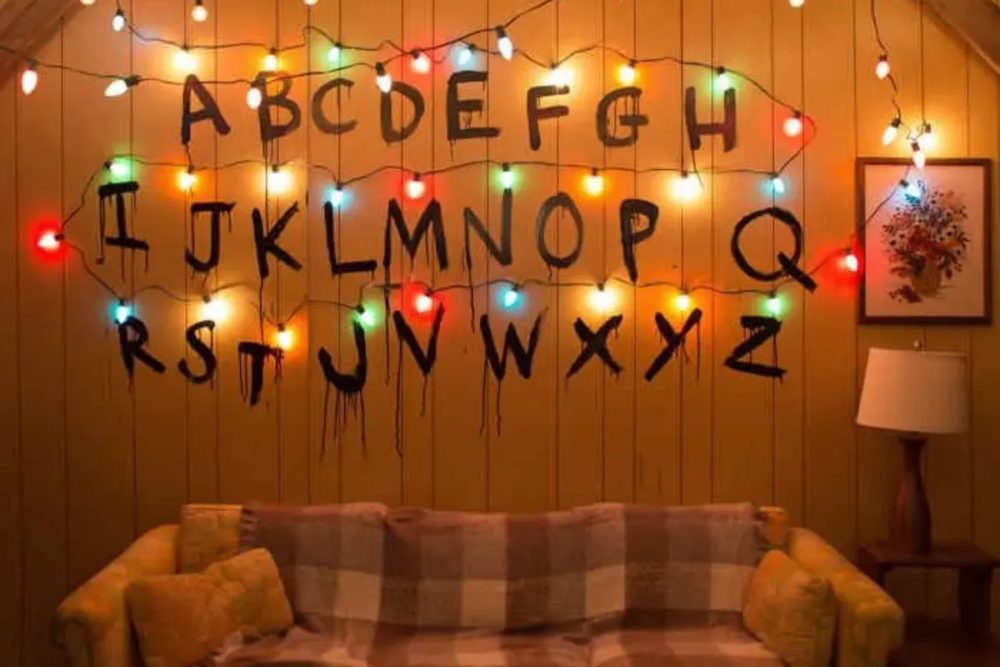Nicola Piovani e i suoi registi: Fellini, Bellocchio, Moretti
Il flusso di pensiero: Nicola Piovani parla di composizione per il cinema, duecento film, il rapporto con alcuni tra i tanti registi con cui ha lavorato: Federico Fellini, Marco Bellocchio, Nanni Moretti
Nicola Piovani, Biennale del Cinema di Venezia, 31 agosto 2024. Introduzione, informazioni e premessa
Una mattina di fine agosto, ai bordi dei campi da tennis del Lido di Venezia, Nicola Piovani si lascia andare a qualche aneddoto, per una carriera che potrebbe valere l’aggettivo mostruosa, intesa come meraviglia. Oltre duecento film; i registi che contano in cinematografia, della seconda metà del Novecento fino a oggi; premi della critica in Italia e Francia; l’Oscar per La Vita è Bella di Benigni; quanto altro.
Questo testo è reso possibile grazie a Cartier, in qualità di sponsor della 81° Mostra del Cinema, della Biennale di Venezia. L’immagine nel corpo è uno scatto del concerto tenuto da Nicola Piovani per Cartier, la sera del 30 agosto 2024 ad Open Space a Venezia.
Nicola Piovani, compositore che costruisce accanto
La musica quando arriva? È la domanda che Nicola Piovani si pone per accendere un suo personale flusso di pensiero. «Il compositore legge il copione, si crea un rapporto col regista: i due si parlano, si capiscono. Il compositore assiste a una prima visione del lavoro già completo del regista». Nicola Piovani dice di aver sempre costruito accanto. Il regista e il compositore sono due artisti con linguaggi diversi: è il compositore che penetra nel linguaggio del regista e lo trasforma.
«Ruggero Mastroianni, il fratello di Marcello, era un montatore. Niente musica, diceva, il montaggio per andare bene deve funzionare senza musica, perché la musica nasconde i difetti del montaggio. Un buon montaggio possiede il suo ritmo – poi si aggiunge la musica. Questo è il vecchio artigianato, la vecchia scuola che si sta un poco perdendo, quando si monta subito con la musica». Può succedere che il montaggio proceda con una musica che non è quella definitiva, e così può succedere che il regista si abitui a questa musica provvisoria, magari edita o estemporanea, e diventa poi difficile sostituirla con la musica originale, composta appositamente.
Nicola Piovani e Fellini: l’elasticità e il montaggio senza musica
«Federico Fellini diceva che la prima abilità di un musicista da cinema deve essere l’elasticità. Una frase un po’ estrema. Se io scrivo una ballata, una cantata, un preludio, faccio i conti con la mia poetica. Se fai un film, certo, devi immedesimarti nella poetica dell’autore di quel film. Non puoi sfarfallare – ma la dissidenza è d’obbligo». Nicola Piovani si lascia prendere dalle sue parole, se ne lascia travolgere: «Il piano estetico cercato dal regista conta, sicuramente, ma per me conta di più il ritmo della storia. Non vogli essere frainteso: chiaramente il film deve avere la sua estetica, altrimenti non è un film. Per me il cinema è carne. Quello che mi eccita a trovare idee musicali, sono le sequenze, le facce degli attori».
Il pianoforte, Fellini e la proiezione – il film troppo gonfio
Ginger e Fred (1986). Due sequenze sono fatte solo col pianoforte. C’è un motivo, c’è una storia. «Eravamo la mattina a lavorare in moviola. Fellini mi dice, “oggi pomeriggio facciamo una proiezione per i distributori francesi e americani. Vogliamo farglielo sentire un po’ di musica?” Abbiamo fatto portare un pianoforte verticale. I temi li avevamo già scelti, piazzati, avevamo un’idea chiara. Come si faceva con il cinema muto – il film scorreva, e io suonavo dal vivo – così abbiamo presentato il film quel pomeriggio. Quando poi arrivò il momento di registrare in sala, io portai il tema orchestrato. Dopo un poco che il lavoro proseguiva, Fellini mi chiese se non mi sembrava troppo gonfio. Iniziammo a togliere alcune parti, i fiati, gli archi. Dopo una pausa, tagliò via: “perché non lo lasciamo il pianoforte solo che era tanto bella?”»
Questo è uno dei casi in cui si affeziona alla prima, e così l’ho registrata al pianoforte solo. Nel cinema, in genere, non si usa il pianoforte da solo. Ti dà l’idea che ci sia qualcuno che suona nell’altra stanza. Non sembra un commento. In quel film c’era una ragione: nella trasmissione televisiva dove i due protagonisti arrivano, l’introduzione era fatta col pianoforte solo, con questo tema, quindi c’era una logica narrativa. «Anche per questo, ha funzionato», Nicola Piovani lo sottolinea.
Il pianoforte non è un timbro definitivo, è un modo per intendersi con un regista, perché il pianoforte è un’astrazione. Ascoltando un progetto musicale al pianoforte, bisogna farne la proiezione. Il regista la farà in un modo, il compositore che ce l’ha in testa, la farà in altro modo, sapendo che non c’è solo il pianoforte. C’è lo sguardo, c’è la reazione, c’è la parola.

Il rapporto tra musica e immagine: un film deve avere pochi temi
La musica tende a coprire l’immagine. Non solo un montaggio claudicante, ma tende qualche volta a coprire anche una scena che il regista ha sbagliato, quando il problema non è soltanto del montatore. Può capitare che ci sia una sequenza che non ha l’energia che deve avere, che c’è qualche cosa che non va e allora la musica aiuta. «Ci sono registi che usano la musica come fosse dentro la scena. Scorsese, per esempio. I francesi dicono che i film italiani hanno troppa musica». Un film deve avere pochi temi. Un nodo centrale che viene variato. Un tema è il tema del film, e intorno ci sono le variazioni.
Oggi succede che gli spettatori più giovani siano abituati a questi film, americani, con molta musica – e se arriva una scena senza musica, pare loro eterna. Vale qui come per tutto: il troppo annienta. Se c’è troppa musica, l’effetto della musica sul colpo di scena, sulla narrazione in genere, diminuisce.
«Bisogna avere un minimo di pazienza. Come nel teatro d’ombra. Se c’è uno stop di recitativo che vuole lanciare in grande la scena successiva, se noi perdiamo questo atto di fermo, di rallentamento o di silenzio, arriviamo al piattume pubblicitario».
Nicola Piovani e Nanni Moretti – Caro Diario (1993) e La Stanza del Figlio (2001): non saperne niente, non vederne niente
La tensione e la pressione. «Preferirei avere otto mesi per lavorare a un film – non succede così. Nanni Moretti, l’episodio di Caro Diario. Aveva lavorato con altri, ma il risultato non gli funzionava. Mi ha chiamato e mi ha detto che se avessi voluto provarci, avrei avuto una settimana di tempo. Gli ho detto di farmici pensare. Ero affascinato dalla sfida. La mattina dopo dico va bene, ci provo – mi risponde, allora ti do due settimane». Nicola Piovani passa a un altro film di Nanni Moretti su cui ha lavorato in musica, La Stanza del Figlio (2001). «Siccome il lavoro che abbiamo fatto su Caro Diario gli era piaciuto, Moretti si era fissato: non voleva che leggessi niente, che vedessi niente – voleva che avessi poco tempo per lavorarci».
«Ne avevo solo letto qualche fuga di notizia sui giornali, sapevo che il tema era il dolore più grande possibile per un genitore. Quando il montaggio era quasi finito, sono andato una mattina a una proiezione di fase intermedia. Nanni si era seduto dietro di me e cercava di capire da come muovevo la bocca se il film mi stava piacendo. Il pomeriggio stesso ho cominciato a scrivere sulla prima impressione. Con totale innocenza, ho guardato questa storia. In quegli anni avevo due figli di un’età simile al ragazzo della storia, ero turbato e compreso. Il dolore più che la tragedia della perdita. Una vita senza, la malinconia sadica dell’assenza, perché? Nel dolore tragico c’è la presenza – qui c’era solo movimento e ritmo».
Nicola Piovani e Marco Bellocchio: due note, quattro note, mille note
«Marco Bellocchio è stato il mio primo maestro, abbiamo fatto insieme otto film. Resta un pilastro della mia formazione. Resta un amico, di quelle che si dice a Roma, non c’è bisogno neanche di frequentarsi». Salto nel vuoto (1980). Un giudice borghese pieno di fobie e nevrosi entra dentro casa e trova la stanza devastata. Per la paura, si chiude in uno sgabuzzino. Comincia un suo delirio visionario – perché da questo nascondiglio, vede, immagina un gruppo di bambini come ladri che distruggono il suo studio: fogli, libri, oggetti, in aria, buttati dalla finestra. «All’inizio ci sono due note soltanto – e mentre la foga dei ragazzini aumenta, aumentano anche le note, e le parti dell’orchestra. Due note, quattro note, mille note. La guerriglia diventa un valzer vorticoso. Per la composizione, è uno schema semplice, quasi banale – ma da notare è il rapporto con le voci dei bambini nel missaggio. All’inizio ci sono le urla, sopra la musica – poi la scena procede, e la musica sale oltre le urla e le copre, producendo una descrizione della follia che la regia e la recitazione da sole non avrebbero potuto consegnare. Si può definire la silenziazione della recitazione».
«C’è una domanda, che è pura retorica, che affrontai con Fellini: perché due note seguite da una pausa più un’altra nota più una pausa – ovvero, tre note in sequenza – hanno la capacità di strangolarti? Perché? di cosa parla, a chi? Fellini diceva: io guardo i musicisti come delfini eroici, astronauti che si espongono».
Nicola Piovani e Fellini, La Voce della Luna (1990): il tema per l’oboe
«Federico Fellini andava in panico per la musica perché diceva “mi commuove perché non parla di niente”. Sul lavoro si dimenticava di tutto, gli venivano gli occhi rossi. La voce della luna (1990). C’era una scena in cui un vecchio oboista d’orchestra voleva seppellire la musica. Perché voleva seppellire la musica? Perché la musica è bugiarda, diceva nel film. Perché la musica promette, promette e non mantiene mai niente. Promette che tutto ci sarà riscatto per tutti, che anche il dolore può essere bello, o almeno dovrebbe. Niente». Nicola Piovani riassume la trama: l’oboista suonava un tema sull’oboe a casa sua, poi andava nel giardino, scavava una buca, ci metteva dentro l’oboe e lo seppelliva pensando di aver seppellito la musica. Tornando a casa, dalla terra, emergeva la musica, e questa musica inseguiva il vecchio oboista. Il film era una sorta di favola o metafora, per dire che la musica non si può fermare, non si può certo seppellire».
«Dovevo scrivere il tema per l’oboe protagonista: dovevo scrivere una musica che, in questo caso specifico, non era solo accompagnamento ma era il fuoco dell’intera storia. Io scrivo il tema e vorrei farglielo sentire, a Fellini. Lo chiamo, Fellini mi risponde che sta andando in sopralluogo, “poi domani ti chiamo, e lo sento”. Niente, comincia a girare il film senza sentire quello che avevo scritto».
«Ero preoccupato. Fellini non si faceva più sentire. A un certo punto mi chiamò la produzione e mi disse, “Guardi, dopodomani dobbiamo girare la scena dell’oboista”. Allora io subito chiamai un oboista di professione: l’attore avrebbe finto di suonare e l’oboista dietro la cinepresa avrebbe svolto il tema. Chiamai Fellini, e mi imposi, gli chiesi di venire a sentire il pezzo. “E vabbè, la sento domani mattina, stai tranquillo”. La mattina andai, Fellini stava facendo tutt’altro. Lo presi quasi di forza e lo portai lì, dall’oboista, gli dissi: “Senti la musica, dimmi che ne pensi, che se non ti piace faccio ancora in tempo a modificarla”. L’oboista suonò il tema e Fellini disse. “Va bene. Sì, sì, va bene” – ma con la faccia diceva tutt’altro. Io insistei: “Se non va bene, te lo ridico, ne facciamo un altro, di tema. Troviamo qualcosa d’altro”. “No, no, la musica va bene. È bellissima”. Io continuavo a vederlo perplesso. Fellini allora guardo lo strumento e mi disse: “Ma questo è l’oboe? Io me lo immaginavo tutto diverso”. Mi fece un disegnino dal quale capii subito che quello che aveva in mente era il fagotto, non l’oboe. Gli dissi di darmi due ore che avrei recuperato un fagottista, e che avrei adattato il tema a un fagotto. Fellini mi rispose: “Nicola, se il cielo ci ha mandato l’oboe, teniamocelo”».
Carlo Mazzoni