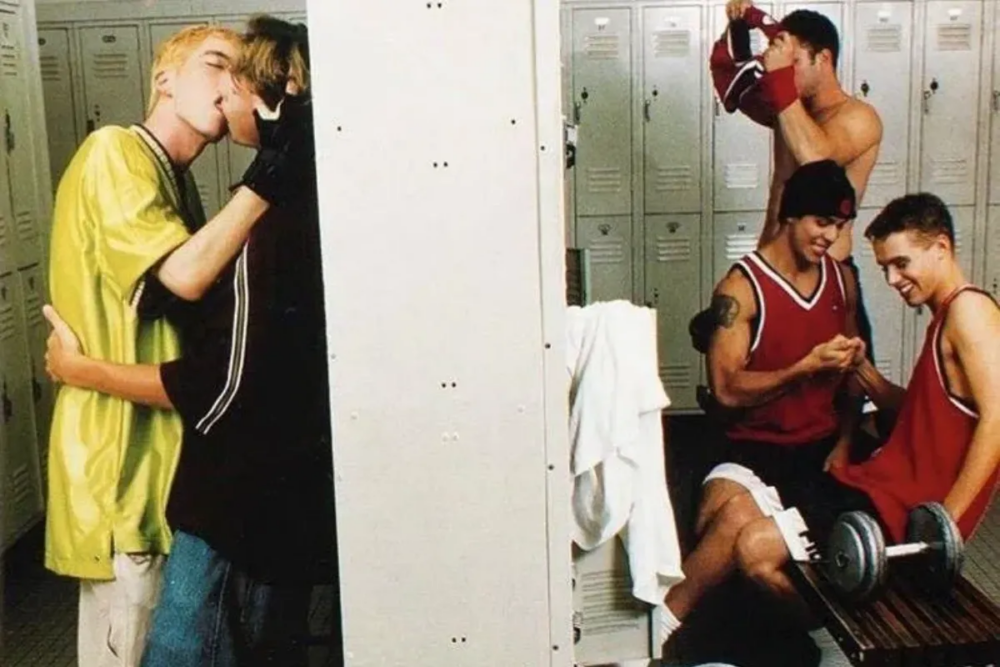Open House Milano: dieci anni di città aperta tra architettura, acqua e soglie
Tra case-scrigno, teatri ritrovati e quartieri in trasformazione, il volume del decennale di Open House Milano offre chiavi di lettura per una metropoli che si ricompone per frammenti e pratiche dal basso
Un atlante corale per i dieci anni di Open House Milano
Milano è una città che si comprende solo attraversandola – tra acque, architetture, cortili nascosti e margini. È da questa intuizione che nasce “D’Acqua e Soglie. Milano”, il volume ideato da Lucia Mannella e Maya Plata, co-direttrici di Open House Milano, pubblicato in occasione del decennale dell’iniziativa e presentato alla Triennale di Milano durante Arch Week – Inequalities and Architecture. L’opera è un atlante visivo e narrativo che raccoglie dieci anni di aperture, percorsi e racconti urbani. Pagine di immagini, saggi e progetti che costruiscono un ritratto plurale della città, tra memoria, trasformazione e futuro.
Open House Milano: un progetto culturale per una città aperta
Nato nel 2015 come parte del network internazionale Open House Worldwide – attivo in oltre cinquanta città nel mondo, da Londra a New York, da Barcellona a Buenos Aires – Open House Milano è un progetto di divulgazione architettonica e cittadinanza attiva che ogni anno, in un weekend di primavera, apre gratuitamente centinaia di edifici pubblici e privati normalmente non accessibili.
Palazzi storici, studi di architettura, fabbriche riconvertite, teatri, case private e spazi di lavoro diventano luoghi visitabili, raccontati direttamente da chi li ha progettati o li vive ogni giorno. Negli anni, l’iniziativa ha coinvolto migliaia di visitatori, progettisti, studenti e volontari, trasformando la curiosità per l’architettura in una forma di partecipazione civica. Il suo motto – “aprire per condividere” – riassume una filosofia che va oltre il turismo urbano: creare connessioni tra spazio e cittadinanza, tra architettura e vita quotidiana.
Il libro D’Acqua e Soglie. Milano nasce proprio per celebrare questo percorso, restituendo una mappa collettiva della città attraverso le storie dei suoi luoghi e delle persone che li attraversano.

Milano, città d’acqua e di passaggi
Il titolo – D’Acqua e Soglie – sintetizza un doppio sguardo. L’acqua, elemento fondativo della città, diventa metafora di movimento e riflessione: dai Navigli e rogge ai vetri che oggi riflettono e scompongono il paesaggio urbano. Le soglie, invece, rappresentano l’apertura e la relazione: porte, atri, cortili e passaggi che uniscono interno ed esterno, privato e pubblico, noto e inedito. Il libro, realizzato con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia e Ordine degli Architetti PPC di Milano, si pone come strumento di lettura e orientamento, invitando a esplorare, più che a descrivere.
Sei sezioni tematiche, sei prospettive che si intrecciano come le vie e i canali milanesi: il passato e il futuro, il lavoro e la casa, la cultura e la spiritualità, la cittadinanza e la rigenerazione. Non un’indagine accademica, ma un vero e proprio atlante narrativo della città viva, letto attraverso i luoghi e le persone che la abitano e la costruiscono ogni giorno.
Franco Raggi e la città tra memoria e futuro: Milano come paesaggio condiviso
Il volume si apre con una riflessione dell’architetto e designer Franco Raggi, figura storica della cultura progettuale milanese e tra i protagonisti del dibattito sull’identità urbana dagli anni Settanta a oggi. Raggi osserva la trasformazione di Milano a partire dal dopoguerra, mettendo in luce la perdita progressiva di una visione collettiva dello spazio pubblico. La città del boom economico, ordinata e civile, ha ceduto il passo a una metropoli frammentata, spesso guidata da logiche immobiliari più che da principi di urbanità.
Eppure, nel suo sguardo non manca la speranza. L’autore individua segnali di rinascita in una nuova attenzione alla scala umana, al verde, alla mobilità sostenibile, alla partecipazione. Raggi cita esempi come il Complesso Monte Amiata, progettato da Carlo Aymonino e Aldo Rossi nel quartiere Gallaratese, come modello di architettura sociale capace di creare relazioni e spazi condivisi. È in questa tensione, tra memoria e rigenerazione, che l’architetto individua il vero orizzonte della città contemporanea.

Francesco Rovere e la metamorfosi degli spazi del lavoro: gli uffici come infrastrutture civiche
La seconda sezione, curata da Francesco Rovere, Senior Development Manager di AXA IM Alts, affronta il tema della trasformazione degli ambienti di lavoro. Rovere racconta come gli edifici per uffici siano diventati oggi luoghi aperti, permeabili, connessi con la vita pubblica della città. Nel suo racconto prendono forma esempi della nuova Milano produttiva.
Il primo è Monte Rosa 91, progettato da Renzo Piano Building Workshop, che da tradizionale complesso direzionale si è trasformato in un campus urbano accessibile, con giardini, ristoranti e spazi culturali aperti al quartiere. Il secondo è il Vetra Building, in piazza Vetra, ex esattoria civica riconvertita in sede contemporanea dove arte, lavoro e convivialità coesistono. Rovere legge in questi interventi una vera rivoluzione: l’ufficio che diventa infrastruttura civica, capace di ospitare non solo l’economia ma anche la relazione e la cultura, secondo lo spirito più autentico di Open House Milano.
Francesca Taroni e l’abitare come paesaggio interiore: Milano dentro le sue case
Con la terza sezione il racconto entra nelle case e negli interni, guidato dalla voce di Francesca Taroni, direttrice delle riviste Living e Abitare. Taroni indaga l’universo domestico come paesaggio interiore e specchio della città. La sua Milano è fatta di spazi reinventati e luminosi, dove il design dialoga con la memoria. Case nate da ex opifici e laboratori artigianali, riconvertite in abitazioni creative.
Casa Cescolina2 di Nomade Architettura nel quartiere Lambrate, è una residenza-laboratorio aperta alla luce e alla sperimentazione; The BotanicaLoft di Isola Design Studio, abitazione-showroom immersa nel verde nel cuore del quartiere Isola; Casa TOOOP Frame dello studio debatelier, manifesto di architettura sostenibile e artigianale; e Casa Studio Aricò, nel quartiere NoLo, dove vita e lavoro convivono in un unico spazio poetico. In tutte, emerge una costante: la capacità di Milano di reinventare il proprio modo di abitare, mantenendo sempre un dialogo vivo con il suo tessuto urbano e con la cultura del progetto.

Dario Bolis e la doppia anima di Milano: tra culto e cultura, i luoghi che uniscono la città
La quarta sezione, curata da Dario Bolis, direttore della comunicazione di Fondazione Cariplo, mette in dialogo due dimensioni apparentemente opposte ma intrecciate: il culto e la cultura. Bolis esplora spazi che, pur nati con funzioni diverse, oggi condividono la stessa vocazione civile, quella di tenere unita la comunità attraverso la bellezza.
Ne è esempio il Teatro Gerolamo, piccolo gioiello ottocentesco di piazza Beccaria, rinato come spazio di musica e teatro contemporaneo; la Fondazione Vico Magistretti, nell’ex studio dell’architetto in via Conservatorio, che custodisce archivi e progetti trasformando il luogo di lavoro in museo didattico; Assab One, ex tipografia industriale oggi centro d’arte contemporanea e laboratorio di ricerca; e la Chiesa di San Giovanni Bono, progettata da Arrigo Arrighetti nel quartiere Lorenteggio, una delle architetture religiose più radicali del dopoguerra. Bolis mostra come questi luoghi, tra spiritualità e cultura, rappresentino la vera infrastruttura simbolica di Milano: spazi di memoria, apertura e dialogo, dove la città riconosce se stessa.

Elisabetta Bianchessi e la città che si apre dal basso: arte pubblica, quartieri e cittadinanza attiva
Con il testo di Elisabetta Bianchessi, urbanista e community designer, il volume si sposta nei margini della città, là dove nascono i processi di trasformazione dal basso. Bianchessi racconta una Milano vissuta e partecipata, dove i quartieri diventano laboratori di innovazione sociale e culturale.
Progetti come OR.ME – Ortica Memoria, museo diffuso realizzato dal collettivo OrticaNoodles, raccontano attraverso murales la storia del Novecento milanese; Tunnel Boulevard, nel sottopasso di via Pontano, ha trasformato un luogo marginale in corridoio urbano grazie a street art e co-progettazione; il programma Piazze Aperte, promosso dal Comune di Milano, ha restituito oltre quaranta piazze ai cittadini attraverso interventi di urbanistica tattica; mentre ArtLine Milano, nel parco di CityLife, ha portato opere d’arte contemporanea nello spazio pubblico, creando un museo all’aperto nel cuore del quartiere dei grattacieli. La città è davvero “aperta” quando la cultura e la cura dello spazio nascono dal basso, da cittadini e comunità che diventano co-autori del proprio ambiente.

Barreca & La Varra e il futuro della rigenerazione urbana: Milano come laboratorio del possibile
La sezione conclusiva, firmata dagli architetti Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra, fondatori dello studio Barreca & La Varra, è dedicata alle nuove prospettive della rigenerazione urbana. Gli autori, protagonisti di trasformazioni milanesi, riflettono su una fase storica in cui il progetto non riguarda più l’espansione ma la ricomposizione della città esistente.
Milano è il laboratorio di questa transizione, come dimostrano interventi come ARIA – Ex Macello, nel quartiere Calvairate, che trasformerà gli ex macelli comunali in un distretto di social housing e innovazione; 5Square, al Vigentino, dove cinque edifici abbandonati sono diventati un nuovo quartiere residenziale; Open 336, in viale Sarca, che reinterpreta il patrimonio industriale della Bicocca in chiave sostenibile; e il Nuovo Policlinico di Milano, destinato a diventare il più grande ospedale-giardino d’Italia.
Per Barreca e La Varra, la rigenerazione non è un’operazione estetica, ma un gesto civile: il progetto deve ricucire, non sostituire. Le nuove architetture, scrivono, non nascono per stupire ma per costruire senso, restituendo spazi di vita, salute e comunità.
Matteo Mammoli