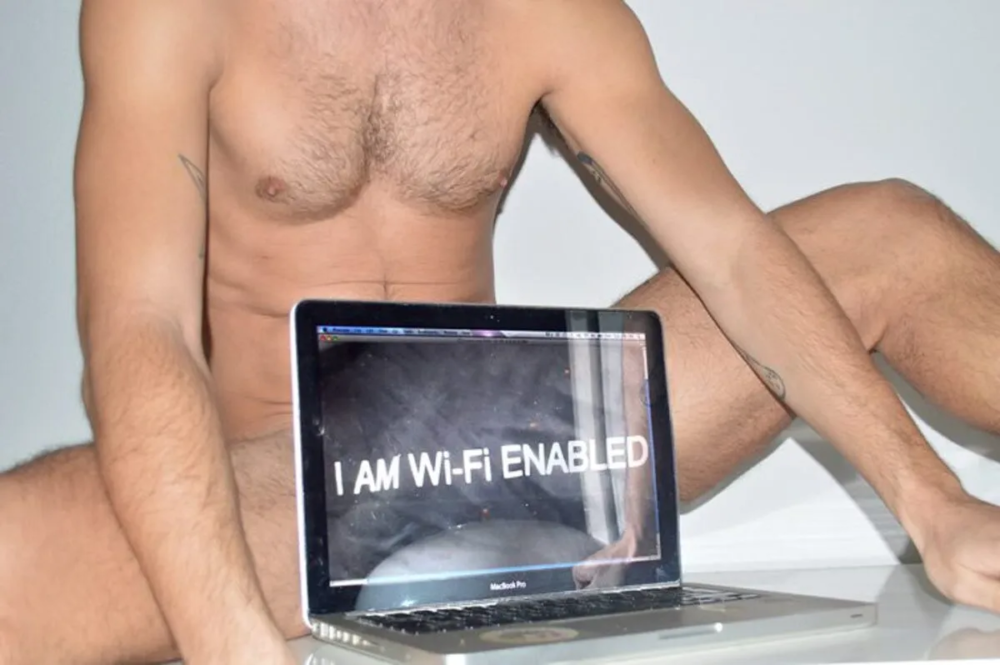Le Palazzine di Roma, gli architetti e i Palazzinari: storie postmoderne di architettura
La palazzina prese forma nell’ambiente di una classe alto borghese aperta al dibattito culturale internazionale – uno strato sociale ricco di sfumature e contraddizioni
Palazzina: tipologia architettonica simbolica a Roma
La palazzina rappresenta una tipologia architettonica simbolica a Roma, che si estende dalla metà degli anni Trenta (dopo il piano regolatore del 1931) ai primi anni Ottanta. Riecheggia nella letteratura italiana—da Moravia e Gadda ai romanzi di Giorgio Montefoschi ambientati ai Parioli—e nel cinema d’autore, in particolare nelle opere di Antonioni e Fellini. Col tempo è divenuta anche l’ambientazione prediletta di un certo filone della commedia all’italiana.
Avvicinandosi all’epoca contemporanea, la Palazzina Girasole di Luigi Moretti (1947-50), affacciata su Viale Bruno Buozzi ai Parioli, è stata immortalata dai percorsi in motorino di Caro Diario (1992). Moretti progettò inoltre la Stock Exchange Tower di Montréal (1960) e il complesso del Watergate a Washington (1961). In Complexity and Contradiction in Architecture Robert Venturi si chiede se quella massa—al contempo simmetrica e asimmetrica, con il taglio centrale di Fontana—sia un unico edificio segnato da una frattura interna o piuttosto due strutture adiacenti.
I progetti eclettici di Venturino Ventura
L’atrio che compare in Il Tigre (1967, regia di Dino Risi) appartiene alla palazzina di Via Flaminia progettata da Venturino Ventura. A lungo liquidato da alcuni come semplice professionista, Ventura propose uno stile provocatorio e refrattario alle norme in tre opere romane di riferimento: la palazzina del 1968 in Via Bruxelles; l’edificio del 1969 in Via Piccolomini, con parapetti in legno a vista e vetro; e la struttura del 1961 in Via Gomenizza.
Qui balconi ottagonali e ascensori esterni scandiscono la facciata. Ferro e cemento armato sono spinti ai limiti delle loro possibilità tecnologiche e plastiche. Nell’atrio d’ingresso si erge una foresta di pilastri biforcuti simili ad alberi. Legno, calcestruzzo e acciaio zincato dominano la palazzina del 1960 tra Via Montanelli e Via Nicotera, mentre i balconi circolari su ognuno dei tre angoli del piano triangolare evocano torri fiabesche.
La visione di Ventura—la sua prima opera di rilievo fu la torre per la Mostra d’Oltremare di Napoli (1938)—sovrappose negli anni Cinquanta gli ideali del Movimento Moderno all’architettura organica, traendo spunto da Frank Lloyd Wright. Anche le correnti sperimentali del Team 10, annunciate con il Doorn Manifesto del 1953, alimentarono le sue riflessioni espressioniste. Emergono così elementi onirici e difficili da classificare, che creano effetti scultorei quasi teatrali.
Venturino Ventura (1910-1991), più eclettico che manierista e mai minimalista, nacque a Firenze in una famiglia ebraica. Scrisse un manoscritto di 500 pagine, La Città Condannata, in cui condensò la sua visione utopica delle metropoli future. Scomparso misteriosamente, il testo circolò solo tra pochi lettori, tra cui lo storico Fabio Mangone, che ricorda l’interesse di Ventura per il Metabolismo giapponese dei primi anni Sessanta, movimento che vedeva l’architettura come un processo evolutivo dall’atomo alla nebulosa.
Origini barocche della palazzina romana
Il termine palazzina a Roma risale ai primi del Settecento, quando Filippo Raguzzini costruì tre piccole case d’appartamenti in Piazza Sant’Ignazio, affittandole senza cortile interno. Critici influenti come Aldo Natoli e, soprattutto, Antonio Cederna denunciarono poi la palazzina quale simbolo della speculazione edilizia senza scrupoli. Gli architetti modernisti, propugnatori di una città più razionale e pubblica, la consideravano un retaggio individualista, staccato da qualunque dimensione collettiva.
Nel corso dei decenni, le palazzine divennero un laboratorio di libertà espressiva e sperimentazione d’avanguardia. Secondo Vieri Quilici, la palazzina si colloca a metà strada tra tradizione e innovazione, in una città che da sempre media e compromette: una Roma in marcia verso la modernità, ma che fisicamente non l’ha mai abbracciata del tutto.
Il ruolo politico dei palazzinari romani
Un velo di oblio è calato sui protagonisti creativi di questa vicenda—forse per pregiudizi politici o perché la pluralità dei linguaggi espressivi sfugge a un unico schema ideologico. Il libro di Alfredo Passeri, La palazzina romana: impulsiva e svampita, sostiene che le palazzine di qualità sprigionano energia in una monotona successione di volumi incongrui.
Il dispregiativo palazzinaro (equivalente di “palazzinaio” o “palazzinaro d’assalto”) è divenuto sinonimo di avidità e irresponsabilità. In C’eravamo tanto amati (1974) Ettore Scola, con Aldo Fabrizi, ironizza sul palazzinaro classico. Questi costruttori formavano una casta intrecciata alla politica locale, puntando tutto su successi e fallimenti spettacolari, stringendo accordi con banchieri, mediatori e figure della malavita in una città dai forti contrasti. Questo “esercito di cemento” alimentò paradossalmente un dibattito architettonico più ampio, segnato da contraddizioni e molteplici prospettive.
Architetti di spicco delle palazzine romane
Diversi progettisti—alcuni celebri, altri quasi dimenticati—plasmarono il panorama delle palazzine romane. Oreste Martelli Castaldi, Francesco Berarducci, Luigi Pellegrin, Francesco Palpacelli, Mario Marchi, Mariano Pallottini e Claudio Dall’Olio lasciarono ciascuno il proprio segno con blocchi residenziali distintivi, mentre Angelo Di Castro e Cesare Pascoletti portarono un’impronta volumetrica di chiaro influsso frank-lloyd-wrightiano alla Palazzina Costanzi in Viale di Villa Grazioli (1953-55). Vittorio Ballio Morpurgo, con Del Debbio e Foschini, collaborò al monumentale Palazzo del Littorio-Ministero degli Esteri (1935-59) e alla teca in vetro dell’Ara Pacis (1938), mentre l’architetto-costruttore Alvaro Ciaramaglia intraprese audaci commesse prive di clientela esterna.
Nel 1948 Alberto Carpiceci presentò la cosiddetta “Palazzina Arcobaleno” di Via Guidubaldo del Monte, con intradossi dei balconi in tinte contrastanti sorretti da travi chiare; Giuseppe Perugini stupì con il Villino Borzi in Via San Pancrazio (1948), caratterizzato da balconi a giostra e geometrie ottagonali. Infine, la Villa Crespi a Posillipo (1955) di Davide Pacanowski fuse magistralmente il concetto di Raumplan di Adolf Loos con i volumi austéri di Le Corbusier.
Le palazzine moderniste di Ugo e Amedeo Luccichenti
I fratelli Ugo Luccichenti (1899-1976) e Amedeo Luccichenti (1907-1963) forgiano la Roma modernista nei quartieri Parioli e Balduina. Nel 1938 Amedeo, con Vincenzo Monaco, progettò Villa Petacci in Via Camilluccia—scenario della relazione tra Mussolini e Claretta Petacci—e nel 1950-51 la Palazzina Federici in Via San Crescenziano, celebre per i balconi sporgenti.
Ugo, appannato dalle critiche al colossale Hilton di Monte Mario, realizzò anche la Palazzina di Largo Spinelli 5 e un altro edificio volumetricamente dinamico in Via Fratelli Ruspoli. La palazzina di Via Archimede 105 (primi anni Cinquanta) si distingue per la concezione spaziale avanzata: otto livelli (compreso seminterrato), un corpo scala curvilineo e due cavedi in vetro e acciaio.
La fotografia architettonica di Romain Laprade a Roma
Pur compatte e simmetriche in pianta, le palazzine ritratte da Laprade appaiono asimmetriche e dinamiche. Canali orizzontali separano gli appartamenti sovrapposti, creando un suggestivo gioco di luci e ombre.
«Un giorno, per puro caso» ricorda il fotografo francese Romain Laprade (n. 1988), «mi imbattei nella foto di un edificio residenziale moderno a Roma… Avevo scoperto un aspetto della capitale che non avevo mai visto. Roma è altro rispetto a ciò che credevo. I codici di sicurezza e comfort sono familiari—ampie aperture, finestre continue, materiali pregiati—ma ho trovato elementi inediti: forme arrotondate, un tripudio di ottagoni, ellissi, curve, pensiline… Metallo, vetro, ceramica: una forte presenza di arti applicate per una classe media in ascesa, desiderosa di nuove immagini moderne».
Nella palazzina di Ventura in Via Bruxelles (1968) Laprade ha ammirato i balconi drammaticamente aggettanti—«come un transatlantico incagliato… un brutalismo scolpito addolcito da svolazzi barocchi». La facciata espressionista fonde influssi De Stijl: alte finestre incorniciate di bianco contrastano con balconi di calcestruzzo sinuoso, pilastri a fungo e un’apertura ovale per un cipresso. Dietro il guscio espressionista si cela una facciata interna più sobria, in intonaco rosso mattone, traforata da finestre di camere e servizi. Un grande vuoto interrompe la composizione orizzontale dei balconi, rivelando lo spazio cavo dell’ingresso.
La stagione postmoderna delle palazzine romane
Casa Baldi a Labaro (Paolo Portoghesi, 1959-61), arroccata su un colle di tufo lungo la Via Flaminia, segna la svolta postmodernista romana in contrapposizione alle norme dell’International Style. Il tufo viene usato a crudo, con rimandi compositivi che vanno da Borromini a Gaudí.
Tra il 1976 e il 1978 Mario Stara e Giancarlo Pennestri costruirono la Palazzina Stara sul Lungotevere delle Armi: seminterrato e piano terra, quattro piani superiori (due appartamenti ciascuno), scale circolari in supporti cilindrici d’angolo e un tetto inclinato a gradoni che crea spazi abitabili all’aperto. Questa struttura rappresenta la chiusura ideale di un percorso quarantennale, solo di recente riscoperto e apprezzato per la sua rilevante importanza creativa.
Cesare Cunaccia