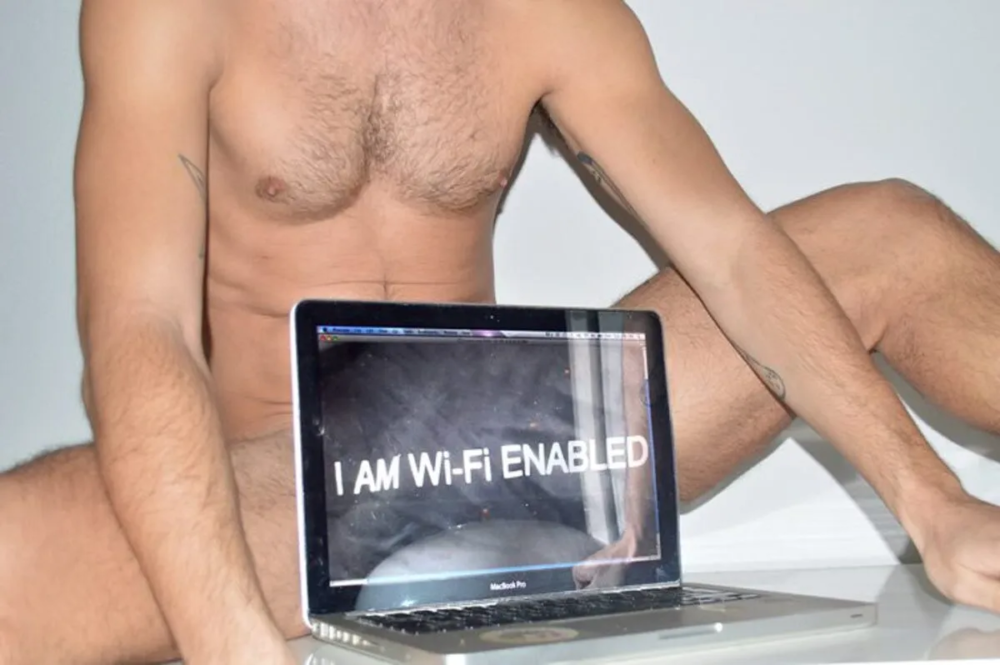Stefano Rabolli Pansera, rigenerare con l’arte: Khao Yai Art Forest e Bangkok Kunsthalle
Dal riuso di una tipografia bruciata alla foresta-laboratorio: Stefano Rabolli Pansera racconta Khao Yai Art Forest e Bangkok Kunsthalle tra riforestazione, energie rinnovabili, monitoraggio idrico e riciclo dei materiali
Foresta e città: i 65 ettari di Khao Yai Art Forest e la Bangkok Kunsthalle, da un’ex tipografia bruciata
Foresta e città come due laboratori contigui: da un lato i 65 ettari di Khao Yai Art Forest, dove l’arte misura il tempo degli alberi; dall’altro Bangkok Kunsthalle, dove un’ex tipografia bruciata diventa organismo espositivo in crescita.
Lampoon intervista Stefano Rabolli Pansera, direttore di Khao Yai Art Forest e Bangkok Kunsthalle
Stefano Rabolli Pansera: «Khao Yai Art Forest e Bangkok Kunsthalle sono due poli che si completano: il primo cura un paesaggio naturale ferito dalla deforestazione e dall’agricoltura intensiva, il secondo rigenera un complesso industriale abbandonato nel cuore di Bangkok. Guarire la foresta e guarire la giungla urbana significa trasformare la missione in atti concreti: reimpiantare alberi autoctoni, gestire l’acqua in maniera sostenibile, costruire programmi educativi con scuole e università, commissionare opere site-specific, organizzare cene comunitarie e momenti di scambio.
Abbiamo già osservato risultati tangibili: a Khao Yai nuove specie hanno iniziato a popolare la foresta; a Bangkok la Kunsthalle è diventata catalizzatore di pubblico e generatrice di un discorso critico inedito. Ma la cura non si esaurisce in azioni pratiche: è innanzitutto una postura concettuale e curatoriale. Le opere sono dispositivi che ci permettono di riconnetterci con la natura e con lo spazio in modo autentico.
Così Maman di Louise Bourgeois è divenuta rifugio per gli uccelli e attorno a lei sono nate risaie che oggi forniscono il riso al ristorante. La Fog Forest di Fujiko Nakaya ha generato un ecosistema parallelo di piante e insetti. In ultima analisi, to heal is to dwell: abitare uno spazio – naturale o urbano – significa accettarne le condizioni, trasformandole in base per nuove relazioni e nuove memorie».


Da fabbrica bruciata a Kunsthalle: addomesticare lo spazio con l’arte. Nessun restauro
FJC: L’edificio che ospita Bangkok Kunsthalle – ex tipografia – non vuole occultare le sue “ferite”, causate da un incendio nel 2001.
Stefano Rabolli Pansera: «Gli spazi dell’ex tipografia Thai Wattana Panich non sono stati restaurati ma addomesticati: Korakrit Arunanondchai ha trasformato le ceneri dell’incendio in pavimento, Nicolas Amato ha levigato un corrimano, mutando un passaggio di servizio in spazio contemplativo.
Ristrutturare significherebbe imporre una visione architettonica su un edificio concepito come contenitore passivo. Addomesticare, invece, implica reciprocità: lo spazio trasforma le opere e le opere trasformano lo spazio.
Il programma curatoriale coincide con il progetto architettonico: mostra dopo mostra, piano dopo piano, l’edificio cresce come un organismo vivente. Non c’è un punto d’arrivo, ma un processo continuo. In questo modo rifiutiamo tanto la logica del restauro quanto quella della ricostruzione: entrambe presuppongono l’impossibilità d’uso. Per noi, al contrario, lo spazio deve continuare a vivere. Le tracce dell’incendio diventano sostanza narrativa.
Superfici annerite, muri scorticati, pavimenti irregolari si trasformano in parte integrante del percorso espositivo.
È un atto di sincerità architettonica che non diventa cimelio o feticcio: ciò che era ferita diventa racconto».


Topografia e movimento: quando l’architettura diventa metodo critico, intervista Stefano Rabolli Pansera
FJC: In che modo sezione, quota, pendenza e accessi orientano le scelte espositive? Ad esempio, con Fog Forest la topografia non è cornice ma parte dell’opera.
Stefano Rabolli Pansera: «L’architettura, per noi, non è cornice neutra, ma metodo critico e una precondizione dell’opera. L’ambizione è che le opere si confondano con lo spazio, fino a non essere più riconosciute come tali.
In Fog Forest di Fujiko Nakaya, la topografia diventa parte integrante dell’opera: pendenze, salite e aperture influenzano la densità e la durata della nebbia, trasformando il land-scape in time-scape. Il visitatore avanza, si perde, riemerge. L’opera esiste perché la topografia del terreno condiziona l’evaporazione della nebbia.
Lo stesso accade a Bangkok Kunsthalle: gli artisti scelgono spazi segnati da scale bruciate, travi a vista, aperture improvvise e li trasformano in nuove relazioni espositive».

Forestare per esporre: il terreno prima dell’arte. Lavorare il suolo per ospitare l’opera
FJC: Alberi e forestazione. Quali specie, quali densità, quale la gestione del soprassuolo in pianura, collina, montagna? Come si intreccia questo “tempo vegetale” con il “tempo minerale” del cerchio di ardesia di Richard Long?
Stefano Rabolli Pansera: «Foresta e opere convivono su scale temporali diverse, ma intrecciate: Khao Yai offre un’esperienza di tempo radicale: la crescita lenta degli alberi e la presenza delle opere producono una dialettica tra permanenza e trasformazione.
A Khao Yai l’opera d’arte precede il paesaggio: non seguiamo la sequenza canonica di masterplan e poi installazione, ma invertiamo l’ordine. Ogni intervento comincia da un gesto originario: livellare il suolo (bprap-na-dim). Non un piedistallo per elevare, ma un’apertura affinché l’opera possa accadere.
Con Richard Long, Ubatsat, Francesco Arena o Louise Bourgeois l’orizzontalità è stata condizione spaziale per l’opera. Con Delcy Morelos, lo scavo che ha rivelato solo massi inamovibili diventerà giardino di pietre, trasformando una condizione tecnica sfavorevole in epifania poetica».

Acqua dall’aria, energia dal sole: la nebbia sostenibile che si adatta ai monsoni
FJC: La nebbia di Fujiko Nakaya nasce da acqua catturata dall’aria. Qual è il bilancio energetico del sistema e come varia tra stagione secca e monsonica? In generale, quali protocolli adottate per contenere l’impatto ambientale?
Stefano Rabolli Pansera: «La Fog Forest utilizza acqua raccolta in loco grazie a un sistema brevettato da Aquaria, start-up californiana partner del progetto. L’energia è fornita da pannelli solari e calibrata sulle stagioni: durante il monsone la nebbia si integra con l’umidità naturale, nella stagione secca richiede maggiore compensazione, sempre mantenuta entro bilanci sostenibili.
Abbiamo definito protocolli precisi: uso di energie rinnovabili, monitoraggio dell’impronta idrica, riduzione dei trasporti, riuso dei materiali. Anche la frequenza delle attivazioni è calibrata, così da rendere sostenibile l’opera e permettere alla nebbia di generare un ecosistema parallelo».


Materia ruvida che insegna: leggere “GOD” con il corpo, prima che con le didascalie
FJC: C’è materialità ruvida nell’opera GOD di Francesco Arena: due massi, una responsabilità dello sguardo. In che modo questa fisicità educa il pubblico e favorisce un incontro diretto con le opere, senza eccesso di apparati?
Stefano Rabolli Pansera: «GOD di Francesco Arena è stata la prima opera installata a Khao Yai. Due massi, fra cui una parola fu incisa ed ora rimane invisibile: ciò che resta è solo immaginabile, mai leggibile. La lettura diventa atto di fede.
La forza dell’opera sta nella sua nudità: due blocchi che obbligano lo spettatore a confrontarsi con il loro peso e la loro gravità. Non ci sono apparati ridondanti, nessuna mediazione invasiva: è la materia stessa a educare lo sguardo. Molti visitatori si avvicinano a toccare la pietra, come per percepire con il tatto l’energia compressa in trenta tonnellate».


Che cosa rendere pubblico: misurare, numeri e la qualità del discorso che resta
FJC: È possibile misurare la cura? Tra foresta e Bangkok Kunsthalle quali indicatori rendete pubblici – accesso, partecipazione, risultati formativi, qualità del discorso – e come si riflettono in pratiche di riparazione come Mend Piece di Yoko Ono?
Stefano Rabolli Pansera: «La cura non si misura: trasforma. Rendiamo pubblici dati su accesso, partecipazione, programmi educativi. Ma ciò che conta è la qualità della partecipazione e la coerenza del discorso culturale che si genera.
Ogni mostra si valuta per la sua capacità di produrre testi, incontri, dibattiti, di aprire nuove traiettorie. Mend Piece di Yoko Ono lo mostra con chiarezza: il gesto non è riparare un oggetto, ma rendere visibile una comunità che si prende cura dell’opera. È lì che si misura davvero la cura».

Reazioni umane in foresta: ascoltare senza esotizzare, mediare senza addomesticare
FJC: Due artiste, uno specchio del vedere. Maman di Louise Bourgeois; Two Planets di Araya Rasdjarmrearnsook, video in cui contadini, lavoratori e monaci osservano riproduzioni di Le Déjeuner sur l’herbe e The Gleaners.
Quali reazioni avete registrato – parole, risate, silenzi, gesti – di fronte all’arte contemporanea? In che modo hanno orientato mediazione, rispetto delle sensibilità religiose e cura del luogo, evitando stereotipi ed esotizzazioni?
Stefano Rabolli Pansera: «L’ubicazione delle opere nella foresta cambia radicalmente la percezione. Two Planets di Araya lo dimostra: i monaci osservano riproduzioni di capolavori occidentali nel contesto naturale. E noi, spettatori nella foresta, osserviamo loro. E diventiamo come loro.
Il video in natura acquista forza ulteriore, e le reazioni – sorpresa, risate, silenzi meditativi – ci hanno insegnato ad ascoltare invece che imporre interpretazioni.
Con Maman di Louise Bourgeois è accaduto qualcosa di simile: l’ambiguità tra protezione e minaccia si è sciolta. Installata in natura, l’opera ha trovato il proprio ecosistema: gli uccelli hanno costruito nidi tra le uova di marmo, incarnando il concetto di maternità caro a Louise Bourgeois. La benedizione di Maman da parte dei monaci buddhisti è avvenuta senza spettacolarizzazione, rispettando sensibilità religiose e sociali. Non si è trattato di esotizzare la differenza, ma di aprire uno spazio di dialogo».
Un bar che apre una volta al mese: socialità controllata e impatto sul paesaggio
FJC: K-BAR come rito sociale mensile nel paesaggio. Perché questa scelta? Come governate afflusso, rifiuti, rumore e luci in un ambiente che chiede protezione?
Stefano Rabolli Pansera: «K-BAR è un’anti-oasi di Elmgreen Dragset: un bar ispirato a Martin Kippenberger che rimane sempre chiuso, aprendo solo un sabato al mese. È un anti-rituale, un atto di ospitalità negata.
La gestione è parte integrante del progetto: accessi contingentati, menù cosmopolita deciso dagli artisti stessi, controllo attento di rifiuti, rumori e luci. Non è intrattenimento, ma un gesto calibrato di socialità differita».

Stefano Rabolli Pansera sul futuro: commissioni in foresta, domesticità in città, alleanze operative
FJC: Uno sguardo ai prossimi mesi. Qual è la rotta? Tra nuove commissioni nella foresta, sviluppo della Bangkok Kunsthalle, programmi educativi, manutenzione delle opere all’aperto.
Stefano Rabolli Pansera: «Il nostro orizzonte degli eventi non supera i dodici mesi: il percorso non è lineare, ma fatto di ascolto e adattamento.
A Khao Yai vogliamo consolidare il modello di Land Art 2.0 con una commissione annuale. Stiamo realizzando l’opera di Delcy Morelos: un tavolo ovoidale di quattrocento metri che trasforma uno scavo in giardino di pietre. La costruzione stessa dell’opera diventa performance comunitaria, coinvolgendo i lavoratori locali.
Alla Kunsthalle ci concentriamo sull’ampliamento degli spazi e sul rafforzamento delle reti. Le prossime mostre rifletteranno sul tema della domesticazione: Spencer Sweeney ha trasformato un piano della Kunsthalle in studio-laboratorio; Mapping the Studio di Bruce Nauman mostrerà lo studio come opera; Description without Place con le Cellule di abitazione di Absalon introdurranno per la prima volta in Asia una riflessione radicale sulla domesticità.
Criticità come costi, clima e distanze saranno affrontate con co-produzioni e partnership museali. La rotta rimane la stessa: guarire attraverso l’arte. Nella foresta come nella città».
Stefano Rabolli Pansera
Stefano Rabolli Pansera (Brescia, 1980) è architetto e curatore. Dirige Bangkok Kunsthalle e Khao Yai Art Forest in Thailandia – promosso dalla collezionista e filantropa Marisa Chearavanont. Inoltre, Pansera è fondatore e direttore artistico di St. Moritz Art Film Festival; ha co-fondato Beyond Entropy e, in precedenza, è stato direttore di Hauser & Wirth tra Londra e St. Moritz; nel 2013 ha ricevuto il Leone d’Oro come co-curatore del Padiglione dell’Angola alla Biennale di Venezia.