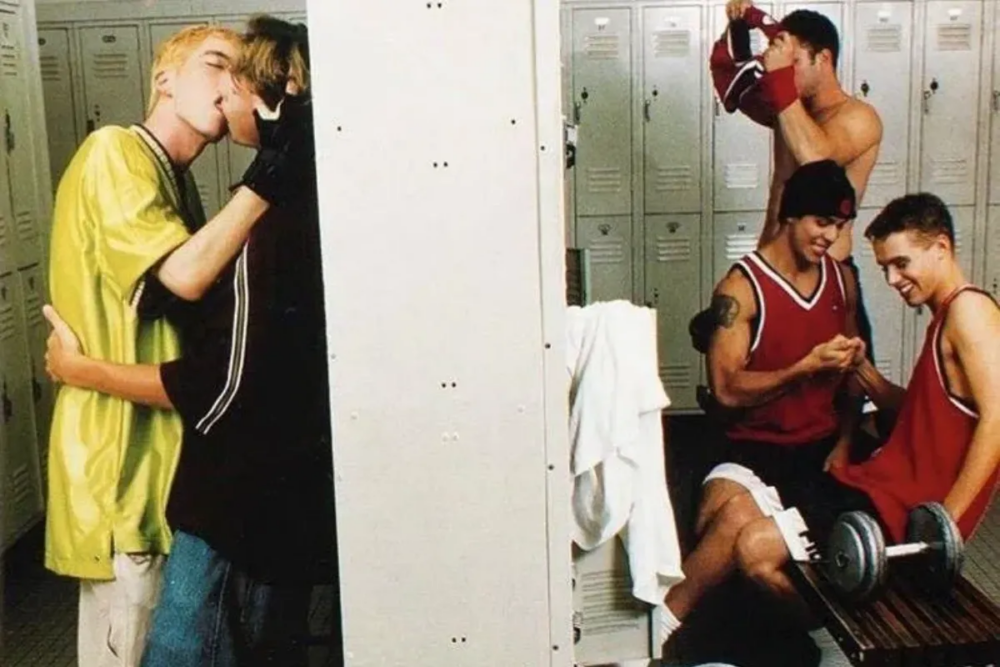Tintura e filatura: soluzioni sostenibili più realistiche di quanto si creda
Seta, Bisso, canapa, cocciniglia e robbia. La combinazione delle materie prime soddisfa il mercato e presenta risposte alle esigenze ambientali del futuro. Parola a Stefano Panconesi
Dalla tintura artigianale a una scienza tessile sostenibile: come funziona oggi il processo di colorazione naturale
Da pratica artigianale, il processo di coloritura delle fibre tessili è divenuto oggi una scienza. La procedura naturale inizia con l’immersione dei tessuti in un bagno acquoso ad alta temperatura, dove viene disciolto il colorante, che può essere in forma liquida o secca, a seconda se esposto in una stufa o al sole. Prima di tingere, bisogna mordenzare il tessuto: si tratta di un pretrattamento con sali di origine minerale o tannini vegetali, necessari per creare un legame tra la struttura chimica della fibra e quella del colorante.
Sebbene molti industriali dimostrino interesse a riconvertire le proprie attività in chiave naturale, la mancanza di esperienza specifica può rallentare o ostacolare il cambiamento. Per questo motivo, intervengono esperti del settore, capaci di agire come mediatori tra impresa e ricerca scientifica. Il ruolo della consulenza non si limita a indicare azioni pratiche, ma punta anche a trasferire conoscenze strategiche, costruendo consapevolezza sul potenziale sostenibile del proprio operato.
Stefano Panconesi, ispettore GOTS, pioniere della tintura naturale nel sistema moda
Fiorentino, ispettore GOTS (Global Organic Textile Standard), Stefano Panconesi si dedica da oltre trent’anni all’applicazione della tintura naturale in ambito industriale. Il suo approccio parte dallo studio del materiale grezzo – fornito dall’azienda o selezionato congiuntamente – e si focalizza sulle fibre organiche e naturali: lana, seta, lino, canapa. Da qui si sviluppa la cartella colori, costruita tenendo conto delle referenze cromatiche fornite dall’azienda.
Il colorante può essere selezionato in tre forme – intera, a taglio tisana o in estratto – e successivamente si procede con il bagno campione e la verifica della solidità alla luce, al sudore e allo sfregamento. Dopo aver definito il prodotto, è messa a punto una strategia di marketing e il packaging, in vista della partecipazione a fiere di settore, dove deve essere illustrato in modo trasparente l’intero processo produttivo.
«Cerco di far comprendere all’industria lematerie prime organiche. Si può tingere con i coloranti naturali senza cambiare le macchine, senza stravolgere la lavorazione, utilizzando ciò che già si possiede. La differenza tra artigianalità e industria sono i numeri. Si tratta di mettere a punto una ricetta che permetta di tingere una quantità controllata di capi».
«Dall’anno scorso l’industria della moda ha cominciato a comprendere le potenzialità del colorante naturale. Fino ad allora c’era una mancanza di accettazione di alcune sue prerogative: standard di resistenza alla luce più basso dei colori sintetici, minore unitezza del colore, difficoltà di ripetizione. Oggi possiamo ancora ammirare i colori degli arazzi del Quattrocento e del Seicento. C’è un motivo: all’epoca esisteva l’abitudine di custodire i tessuti fino all’utilizzo successivo, riponendo dentro bauli. Occorre comprendere i limiti delle cose e riadattare le nostre abitudini».
l caso del sandalo Ferragamo per Judy Garland
Nel 2017, il reparto materiali di Salvatore Ferragamo propone a Panconesi di reinterpretare il Sandalo del 1938, realizzato in capretto dorato, strati di sughero e camoscio policromo, e destinato all’attrice Judy Garland. L’obiettivo era utilizzare materiali naturali. La scelta è ricaduta sul cotone organico, a cui è seguita un’attenta analisi del modello originale in pelle tinta, per poi sviluppare una nuova ricerca cromatica.
Approvata la cartella colori, le fibre sono state tinte in una tintoria locale. Il processo è stato documentato da Ferragamo, che ha seguito Panconesi nel laboratorio, assieme alle artigiane dell’uncinetto e al falegname che ha realizzato il tacco e la confezione finale.
Un sapere millenario: filatura, tintura e identità tessile nel mondo antico
Panconesi integra nella sua ricerca il confronto con maestri tintori conosciuti durante i suoi viaggi e la consultazione di antichi manuali. Dalle popolazioni nate lungo i fiumi e i mari si sono sviluppate tecniche complesse di filatura e tintura: i Cinesi e i Giapponesi erano esperti nella seta; gli Egizi tingevano il lino; gli Assiro-Babilonesi la lana; gli Indiani il cotone; in America centrale si tingeva la lana di alpaca e vigogna, mentre i nativi del Nord America usavano iuta, peli e pelli di montone.
Tra i pigmenti storici, il rosso veniva ottenuto dalla Robbia – radice di Rubiacee europee – e dalla Cocciniglia, un parassita dei cactus del Messico e delle Canarie. Il Campeggio, estratto nelle Indie Orientali dalla corteccia di una leguminosa, produceva tonalità dal viola al nero. Altri esempi sono il Mallo di Noce e l’Indaco, uno dei coloranti più antichi, estratto dalle foglie di leguminosa tramite il processo al tino.
Per i gialli, si usavano l’Annatto (semi rossi di una pianta sudamericana), la Curcuma e lo Zafferano, ricavato dagli stigmi del fiore coltivato in Asia Minore e nel Mediterraneo.
Casa Clementina: un luogo per apprendere e trasformare la cultura della tintura
Nel 2011 Panconesi fonda, assieme all’architetto Sissi Castellano, Casa Clementina: uno spazio didattico rigenerato in una struttura dei primi del Novecento, dedicato alla tessitura e tintura naturale. Qui, creativi e artigiani provenienti da culture diverse trovano un contesto formativo e uno scambio reciproco.
«Da alcuni anni accogliamo quattro, cinque studenti interessati ad approfondire studi specifici. Nel progetto formativo di Casa Clementina, anziché lavorare per salvare le piccole identità locali, le si crescono e le si trasformano».
Colori, sostenibilità e consumo: il nuovo paradigma della moda responsabile
L’emergenza climatica ha ridefinito il concetto stesso di colore, che dagli anni Sessanta ha smesso di essere un bene di lusso per diventare bene di consumo (Falcinelli, Cromorama, Einaudi, 2017). Per evitare che gli sforzi vengano vanificati, l’industria deve adeguarsi a un modello di economia circolare, in cui i prodotti creati rientrano in un ciclo continuo di riciclo e riutilizzo.
«Credo che oggi la fibra massima a cui si deve aspirare sia quella organica. È il punto di partenza. Cotone, lana, lino o canapa, glicine, ananas, juta, bambù, la ginestra e molti altri: alcuni consentono una produzione a larga scala, altri più ridotta, ma l’impiego di ciascuno consente al prodotto di poter tornare a essere quel che era dopo essere stato gettato».
Filiera tessile ecologica: dati, prospettive e pratiche rigenerative
Secondo un articolo de Il Sole 24 Ore (2019), la produzione globale di indumenti in fibre naturali e colorati in modo sostenibile è destinata a crescere del 63% entro il 2030. Inoltre, il 55% dei consumatori italiani si dichiara disposto a pagare fino al 25% in più per capi in fibra e tinta naturale.
Sempre nel 2019, ANSA riportava dati della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) secondo cui la produzione italiana di lino, canapa e gelso da seta – oggi sostenuta da circa 2.000 aziende agricole – potrebbe triplicare grazie al coinvolgimento delle 3.000 imprese che già coltivano piante officinali e camomilla, sfruttando gli scarti agricoli come base per la tintura.
Questi sviluppi riflettono la crescente consapevolezza dei consumatori a partire dagli anni Novanta, che hanno spinto design e produzione industriale verso una maggiore attenzione ambientale. Il settore tessile resta tuttavia uno dei più inquinanti al mondo: la sola tintura dei tessuti consuma tra i 6 e i 9 trilioni di litri d’acqua l’anno, gran parte dei quali diventa scarto non potabile. La causa principale è l’utilizzo di coloranti sintetici derivati dal petrolio, tossici e non biodegradabili, che rilasciano sostanze dannose nell’ambiente durante lo smaltimento.
Coloranti naturali e nuove tecnologie: la risposta alla crisi ambientale e sanitaria
In risposta a queste problematiche, l’industria tessile e della moda ha avviato numerose iniziative volte a garantire la tracciabilità delle materie prime e il controllo dei processi, come la campagna Detox di Greenpeace, attiva dal 2011 al 2020. Parallelamente, sono state sviluppate tecniche di colorazione alternativa, capaci di rispettare gli standard qualitativi del prodotto finito.
L’attenzione si è focalizzata sui coloranti naturali, estratti da risorse vegetali e animali rinnovabili. Questi pigmenti offrono una soluzione concreta ai problemi ambientali e sanitari legati allo smaltimento e alle dermatiti da contatto causate dai coloranti sintetici.
Oltre alle proprietà benefiche, i coloranti naturali stimolano la ricerca su nuovi addensanti – come la gomma guar (dai semi di una pianta indiana), l’amaranto e l’amido germinato – e mordenti biodegradabili come il Catechu (estratto dal legno di Acacia Catechu), il Tamarindus (dal frutto secco) e il succo di limone.