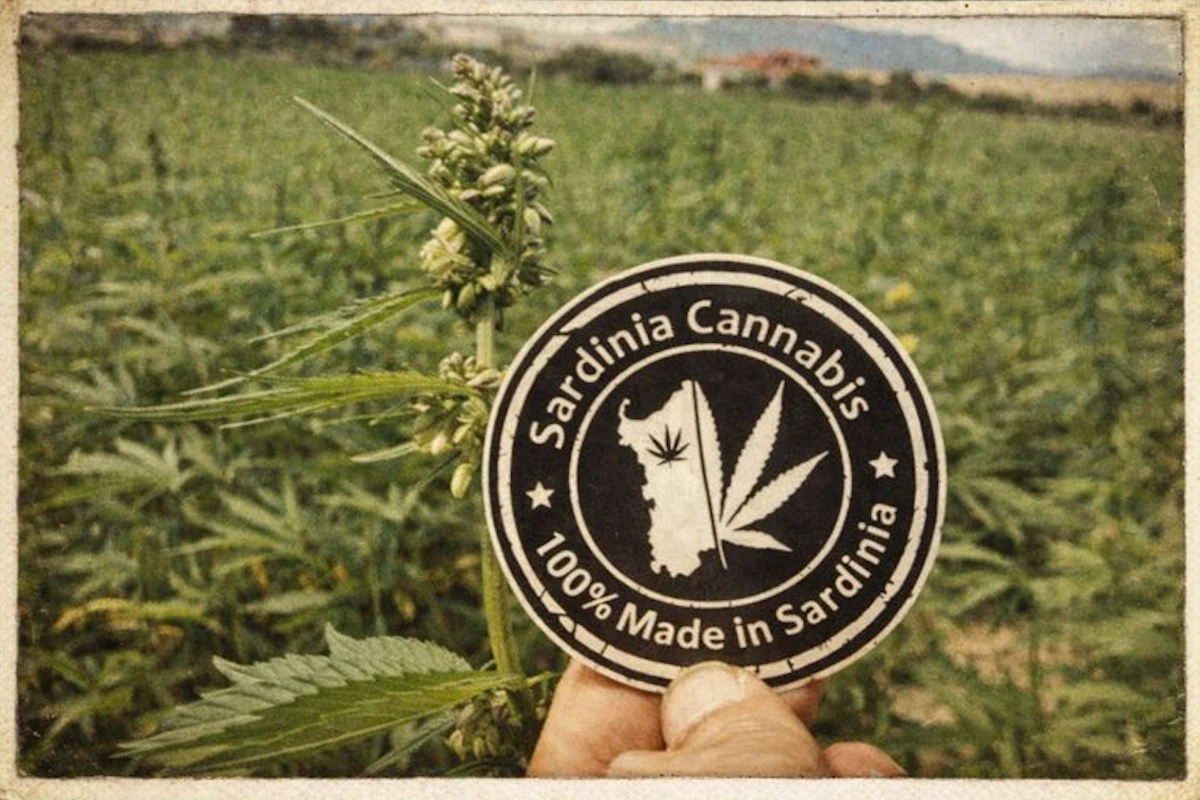Armani Agroforestale: il primo cotone rigenerativo al mondo coltivato in agroforestazione
Un caso studio di rilevanza mondiale: grazie al supporto del gruppo Armani, un protocollo di sperimentazione per il cotone in agro forestazione procede in Puglia – mentre le prime 1000 magliette raggiungono gli scaffali dei negozi
La maglietta in cotone di Armani: Made and Sourced in Italy
La maglietta in cotone da filiera agroforestale a tracciabilità completamente italiana: Made and Sourced in Italy – un codice ulteriore, come per il vino, quando il DOCG segue il DOC. Non una cosa da poco, considerando che in Italia, qui dove il Made in Italy è vanto e orgoglio nazionale – oltre che motore economico per migliaia di posti di lavoro. Oggi il Made in Italy nel tessile non prevede filati di produzione italiana, non esiste il “sourced in Italy”. I tessuti sono lavorati in Italia, i telai sono italiani – ma i filati sono d’importazione. Poche eccezioni, qualche lana a titolo basso e mano ruvida che difficilmente raggiunge ritmi industriali – e oggi, il cotone voluto da Armani in Puglia.
Con la raccolta del 2023, lo scorso 17 luglio 2025 Giorgio Armani ha presentato in vendita un migliaio di magliette in cotone da agricoltura rigenerativa italiana: pochi negozi in Europa, le magliette entrano nella collezione di prima linea, omaggio al signor Armani che vestiva una maglietta di cotone tutti i giorni. Il cotone è oggi la fibra più utilizzato al mondo – dopo la fibra sintetica. Non si può coltivare il cotone ovunque nel mondo, bisogna rispettare suolo e clima. La Puglia è terra buona per il cotone, laddove il cotone apprezza il caldo a 43, finanche 45 gradi.
Il CREA di Bari e Giorgio Armani: gli ettari a Rutigliano e il professore Scarascia dell’European Forest Institute (EFI)
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e in Economia Agraria – il CREA di Bari è a capo di sette aziende agricole sperimentali dislocate nel territorio italiano; quattro sono in Puglia. Una tra queste, l’azienda agricola Venezian-Scarascia porta l’insegna storica dell’Istituto Sperimentale Agronomico di Bari e conta circa 20 ettari di terreno di proprietà pubblica. Grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal gruppo Armani, nella primavera del 2023, furono messi a terra le prime sementi di cotone su 5 dei 20 ettari di terreno. La sgranatura o ginnatura è stata condotta in Sicilia, la filatura è stata processata da Filbest in provincia di Firenze.
Rutigliano, comune della Puglia, è celebre per la produzione da uva da tavola e per i fischietti in ceramica particolarmente cari al Sindaco. Il comune di Rutigliano fa parte del progetto Bio Cities indotto dall’Istituto Forestale Europeo: secondo una regia europea e partecipando a bandi comunitari, Rutigliano partecipa a sperimentazioni di carattere sociale con risvolto in agraria – per esempio, la prototipia di impianti per la stabilizzazione dell’acqua reflue al fine di renderle disponibili all’irrigazione in campo.
La coltivazione del cotone in agroforestale fa parte di questo protocollo. Il professor Giuseppe Scarascia-Mugnozza dell’Istituto Forestale Europeo che coordina questo progetto sperimentale in Puglia, riporta una sua recente visita in Uzbekistan, dove si teneva forse il più consistente congresso sulle tecniche agrarie per il cotone al mondo: come unico esempio di cotone in agro-forestazione, l’intero congresso indicava la sperimentazione in Puglia raccontata in queste righe.
Il fabbisogno alimentare e la disponibilità di ettari agricoli e il suo degradato
Alcuni dati: oggi siamo 8,2 miliardi al mondo, con la pretesa – utopia o diritto – di mangiare (tutti) tre volte al giorno. Calcolando gli ettari coltivabili su questo pianeta, nel 1960 ogni persona avrebbe potuto essere intestataria di 0.5 ettari di terra da destinare al fabbisogno alimentare nel corso di un anno di vita. Oggi abbiamo poco meno di 0,2 ettari a testa. Non sono distribuiti equamente, questi ettari. L’Italia è composta da quasi 30 milioni di ettari di terra e siamo 60 milioni di individui – ovvero abbiamo 0,5 ettari a testa, di cui approssimativamente solo il 41% è a destinazione agricola. Importiamo il latte, il pesce le patate – esportiamo il riso. A livello mondiale abbiamo il 30% circa di suolo è degradato. In Italia abbiamo il 75% di suolo degradato che sta perdendo fertilità.

Le tecniche in agricoltura: convenzionale e biologica
Il modo di dire mandare i figli nei campi è ancor meno vero di un tempo. Le tecniche agrarie oggi sono possibili solo a chi possiede conoscenze tecniche e strumentali non raggiungibili da tutti. Le irrigazioni, primario esempio, sono calcolate con formule matematiche per niente banali, testate e ritestate in laboratorio.
Il professor Giuseppe Corti del CREA identifica quattro tipologie di agricoltura attuali. L’agricoltura convenzionale – oggi indicata come un problema da risolvere, uno stato retrogrado colpevole di tanto problema – ma il professore ricorda come in Italia l’agricoltura convenzionale produca una filiera alimentare invidiata nel mondo e una produttività che tiene in piedi il tessuto attuale di industrie agricole. Non è mai colpa del singolo agricoltore – ma della tradizione radicata in un territorio che invece di essere ricchezza si mostra come freno e ostacolo. L’agricoltura biologica «più che un sistema è un’ideologia. Le produttività diminuiscono. Si fa meno uso di prodotti sintetici come fertilizzanti e disinfestanti – ma non esistono evidenze scientifiche che assicurino un minor impatto ambientale in agricoltura biologica» dice il professor Giuseppe Corti.
Agricoltura rigenerativa e agro forestazione
L’agricoltura rigenerativa mira al recupero della biodiversità del suolo. Dall’agricoltura rigenerativa, l’agro forestazione è sia un ulteriore passo in avanti, sia un ritorno alla storia, quando l’agricoltura disposta tra gli alberi era l’unica forma di lavoro in campo. L’agroforestazione sottolinea come il suolo possa essere nutrito e strutturato grazie alle radici degli alberi – le radici compongono sia un sistema edile che contrasta l’erosione del terreno e il suo smottamento, sia una rete idraulica che conduce i nutrienti in profondità, così da ricreare ambienti idonei ai microrganismi. In agroforestazione, le competenze tecniche richieste sono ancora più precise. I macchinari non sono al passo con i tempi: sono necessarie modifiche ed evoluzioni ai trattori presenti sul mercato, allo stato dell’arte troppo ingombranti per muoversi tra gli arbusti.
In agroforestazione, così come per ogni rigenerazione agricola, il terreno rimane coperto di vegetazione. Qui a Rutigliano, il suolo è coperto d’estate con il cotone, d’inverno con le colture di copertura: le leguminose assorbono azoto dall’atmosfera e lo fissano nel suolo. Si diversificano le piante nel campo – piante che sempre possano avere un interesse economico: il fico per l’alimentare, il carrubo per la zootecnica, il gelso per una possibile ripresa della filiera della seta in Italia.
Agroforestale: sperimentazione e procedure irrigue
Il tema del cotone rimane il fabbisogno idrico. Se è vero che una coltura per la filiera alimentare quale il pomodoro richiede oltre il doppio rispetto a quanta ne possa servire al cotone – un metro cubo d’acqua, in agro forestazione, produce 0,7 chili di fibra e seme di cotone (un dato, comunque, superiore rispetto a 0,4 della letteratura in agricoltura convenzionale).
Ne consegue come le sperimentazioni condotte dai ricercatori del CREA siano concentrate sull’efficienza delle procedure irrigue. Sensori a terra danno la misurazione dell’umidità nel suolo – sensori sospesi, come microstazioni meteorologiche, danno rilievo dell’evapotraspirazione – ovvero: sia l’acqua che evapora dal suolo, sia l’acqua rilasciata dalle piante. Per sottrazione, si conosce l’effettivo consumo d’acqua da parte delle piante. Lavorando su cinque ettari, dividendo questo terreno in particelle, per ogni area sono testate variabili diverse.
L’ombra degli alberi sul cotone può portare a una diminuzione della crescita della pianta – ma questo svantaggio va posto sulla bilancia a contrappeso con più aspetti positivi: la concimazione del terreno, il ridotto fabbisogno idrico (con gli alberi a intervallare le colture, il terreno rimane più umido). Il risultato è positivo per il campo in agroforestale, con un’efficienza aumentata del trenta per cento. La pianta giunge a fiore più tardi nei mesi, producendo capsule più grandi e in quantità maggiore.
A dicembre, dopo la raccolta dei fiocchi, le piante di cotone sono trinciate dalle macchine. I frammenti organici restano a terra per qualche settimana; poi un’aratura non superiore a 10 centimetri di profondità le interra. Non ci sono mai arature profonde: non si deve esporre la terra all’aria. La terra deve essere coperta da vegetazione, in ogni stagione dell’anno – così che un’attività di fotosintesi non sia interrotta e che il carbonio stoccato nel suolo non sia ossidato dall’aria.
Certificazioni e Passaporto Digitale: gli audit di Regenagri
Passaporto Digitale: inquadrando un QR code posto sull’etichetta, appare una scheda descrittiva del percorso e delle fasi che la maglietta ha attraversato, da materia prima al packaging con cui il capo è consegnato dopo lo scontrino. Dal Passaporto Digitale si possono comprendere le certificazioni, e quante più prove a garantire la veridicità e la sincerità dell’intento – il lavoro di chi scrive questo testo, cerca un equilibrio tra informazioni tecnico-professionali e narrazione per gente comune, non sempre interessata a tali approfondimenti.
Il valore di tracciamenti e certificazioni dipende dall’idoneità e dall’autorevolezza dell’ente certificatore. Il progetto del Cotone Rigenerativo attivato da Armani in Puglia, in particolare per la fase agricola qui a Rutigliano, procede sotto gli audit di Regenagri – una Community Interest Company (CiC), modello di impresa sociale prevista dai registri commerciali su territorio inglese. I periti professionali incaricati da Regenagri conducono un controllo annuale in campo, valutando ogni possibile parametro: dal consumo di acqua all’uso energetico; dalla tipologia di fertilizzanti che devono essere naturali alla riduzione del solco in aratura; dalla manutenzione dei macchinari al monitoraggio dei campi richiedendo la presenza di siepi antivento, all’assenza di plastica nelle operazioni. Gli audit annuali producono un punteggio complessivo che qui a Rutigliano, dopo le ultime rilevazioni, ha raggiunto un valore di 79 su 100 (la certificazione si ottiene con almeno il 65% del punteggio) – non solo: Regenagri obbliga al consolidamento di ulteriori 4 punti di percentuali per il prossimo rilievo (nell’ottica di raggiungere il 100% nell’arco dei 3 anni). Richiedere queste misurazioni è un investimento economico: sia per la preparazione necessaria, da parte dell’azienda agricola, al superamento di questi test – sia per il compenso che si deve agli enti certificatori e ai loro tecnici. A oggi, Regenagri dà relazione e valutazione tecnica per circa due milioni di ettari di terreno nel mondo, per un totale approssimativo 330.000 aziende agricole a livello globale.
Carlo Mazzoni
Nota informativa. Il progetto per il Cotone rigenerativo in Puglia è possibile grazie a un’iniziativa del gruppo Armani, promosso da SMI (Sustainable Markets Initiative Fashion Task Force), in collaborazione con Circular Bioeconomy Alliance, con il coordinamento dell’Istituto Europeo per la Forestazione (EFI), del Consiglio Italiano per la Ricerca e l’Analisi in Agricoltura (CREA) e di Pretaterra.