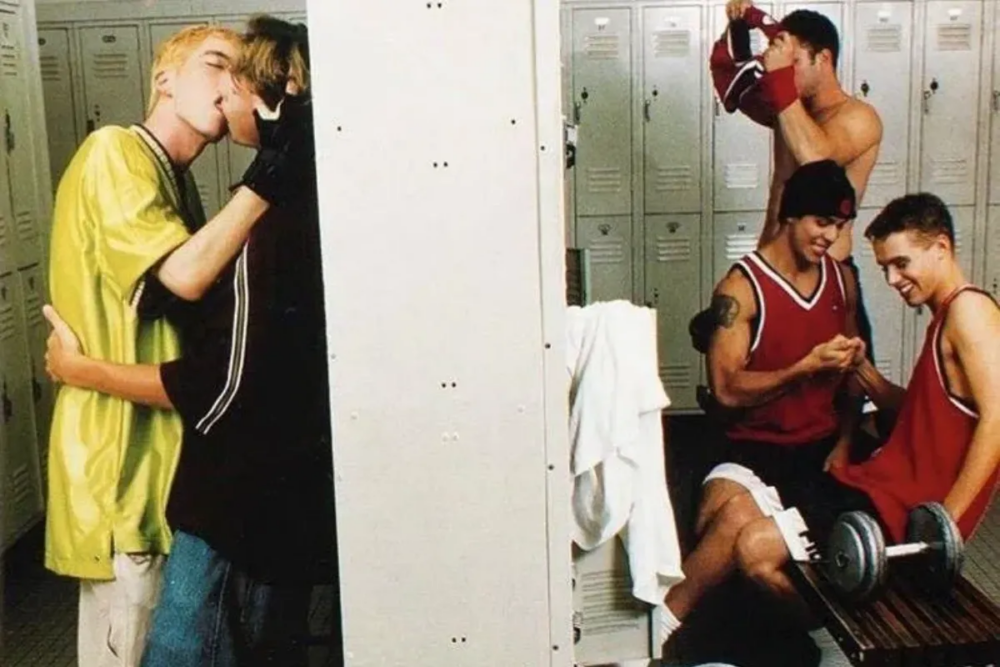Dior sfila a Villa Albani Torlonia, il giardino dove nacque il Neoclassicismo
Nel giardino che fu laboratorio del Neoclassicismo, dove Winckelmann e il cardinale Albani reinventarono il dialogo fra arte antica e natura, la sfilata diventa tributo ai legami culturali che uniscono l’Italia alla maison sin dal 1947
La Dior Cruise 2026 firmata da Maria Grazia Chiuri sfila a Villa Albani Torlonia
Il 27 maggio 2025 Villa Albani Torlonia apre per la prima volta i suoi cancelli alla moda: la Maison Dior presenta qui la collezione Cruise 2026 firmata da Maria Grazia Chiuri, romana di nascita e custode di un’estetica che guarda al classicismo come fonte inesauribile di ispirazione. La scelta non è casuale. Nel giardino che fu laboratorio del Neoclassicismo, dove Winckelmann e il cardinale Albani reinventarono il dialogo fra arte antica e natura, la sfilata diventa un tributo ai legami culturali che uniscono l’Italia alla maison sin dal 1947, anno in cui Christian Dior affidò a artigiani e tessitori italiani la realizzazione di molte sue creazioni.
Un’oasi di arte e verde incastonata nella Roma del traffico
A chi oggi imbocca via Salaria, pochi metri fuori Porta Pinciana, basta aguzzare lo sguardo oltre l’alto muro di tufo per intravedere una quinta di lecci, cipressi e pini marittimi ordinati come comparse di un set cinematografico. È l’anticamera di Villa Albani Torlonia, «uno dei più raffinati giardini d’Europa, concepito come palcoscenico dell’antico», secondo la definizione che ne diede l’archeologo Johann Joachim Winckelmann. Dietro quel muro si estende un parterre all’italiana di oltre sette ettari, ricamato di bosso e punteggiato da tempietti, obelischi, fontane e finte rovine: un manifesto a cielo aperto del gusto neoclassico che, a metà Settecento, fece di Roma la capitale estetica del Grand Tour.
Il sogno antiquario del cardinale Albani
La storia comincia nel 1747, quando il cardinale Alessandro Albani — nipote di papa Clemente XI, collezionista compulsivo di marmi antichi e grande diplomatico — acquista una tenuta vitata appena fuori le Mura Aureliane. Affida il progetto all’architetto Carlo Marchionni, coadiuvato da Giovanni Battista Nolli e, per le “fabbriche” del parco, da Giovanni Battista Piranesi. Obiettivo dichiarato: creare una galleria en plein air dove l’antico dialoghi con la natura e con le feste mondane di una Roma che, all’epoca, contava meno di 150 000 abitanti ma era capitale morale dell’Europa colta.
Winckelmann e la “paletta” del Neoclassicismo
Dal 1759 entra in scena Winckelmann, assunto come bibliotecario ma presto trasformatosi in regista iconografico del complesso. Fu lui a convincere Albani a non lasciare “alcuno spazio vuoto”, come scriverà in una lettera del 1766, e a disseminare il giardino di sculture greche e romane originali o restaurate con rigore filologico. Il risultato è un vero dizionario lapideo: dal celebre rilievo di Antinoo nel Casino Nobile al Parnaso di Anton Raphaël Mengs che campeggia nella Galleria, passando per copie ottocentesche di capolavori ellenistici esibite all’aperto come in un museo senza tetto.
Disegno “alla francese” e prospettive all’infinito
Il cuore verde è l’ampio parterre rettangolare che si apre a sud della villa. Le aiuole di bosso, disegnate come ricami barocchi, convergono verso la vasca circolare con zampillo centrale; l’asse visuale punta dritto alla facciata nobile, creando un effetto cannocchiale che ricorda Versailles e le regge medicee, ma ridotto a scala urbana. Ai lati, due fasce boscate schermano i rumori della via Salaria e incorniciano scorci studiati: ogni passo svela un’“invenzione” — un’ara romana, un sarcofago scolpito, una colonna antica — accuratamente allineata per sorprendere l’occhio del visitatore settecentesco in carrozza e, oggi, di quello che arriva a piedi con casco da scooter sotto il braccio.
Il Kaffeehaus e l’emiciclo delle delizie
Sul fondo del giardino, Marchionni eresse un Kaffeehaus semicircolare, intonacato a rosa pompeiano e coronato da una balaustra di statue marmoree. Qui Albani offriva cioccolata calda, caffè turco e concerti d’archi alle élite europee di passaggio: un “salotto all’aria aperta” in cui l’architettura diventava teatro e la natura quinta scenografica. L’emiciclo, abbracciando il parterre, amplifica la prospettiva e funge da cerniera fra la parte formal e quella pittoresca del parco, dove sentieri sinuosi conducono, fra quinte di alloro e corbezzolo, al Tempio di Diana — tempietto ionico su podio di tufo, progettato come finta rovina per evocare la malinconia del tempo che consuma.
Flora, microclimi e un raro “bosco artificiale”
Se le architetture raccontano il mito dell’antico, il planting design parla la lingua del Paesaggio Romano: pini domestici che svettano come ombrelli, cedri del Libano importati nel 1755, cipressi toscani a segnare i confini, corbezzoli e lauri profumati nei brani d’ombra. Sul piano botanico, l’innovazione maggiore fu la creazione di un “bosco artificiale” con specie sempreverdi accostate a fusti caducifogli per garantire scenario verde anche d’inverno. La tessitura di bosso, rasata a 40 centimetri di altezza, fu invece riplasmata nell’Ottocento dai Torlonia, che introdussero geometriche aiuole ellittiche in dialogo con i rilievi scultorei.
Il passaggio ai Torlonia e la fortuna ottocentesca
Nel 1866 la villa passa al principe Alessandro Torlonia, la cui famiglia si era arricchita col monopolio dei dazi su sale e cereali. I Torlonia conservano intatto l’assetto Albani ma rendono il giardino più scenografico: introducono impianti idrici a pressione, riordinano i viali ghiaiati e restaurano marmi lesionati, rendendo la tenuta la meta prediletta di imperatori, papi e teste coronate in visita nella Capitale del neonato Regno d’Italia.
Guerra, decadenza e rinascita
Durante la Seconda guerra mondiale il complesso subisce requisizioni e spoliazioni; negli anni Sessanta il forte inquinamento urbano provoca l’imbrattamento delle sculture. È solo nel 1997 che la Fondazione Torlonia avvia un maxi restauro pluriennale da 20 milioni di euro, culminato nel 2020 con la pubblicazione del volume “Villa Albani Torlonia. Architetture, Collezioni, Giardino” e con il recupero di oltre 300 opere lapidee, molte ricollocate nei loro nicchioni originari nel parco.
Visitare oggi Villa Albani Torlonia
Oggi la Villa rimane proprietà privata ma, grazie a un accordo con la Fondazione, è visitabile su prenotazione: gruppi di massimo dieci persone, ingresso gratuito con contributo suggerito di 50 euro destinato a nuovi restauri. Le date, pubblicate sul sito della fondazione, vanno sold-out in poche ore; un chiaro indice del fascino che il luogo esercita su studiosi e semplici appassionati di giardini storici.