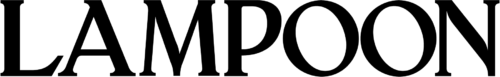Jonathan Anderson, Dior e quel graffio della cultura inglese
La cultura e l’ironia inglese, quel fare dissacrante, lo schiaffo e il graffio tra artigianato e provocazione – oggi sono il motore del brand che è più di ogni altro rappresenta lusso e ricchezza
Il graffio di Jonathan Anderson da Dior
Farla difficile – disturbarti un po’. La sfilata di Jonathan Anderson per Dior uomo vuole essere un graffio, uno schiaffo – forse se ne rileva lo stridere anche perché era la prima dopo le presentazioni di Milano. Da Milano, dove tutti sono più attenti alla strategia commerciale, a procedere un dialogo che i buyer possono capire – a Parigi, con Dior subito si cambiava ritmo. Anderson e tutta la sua buona educazione quando accoglie gli ospiti dopo la sfilata – mentre prima, con la sfilata vuole farti alzare il ciglio. Tutto bello, delicato e sofisticato, ma in realtà il gioco è darti fastidio. Lo scopo è farti pensare che non ti piace e poi ti capita a ripensarci la sera, la notte magari te lo sogni pure – Anderson e tutto quello che disegna cuce e crea – e poi la mattina dopo ti ritrovi che ti piace.
Anderson e la cultura dei designer inglesi
Anderson è inglese, scende da una genealogia immaginifica di designer britannici che non volevano presentare abiti belli – volevano scavarti le guance, pungerti gli occhi. Westwood, McQueen, Galliano, Isabella Blow – Jonathan Anderson a ragione, vuole sottolineare la sua appartenenza a questa matrice creativa. Con Anderson, si può ritrovare quell’umorismo inglese che è una freddura, il verde brilla perché piove sempre. La parrucca gialla, le paillette, le controspalline con le frange prese dalla fantasia militare già negli anni Settanta per ammaliare la scena rock musicale. Le giacche corte, da uomo sopra la vita, i pantaloni ultra-stampati, i bomber. Tutto il clubbing lascia poi spazio a capi sartoriali – un cappotto lungo, l’abito sagomato – che vorrebbero mettere tutti. Una questione di styling: pezzi che nessuno metterebbe, mescolati a pezzi che tutti vorrebbero. Il riferimento a Paul Poiret è comprensibile, ma non è necessario alla lettura del lavoro di Anderson.
Tra Milano e Parigi, due città e due modi
Come sono diverse Parigi e Milano. Parigi snob strafottente, la città di taxisti antipatici dei ragazzi che si sentono (che sono) fighi in ogni bistrot, che si siedono all’aperto con la camicia slacciata a gennaio, anche se piove o se nevica. Parigi che ogni cosa che fai deve essere costruita per soddisfare la vanità. Parigi dove tutto è una posa perché la città e talmente bella nonostante l’immondizia urbana. Non puoi fare altro che sentirti sopra a un palco.
Parigi – davvero, così diversa da Milano. Milano dove prima di tutto si lavora per guadagnare – dove Prada ti ripete sì, tutto wow, ma poi si tratta di vestiti che la gente deve comprare. Milano – tu vola alto ma poi meglio sapere come atterrare veloce. Milano dove si vive dietro i portoni, dove lo snobismo è understatement, dove non c’è il decoro ma c’è il design. Nei salotti ci sono più libri da leggere che da sfogliare mentre a Parigi, i libri sono grandi, fotografici e fantastici, e decorano i tavolini ai lati del divano, la consolle di fonte alla porta di ingresso. A Parigi, con Dior, c’è il Rococò di Versailles – a Milano abbiamo solo un razionalismo moderno.

Jonathan Anderson e la superbia, la ricchezza, di Dior
Jonathan Anderson da Dior: una mondo celebrale, la cultura inglese, che si sposa con la massima icona del lusso mondiale: Dior, che ricorda l’oro. L’amministratrice delegata è una regina imperiale. Dior che può permettersi ogni superbia, ogni altezzosità, ogni ricchezza – perché questo è Dior, fino all’eccesso –per definizione il lusso non ha limite all’eccesso. Dior simbolo di Parigi, che potrebbe ristabilire l’Ancient Regime e sbadigliare di fronte a uno stupido rimando al 1789. Dior oggi è disegnato da un ragazzo inglese, alto, con gli occhi azzurri e un po’ stanchi per il troppo lavoro, che parla con una mano nella tasca dei jeans, sembra timido ma non lo è.
Jonathan Anderson è forse il designer più rispettato dall’industria della moda oggi. Per Loewe aveva portato uno shock all’artigianato di ispirazione spagnola. Con la sua marca, oggi, reinventa un armadio dove i vestiti si intervallano alle persone, ai ricordi, ai riferimenti pop. Anderson e le sue magliette “I told ya” con Guadagnino – e quella altra ancora “drink your milk” – in riferimento alla serie Fellow Travellers con Matt Boomer e Jonathan Bailey – questo secondo, il primo attore gay a essere considerato l’uomo più sexy al mondo – il gioco con la sua controfigura, il ballerino Ivan Ugrin – tutti a ripetere drink your milk quasi come fosse una minaccia – perché il latte fresco in grandi sorsi rischia quella sciolta che non è gradita durante l’intercorso gay.
Anderson oggi da Dior – come riesce e come riuscirà a mescolare tutta questa sua cultura alta e bassa, snob e pop, link e interlink culturali, ironia inglese – con l’assioma massima del lusso e della ricchezza, con i nuovi clienti in Asia o in Arabia, dove il lusso richiede compostezza, bellezza, ricamo e perfezione?
Jonathan Anderson, maestro di artigianato
Anderson è un maestro del design applicato all’artigianato. Le sue idee capita siano realizzabili solo a mano perché non esistono macchine abili o tecnologiche abbastanza, per stare dietro alla sua fantasia. Una fantasia che non ha confini – per fortuna, il caso da dire, oggi che sembra possibile sia un’intelligenza artificiale a dare sfida alla fantasia umana. Anderson continua ad avere il plauso di chi scrive e di molti, quanti altri. Anderson ci invita ad aspettare la prossima – perché ne vogliamo ancora, di questa sua crasi tra ironia e sapere, questa sua sepsi tra bellezza e schianto.
Intanto, sia a Milano sia a Parigi, della stampa interessa poco o niente – sia perché la maggior parte dei giornalisti sono diventati cicisbei con scia di bava alla caccia di selfie con celebrities, sia perché al posto dei giornalisti ci sono gli influencer che al posto di opinioni procurano pubbliche relazioni, amplificatori di quanto vogliono farsi vanto di dirsi spettatori.
Carlo Mazzoni