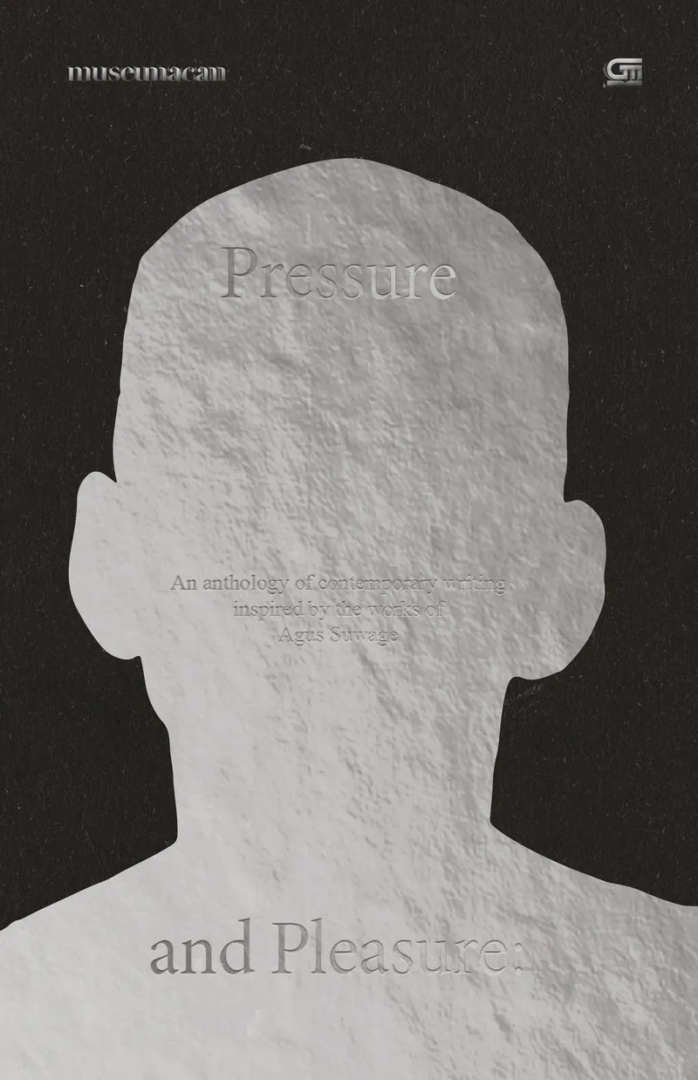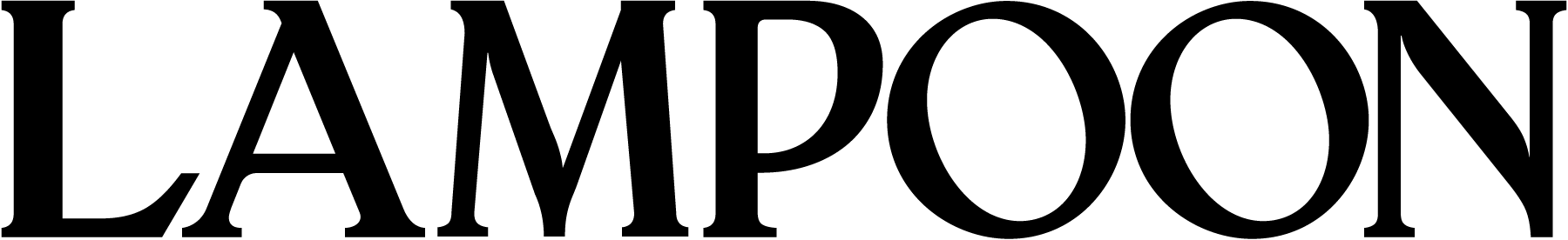Corpi che disobbediscono: l’arte è collettiva nell’Indonesia contemporanea
Dai movimenti nati sotto il regime di Suharto ai collettivi post-Reformasi, fino al Max Mara Art Prize a Jakarta: l’arte indonesiana usa pratiche condivise e attivismo come spazio pubblico
Corpi in rivolta: dal gesto collettivo alla pratica contemporanea
Uno degli aspetti che caratterizza la lettura occidentale dell’arte indonesiana è la sua inclusione, insieme a quella dei paesi più o meno limitrofi, sotto un unico ombrello definito “Arte orientale”. Ancora oggi gran parte dell’attenzione verso l’arte del sud est asiatico, influenzata da un retaggio orientalista che divide i paesi del primo e del terzo mondo, è rivolta soprattutto all’arte folk e all’archeologia. Impareggiabile il confronto con il fenomeno che ha riscosso maggiore successo in Europa, quello del japonisme, confermato dalla mostra dedicata a Hokusai al Palazzo reale di Milano che ha celebrato il centocinquantesimo anniversario dal Trattato di amicizia sottoscritto da Regno d’Italia e Impero del Giappone.
Fino agli anni Novanta, la critica occidentale ha trascurato i movimenti indonesiani nati per sopperire alla stagnazione delle accademie, dipendenti dal primato di pittura e scultura. A metà degli anni Settanta, infatti, gruppi di giovani studenti universitari iniziarono a mettere in discussione questi modelli dominanti. Il Gerakan Seni Rupa Baru (Indonesian New Art Movement) nacque a Jakarta sotto il regime dittatoriale instaurato da Suharto (1967-98), proponendosi non solo come portavoce di una riforma artistica, ma anche come atto di protesta politica per i temi affrontati nelle opere. Gli artisti che diedero vita al movimento, tra cui FX Harsono (1949) e Jim Supangkat (1948), presentavano opere e installazioni realizzate con collage, fotografie e oggetti provenienti dalla vita quotidiana, non solo per scardinare le pratiche artistiche tradizionali, ma anche per ridefinire il ruolo dell’artista in relazione alla società che lo ospita.
La nascita dei collettivi nell’era post-Suharto
In Italia, pochi anni prima, si sviluppava con premesse simili il movimento dell’arte povera, coniato da Germano Celant attraverso la parola “guerriglia”. Se quella spinta è stata col tempo assorbita dal mercato, proprio il suo successo ha contribuito alla diffusione di un messaggio tutt’ora valido: utilizzare nuovi linguaggi espressivi per scuotere le istituzioni. Così anche il GSRB normalizzò l’utilizzo di tecniche non convenzionali, come materiali industriali, testi e immagini mediatiche, per aprire un confronto diretto con il pubblico.
Un punto di svolta per l’arte contemporanea in Indonesia risale alla fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, grazie ad eventi come la 9° Biennale di Jakarta (1993), che consacrò nel paese nuove forme espressive, come il video, l’installazione e la performance. La crisi economica e politica del 1997-1998 e la caduta del regime di Suharto influenzarono la produzione artistica e accelerarono la circolazione di opere non convenzionali. Artisti come Arahmaiani, Agus Suwage, Mella Jaarsma, Dadang Christanto e Heri Dono svilupparono opere che affrontavano temi legati a identità culturale, religione, migrazione, trasformazioni sociali e denuncia della violenza politica, attraverso sia i media più tradizionali, sia il copro e le installazioni.
Durante questa fase, nota come Reformasi, lo scuotimento della situazione politica ed economica spinse l’arte a diventare uno spazio di dibattito pubblico, consolidando il rapporto tra pratica creativa e attivismo politico. I lavori di questo periodo affrontano temi come le rivolte e le questioni legate ai diritti umani. In un contesto così fragile una risposta compatta arrivò dai numerosi collettivi di giovani artisti, come Apotik Komik e Taring Padi, che introdussero fumetto, animazione e grafica digitale nelle loro opere, ampliando ulteriormente il campo dei media utilizzati. Grazie anche al supporto di un sistema dell’arte sempre più libero, si sono potuti affermare opere controverse come Pressure and Pleasure (1999) di Agus Suwage, in cui il tema erotico è affrontato attraverso locandine pubblicitarie soft-porno installate all’interno di una tenda militare.

Max Mara Art Prize: residenze formative per artiste tra l’Italia e Londra
Il Max Mara Art Prize nasce nel 2005, da una riflessione sul fatto che in Occidente le donne votate a una carriera artistica non abbiano le stesse opportunità dei colleghi uomini. A dare concretezza all’idea di sopperire a questa sproporzione, col sostegno del Presidente di Max Mara Luigi Maramotti, ha contribuito il supporto della Whitechapel Gallery, una delle prime gallerie a finanziamento pubblico, fondata a Londra nel 1901 con l’intento di democratizzare l’offerta artistica nel quartiere popolare dell’East End. Da qui la coerenza del progetto di legare un’azienda come Max Mara, nata negli anni Cinquanta con l’obiettivo di reintegrare la manodopera femminile in fabbrica alla fine della guerra, a una galleria orientata verso il pubblico, attraverso un premio dedicato alle artiste donne.
La cadenza biennale del premio, oltre a scongiurare la saturazione del progetto, consente a ciascuna edizione di smarcarsi in modo significativo dalla precedente. Fino all’edizione corrente, rinnovatasi nella forma, il premio consisteva in una residenza di sei mesi tra Roma e Biella, un vero e proprio tour formativo nel solco del Grand Tour ottocentesco, storicamente riservato agli uomini. I lavori venivano poi esposti presso la Whitechapel Gallery e la Collezione Maramotti di Reggio Emilia.
Un nuovo contesto geografico
La scelta di collaborare a partire da questa edizione con il Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara (MACAN) di Jakarta – fondato nel 2017 e primo museo di arte contemporanea in Indonesia – avviene in un momento delicato per l’azienda, impegnata a gestire le proteste dei dipendenti dopo le accuse di caporalato. Il premio, riservato esclusivamente alle artiste donne e aperto a “chi si identifica nel genere femminile”, rappresenta un’opportunità per riabilitare l’immagine dell’azienda. Spostare l’attenzione verso un paese in via di sviluppo come l’Indonesia, segnando l’interruzione della ventennale collaborazione con la Whitechapel Gallery, diventa un’occasione per superare l’eurocentrismo che aveva caratterizzato il premio fino a oggi. Lo spostamento geografico assume così una sfumatura provvidenziale, inaugurando quella che viene definita la nuova natura “nomadica” del premio.
Quella di spostare l’attenzione su un paese così poco conosciuto in Italia è una scelta consapevole. La sua conformazione geografica, costituita da oltre 17.000 isole, riflette la molteplicità di culture che abitano il Paese. Con più di 265 milioni di abitanti – è il quarto paese più popoloso al mondo – l’Indonesia intreccia etnie e religioni che derivano tanto da tradizioni autoctone quanto da una plurisecolare storia coloniale. Questa varietà di voci trova espressione negli artisti nati tra gli anni Settanta e Ottanta, come Melati Suryodarmo, Uji ‘Hahan’ Handoko Eko Saputro, e Tintin Wulia, e in particolare nei collettivi artistici come Ruangrupa e Taring Padi, che hanno ottenuto grande visibilità in Europa nel 2022, durante Documenta 15 a Kassel, a seguito delle accuse di antisemitismo.
Il premio tra rinnovamento generazionale e dialogo con l’Indonesia
Il premio si rinnova anche rispetto al contesto generazionale a cui si rivolge. La scelta di segnare una discontinuità con il passato, individuando come partner un museo indonesiano, trova giustificazione in un paese in cui – come ha sottolineato la nuova curatrice del premio Cecilia Alemani – “oltre 68 milioni di persone hanno meno di 25 anni”. L’età mediana in Indonesia è infatti di circa 30 anni, quasi venti in meno rispetto all’Italia: un dato che evidenzia la centralità della popolazione giovane, la stessa che è solita frequentare il MACAN. La direttrice del museo, Venus Lau, aveva collaborato con Alemani in occasione della Biennale di Venezia 2022 da lei curata, in veste di advisor per il Sud-Est asiatico.
Time for Women, la mostra che ha celebrato a Palazzo Strozzi il ventennale del premio (aprile-agosto 2025), è stata l’occasione per riaffermare il legame con le nove artiste vincitrici delle precedenti edizioni: Margaret Salmon (1975), Hannah Rickards (1979), Andrea Büttner (1972), Laure Prouvost (1978), Corin Sworn (1975), Emma Hart (1974), Helen Cammock (1970), Emma Talbot (1969) e Dominique White (1993). Una delle peculiarità del premio è l’attenzione dedicata non solo alle vincitrici, ma a tutte le partecipanti. Il processo di selezione e l’incontro tra giurate e candidate contribuiscono a creare una vera comunità che si sviluppa nel tempo. Questo senso di collettività trova un parallelo in un contesto come quello indonesiano, dove il sistema dell’arte si è sviluppato soprattutto dal basso, attraverso iniziative indipendenti e spazi autogestiti.