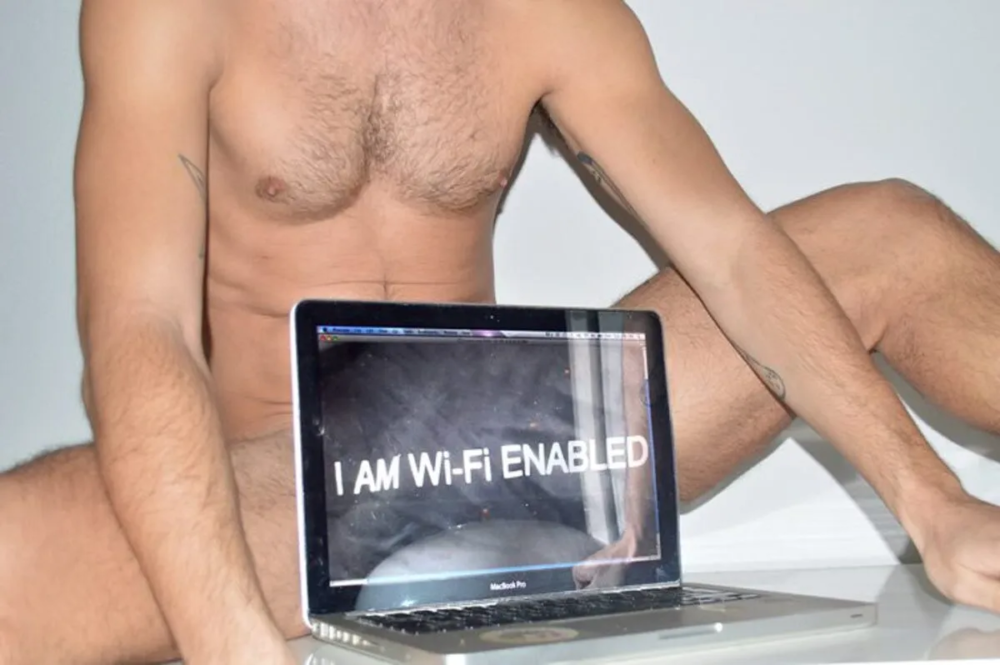Parthenope: Sorrentino, meglio i vecchi che si riscoprono giovani
Idealizzazione della giovinezza e sublimazione del sesso – Parthenope è una napoletana di buona famiglia con un fratello irrisolto che ripugna il lavoro. Dove è finita la ruvidezza di Sorrentino?
Parthenope. Bellezza, intelligenza e monotonia
Con Parthenope Sorrentino non infonde ai suoi personaggi la forza di reagire ai drammi dell’esistenza – se non scegliendo di troncarla. Nessun Sean Penn di This Must Be the Place (2011) all’orizzonte. Stagnano questi esseri umani partenopei, le loro azioni sono spesso inconcludenti. Avanzano affranti. L’orizzonte racchiude un futuro molto più grande di noi, dice Parthenope all’adorante Sandrino. Attendono questo divenire: non si sottraggono al fato ma non ne sono certo il demiurgo.
La giovane Parthenope – Celeste Dalla Porta – prende il sole nel palazzo di famiglia a picco sul mare, mentre incanta tutti con il corpo dalle pose a La grande odalisca di Ingres (1814) e risposte pronte che derivano dal leggere testi universitari. Leggo e studio molto, afferma. Tanto bella e sa pure cogitare (!). A cosa stai pensando?, chiedono più volte i maschi semi-eccitati alla giovane donna. Non una sibilla, non un’odalisca né una futura matriarca partenopea – ma c’è spazio anche per questa figura nel film di Sorrentino. Parthenope naviga a vista e quasi per inerzia diventa professoressa ordinaria di antropologia all’Università di Trento.
Paolo Sorrentino. Dall’interesse per l’odore delle case dei vecchi a quello per i giovani
Almeno fino al penultimo film È stata la mano di Dio (2021), i ricordi nei lavori di Sorrentino sono proiettati nell’avvenire. L’analessi non è crogiolo di memorie stagnanti, più un dispiegarsi di motivazioni che conducono a un certo stile di vita, a un sentire dei suoi personaggi. Con Parthenope, il cui impianto si fonda sul flashback tanto quanto sul trionfo del tabagismo, la rotta s’inverte. Sorrentino afferma che da giovane il suo interesse era rivolto agli anziani; repetita iuvant: «cosa c’è di più bello nella vita? E tutti rispondevano: la fessa! Io solo rispondevo: l’odore delle case dei vecchi» (La grande bellezza, 2013). Oggi il regista cinquantaquattrenne pare volgere lo sguardo verso i giovani. Lo fa con una certa dose di malinconia e irresolutezza, narrando la vita di una donna nata nel 1950 che può simboleggiare Napoli, tanto quanto l’ennesimo dramma borghese.
Parthenope. Paolo Sorrentino porta al cinema la malinconica gioventù napoletana
Dalla riscoperta della giovinezza a 1560 s.l.m., a quella ricordata sul golfo di Napoli. Era il 2015, Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino metteva assieme un cast internazionale – da Michael Caine protagonista a Rachel Weisz e cameo di Jane Fonda – con un finale che attraverso la voce di Sumi Jo erutta in un’ode alla volontà di esistere, nonostante tutto. I feel complete / I lose all control / I hear all that is left to be heard, recita il testo di David Lang. Meno di dieci anni dopo, Parthenope (2024) suona più come un pastiche musicale che tenta di raggiungere a momenti la solennità del Requiem per poi fiaccarlo con slanci alla Piemontesina Bella.
L’incanto borghese del film si tronca a partire dal suicidio del fratello di Parthenope – un carro trainato da cavalli neri sul lungomare di Napoli vorrebbe riecheggiare un Lacrimosa dies illa – per poi risolversi nei sospiri e mezzi sorrisi finali della protagonista. Il film chiude con Stefania Sandrelli nei panni di una ormai pensionata Parthenope che torna a Capri, dove il fratello si lasciò precipitare. Una versione âgée della protagonista, più vicina al brano per sale da liscio di Enrico Frati (1932): La gioventù non torna più /Addio bei giorni passati / Gli studi son già terminati / Abbiamo finito così di sognar / Lontano andrò, dove non so / Dammi l’ultimo bacio d’amor.
Amore e sesso in Parthenope. L’estasi di una santa mancata
«Gli amori giovanili non sono serviti a niente», dice Parthenope nell’addio a Sandrino. Lui ribatte, «forse a darci l’illusione della spensieratezza?». «Appunto, inutili», chiude lei.
Dai tabù – l’intimità fisica con il fratello – a rifiutare l’amplesso con il bauscia milionario sotto le stelle di Capri. Il personaggio di Parthenope si concede a un boss camorrista mentre pensa di diventare attrice – idea che accantona perché i suoi occhi sono tristi e la cinepresa questo non lo tollera. L’orgasmo è raggiunto donandosi a un cardinale. Mentre i suoi versi di appagamento si espandono in Cattedrale, il sangue di San Gennaro si liquefà. Estasi grottesca di una santa mancata.

Parthenope è il contrario di ruvido, mentre Napoli una donna che galleggia sul tempo
Parthenope appassisce facendo esperienza. Come Napoli per Sorrentino? Un ossimoro esistenziale. Più che trarne beneficio o senso, la protagonista galleggia sul passare degli anni. Sugli sguardi, sulle bocche baciate, le erezioni procurate, sul senso di colpa, su genitori sfumati e frantumati da dolori taciuti. Parthenope potrebbe colpire per sensibilità, meno per intraprendenza. Parthenope è il contrario di ruvido. È levigato, soffice come il volto della sua protagonista.
La sospensione del giudizio pattuita con il professore – Silvio Orlando – e il trenta e lode donato alla studentessa incinta assurgono al concetto di Kitsch. Il beneficio del tempo allevia i dolori di Parthenope pensionata. Torna pacificata a Napoli, che ha lasciato per decenni. Sembrava impossibile per metà del film, eppure. Sorride al carro in festa per la vittoria del terzo scudetto. Titoli di coda.
Restare a Napoli è una semi-condanna per Sorrentino? La riqualificazione del Quartiere Sanità, ad esempio, non incontra il gusto del regista? Nessun accenno. Napoli pare debba essere statica nel suo torpore.
Paolo Sorrentino. Auto-citazionismo manierista
Non serve scomodare il nome di Eduardo De Filippo. Parthenope richiede poco più di due ore al cinema dove si passa in rassegna l’intera cifra sorrentiniana – spesso in debito con l’occhio di Fellini e Antonioni. Patchwork dei lavori passati, del già visto. Dall’abuso di sigarette, alle feste private, allo psico-divismo, al figlio malato. Prelati che fumano, esibizione di dolore e malinconia sospese dal ballare a tarda notte. Invettive condite con parrucche volanti in testa ad attrici decadenti: Greta Cool segue l’esempio della diva del cinema Brenda Morel – Jane Fonda in Youth, che la perde in aeroplano dopo una scena di rabbia. Il personaggio del figlio allettato, in questo caso ciclopico, torna dopo l’episodio veneziano di The New Pope (2020). Insomma, Sorrentino pare applicare un manierismo ma sul se stesso di un passato recente. Un ripetersi che si fonda sulla maniera dei suoi “antichi” lavori. Refrain depotenzianti?
Parthenope e la collaborazione con Saint Laurent
Tra idealizzazione della giovinezza e sublimazione del sesso, Parthenope è una napoletana di buona famiglia con un fratello irrisolto – sensibile – che ripugna il lavoro. Le dicotomie, i cortocircuiti di Sorrentino faticano a stupire. La direttrice della fotografia Daria D’Antonio immortala i costumi affidati a Carlo Poggioli che collabora con Saint Laurent secondo Anthony Vaccarello – la maison francese è anche produttore del film. Camicie bianche, jeans, giacche strutturate. Gusto anni Settanta. Omaggio allo smoking femminile YSL, indossato da Della Porta mentre i corpi degli invitati a una festa seguono Malambo No. 1 di Yma Sumac.
In Parthenope di Paolo Sorrentino c’è spazio per tutto, anche per essere tristi
La protagonista si laurea con una tesi che affronta Le frontiere culturali del miracolo. Il suo mentore-relatore le svelerà anni dopo che l’antropologia è saper vedere. In Parthenope si guarda molto perché c’è spazio per tutto ma si vede poco. Gioventù, corpi bagnati, famiglie attorno al tavolo, miseria, sesso, costumi attillati, scrittori alcolizzati – Gary Oldman e la battuta can you smell the scent of dead loves?
Abbracci, soldi, balli notturni, suicidio, benedizioni e prime notti di nozze voyeuristiche. Senso di colpa, rimpianto, misticismo religioso, amore — troppo o troppo poco. C’è spazio per tutto nel film, come nella Napoli vista da Sorrentino. Tranne che per il nuovo. Che film balordo.