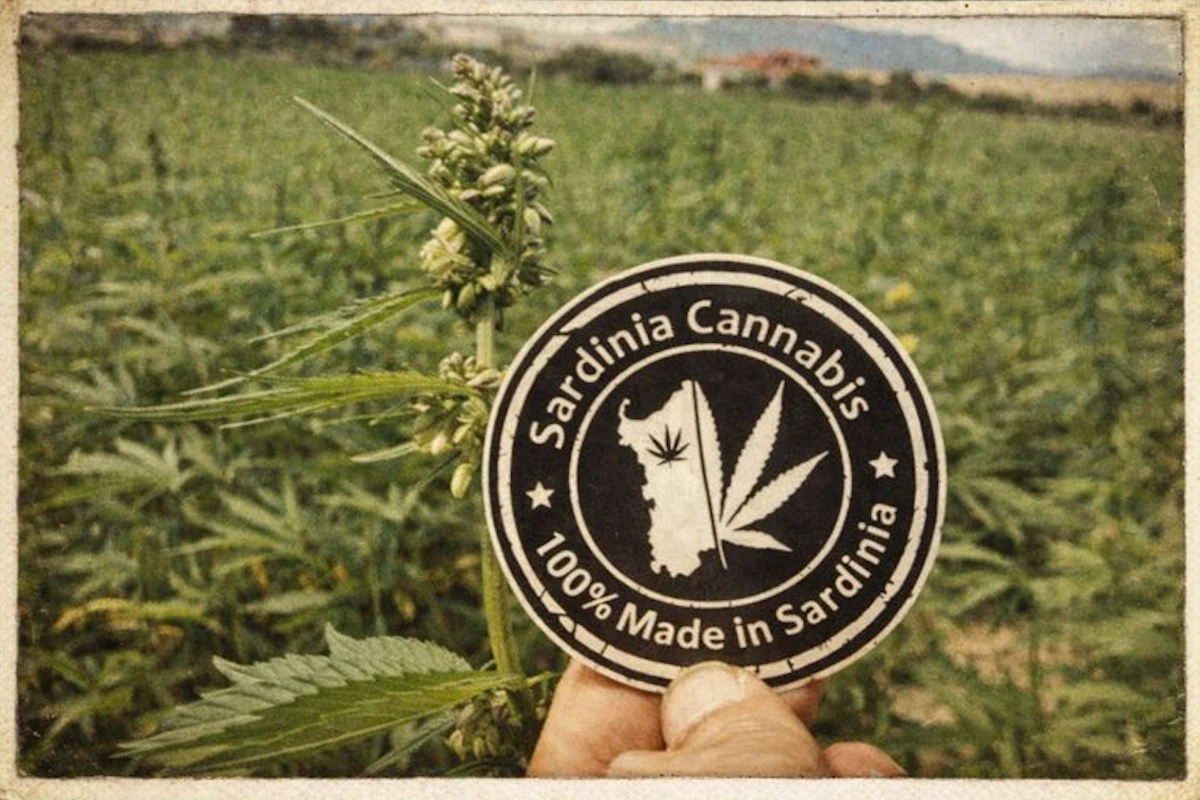Chi vince a Sanremo? Pronostici corrotti e cultura popolare italiana
Sanremo e il nostro Paese, televoto e massa popolare, canzoni sotto la doccia: la nostalgia scoppia per quei momenti che Sanremo trasformò in immagini
Sanremo, chi vince? Giorgia, pronostici e previsioni, da Aragozzini al televoto
Negli anni Novanta, la previsione era una certezza. Quando Sanremo lo vinsero i Pooh, Riccardo Cocciante, Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri – la sensazione fu quella di una vittoria annunciata. Erano gli anni in cui Adriano Aragozzini copriva il ruolo di patron e produttore esecutivo del Festival: oltre ai facili pronostici, si deve a lui il ripristino dell’interpretazione dal vivo invece che in playback. Già l’anno successivo, quando vinse Aleandro Baldi, nessuno era così certo di come sarebbe andata – e tanto meno nel 1995, quando per la prima volta le Nuove Proposte avrebbero scalato la classifica finale con i cantanti affermati, e Giorgia salì al primo posto (Come Saprei). Da lì in avanti, niente fu prevedibile: ogni anno cambiavano le regole della giuria – il televoto, il campione demoscopico, giurie di qualità reperite con criteri ambigui, il voto stampa. Sorvolando su i fiumi di parole, quando nel 1999 al primo posto salì Anna Oxa ci fu polemica: un giurato aveva dato zero a tutti tranne dieci a lei, e pare che questo avesse decretato il risultato finale. Questo anno nel 2025, trenta anni dopo quel 1995, tutto sembra portare alla previsione della vittoria di Giorgia: la canzone scritta da Blanco non mette in eccessivo sforzo la sua trachea, la melodia trova un poco di modernità e ritmo. I vestiti di Dior ne aiutano la rispettabilità. Il gioco è ed era dall’inizio con Simone Cristicchi, Ollie e Achille Lauro.
Sanremo, il pubblico generalista e il potere della massa popolare
Durante gli anni Duemila, qualcosa di anomalo continuava a succedere: Povia nel 2006 con quelli che volevano il becco, Valerio Scanu con il suo amore in tutti i laghi, diedero adito a sospetti, lasciando il sentimento della massa alterato, un senso di cultura popolare troppo basso anche per un pubblico generalista. Un pubblico generalista che sì, per definizione, segue il carro qualunque esso sia – ma se si tratta di canzonette a Sanremo e non di tangenti, quando il carro vira sul baratro, il nostro pubblico generalista reagisce e impunta i piedi. Siamo tutti qui – giornalisti, imprenditori, politici – a cercare di ragionare sulla forza della massa popolare: che la massa sia intesa come lettorato o elettorato, come pubblico o clientela, lo sforzo per provare a sfiorare il suo potere assoluto è richiesta anche agli strati di cultura intellettuale.
Sanremo, Geolier, Angelina Mango, i call center in Campania, il televoto e Marco Mengoni
A Sanremo, solo l’anno scorso, ci fu il clamore, il dubbio su un meccanismo comandato: vinceva Angelina Mango in corsa con Geolier fino all’ultimo metro. In Italia eravamo in tanti a non avere mai sentito il nome di Geolier prima di quei giorni di febbraio: ci fu spiegato che Geolier aveva un seguito locale in Campania, e che tutta la regione si era attaccata al televoto pur di farlo vincere. C’era chi supponeva che tra i fan di Geolier ce ne fossero alcuni in grado di attivare i numeri da call center che in Campania hanno sede operativa. Rimanevano illazioni. Il voto della stampa e il voto demoscopico riuscirono ad arginare il televoto esploso dalla zona di Napoli e insieme fecero vincere la Mango. Polemiche e rancori raccontavano il nostro Paese ancora segnato dal pregiudizio, dalla furbizia, e da uno scarso senso di cultura unificata, da una divisione tra Nord e Sud ancora più violenta di quanto vogliamo supporre.
A pensare che solo un anno prima, nel 2023, tutti erano stati unanimi nella vittoria di Marco Mengoni: in quei giorni, sembrava di essere tornati ai giorni di Aragozzini, appunto, con la certezza sul pronostico. Mengoni è un personaggio che unisce: su ogni età, classe sociale, genere e fluidità. La canzone sembrava forse troppo ragionata a tavolino – ma il risultato fu preciso, un’equazione matematica. Lazza arrivava al secondo posto con una canzone che avrebbe lavorato in radio tutto l’anno.
L’autotune a Sanremo: la direzione artistica di Amadeus e di Carlo Conti
Sanremo, specchio della cultura popolare. Esponenziale rispetto al calcio del campionato domenicale, divisivo: se di fronte alla nazionale nella finale europea siamo tutti azzurri, davanti a Sanremo ci risvegliamo nel Medioevo: tanti piccoli comuni isolati che litigano tra loro a suon di spade, batoste e autotune. Quando arriva il Festival di Sanremo si mostrano le varietà umane su scala sociale – e comprendiamo qui meglio che altro come il reddito pro-capite non trova quasi mai un corrispettivo con una dignità culturale. D’altra parte, cosa può significare la parola cultura se associata al Festival della Canzone italiana? Niente?
L’anomalia comincia dalla direzione artistica in questi ultimi anni. Amadeus, Carlo Conti. Sia conduttori sia direttori artistici – ovvero responsabili della scelta degli artisti e dei brani in gara. Il primo, Amadeus, è cresciuto e si è formato nella scuderia di Claudio Cecchetto negli anni Novanta. Possiede un’esperienza professionale in discografia e radio che gli ha permesso di ottenere la fiducia dell’industria e dei cantanti. Carlo Conti non può competere. Bisogna riconoscere ad Amadeus l’abilità a far salire su quel palco cantanti che non ne avevano bisogno, e che ne correvano solo un rischio – Mengoni, per esempio: se non avesse ottenuto una vittoria così massiccia, la sua reputazione ne sarebbe stata graffiata – così come infatti è successo a Ultimo. Il cristallo di Amadeus si rompeva sulla conduzione: quando la banalità, il luogo comune, la ripetizione e la pedanteria con cui si rivolgeva alla cara, carissima, casalinga di Voghera, strideva con gli artisti scelti pensando alle classifiche di Spotify generate dalle Generazione Z.
Intanto Carlo Conti è pronto a rallegrarci con la stessa retorica che troviamo in una predica alla messa, sempre nella parrocchia di Voghera. Nella lista di Conti non ci sono nomi presi dalle classifiche. Quando al TG1, quella domenica di dicembre, veniva rilasciato l’elenco, l’ultimo nome, come un gran finale, era Giorgia. Un’analisi professionale della vocalità di Giorgia rileva una diminuzione della vibrazione della sua maschera, ovvero l’osso che racchiude la cavità e i seni nasali. Se la maschera vibra meno, il suono si diffonde su un range di frequenze meno ampio. L’effetto è un canto che si può intendere più gracile – e coincide con quanto si poteva ascoltare, con l’inedito di due anni fa.
L’autotune a Sanremo: Giorgia, l’analisi vocale, il canto in maschera, le frequenze, il cry
Oggi, il trap usa l’effetto dell’autotune, per bloccare le frequenze su una nota, annullando completamente il vibrato. L’autotune amplifica la potenza e il volume su una frequenza precisa, invece che su più frequenze armoniche tra loro. Ovvero, l’autotune si ferma su una nota invece che su un accordo – mentre la voce naturale, facendo vibrare più ossa del corpo umano, produce un accordo. Storicamente, questa varietà di frequenza, questo accordo, si intende come qualità della voce umana.
Un’altra tecnica che il canto di questi anni sta via via scartando è il cry – ovvero, l’inclinazione dell’epiglottide per ampliare il suono in testa con la vibrazione delle spalle. Il cry è il settaggio del canto lirico, che viene usato in musica pop per dare un effetto che si può intendere più rotondo e che permette anche l’eventuale accenno di vibrato. Giorgia è sempre più attenta al network, alle collaborazioni, e ai social media, piuttosto che alla sostanza del suo lavoro (così come altre cantanti del suo calibro, vedi Fiorella Mannoia); Giorgia avrebbe voluto usare l’autotune come Tony Effe. Sembra le sia stato sconsigliato.
Raimondo Vianello, Eva Herzigova e Veronica Pivetti a Sanremo nel 1997
Era il 1997 quando Raimondo Vianello conduceva il Festival di Sanremo. Per la prima volta, il pubblico era più attento al presentatore che alle canzoni. I dialoghi con le sue due vallette, Eva Herzigova e Veronica Pivetti erano elaborati dai suoi autori – Vianello li sapeva evolvere in una dinamica d’autore. La domanda apparirebbe retorica, se mi chiedessi ancora e ancora dove sono fini quelli lì, quelli tipo Raimondo Vianello – ma per chiudere queste mie inutili righe di ragionamento su questi giorni del festival, torno agli anni di Aragozzini.
I pronostici erano vittorie annunciate. Vero – la domanda allora è un’altra, meno retorica. Si stava meglio quando c’era qualcuno che sceglieva bene per noi? Staremmo tutti meglio se invece che una maledetta maggioranza numerica, a scegliere per noi ci fosse una mente istruita, acculturata, capace e professionale? Stiamo parlando di canzonette, ma potremmo sfasare e porci questo su altro. Certo, dovremmo avere fortuna: se a scegliere per noi è uno illuminato, tutto va bene – ma se ci ritroviamo un incapace, un pazzo scriteriato? Il timore è che l’ambiente intellettuale e culturale da cui il nostro illuminato dovrebbe emergere si sta sciogliendo come i ghiacci in Groenlandia; e che i suoi neuroni siano già atrofizzati da un persistente e costante scrollo su Instagram.
La nostalgia di Sanremo – Gli Uomini Non Cambiano, Portami a Ballare, Se Stiamo Insieme – Aragozzini e quel Trottolino Amoroso
La nostalgia scoppia per quei momenti che Sanremo trasformò in immagini culturali. Era il 1992 quando Mia Martini cantò Gli Uomini non Cambiano: si disse che la canzone era troppo dura, troppo letteraria e drammatica, per essere il titolo vincitore di un festival popolare. Non è vero. Se capita di rivedere quel video, sulla strofa finale, gli italiani si sentono un popolo unito. Ancora, in quegli anni di Aragozzini: Luca Barbarossa vinse con Portami a Ballare, dedica alla madre, di nuovo letteraria, meno dramma, più poesia – si potrebbe studiare a scuola. Riccardo Cocciante, con Se Stiamo Insieme. Vero, tutte canzoni d’autore – chi se le ricorda oggi, se non uno come me che scrive sempre e solo di nostalgia.
Sanremo è per la massa. Sanremo deve produrre il ritornello da cantare sotto la doccia, la canzone da mettere la domenica in macchina con tutta la famiglia. Mi sembra di vederlo, Aragozzini – chissà che sorriso gli si dipinse in faccia quando, nel 1990 sul palco del Palafiori, in due si misero a cantare Trottolino Amoroso. Popolare e nostalgico – ma la cultura si costruisce con la leggerezza.
Carlo Mazzoni