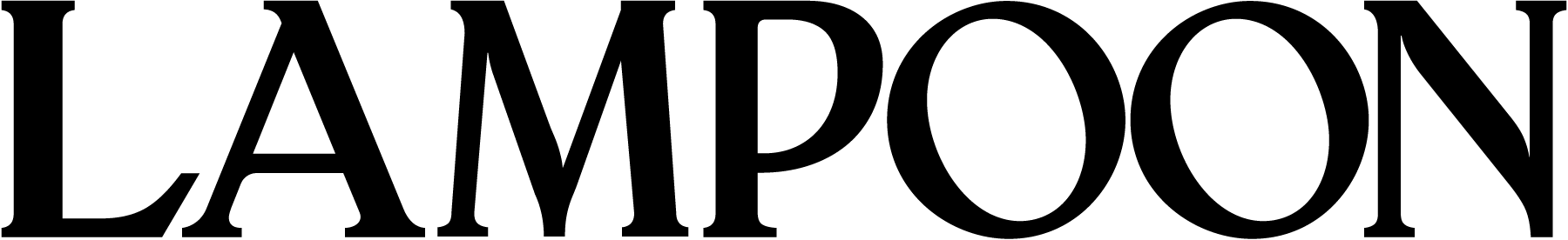Sanremo 2026, il paese dei figli di
Da Sanremo 1989 ai Big 2026: figli d’arte, eredi e cognomi pesanti dominano il cast. Il Festival come tutorial del privilegio culturale in un Paese dove l’ascensore sociale è pressoché fermo.
Un’altra edizione del Festival che non cambia: Sanremo 2026
Sanremo non è ancora iniziato, ma il Paese sa già cosa guarderà: non tanto una gara di canzoni, più un albero genealogico in diretta. Trenta “Big” sul palco dal 24 al 28 febbraio, direzione Carlo Conti. In mezzo a nomi che conosciamo da anni – Patty Pravo, Fedez, Raf, Arisa – la didascalia che rimbalza ovunque è una sola: «figli d’arte ed ereditiera all’Ariston».
Tredici Pietro, LDA, Leo Gassmann, Elettra Lamborghini: quattro persone diverse, una stessa categoria. Sono tutti artisti che lavorano, incidono, portano in giro dischi e live – ma il motivo per cui finiscono nei titoli non è questo. È il cognome. Ogni scheda comincia allo stesso modo: «figlio di», «nipote di», «erede di». È il dettaglio che sposta l’asse del Festival. Sanremo 2026 non viene raccontato come line-up, ma come puntata nuova di una soap dinastica. Prima la famiglia, poi – se avanza spazio – la musica.
L’eccezione non annulla la regola strutturale. Il problema non è l’esistenza di figli d’arte, è la saturazione degli spazi: quanti debuttanti senza cognome riconoscibile, senza legami pregressi con il sistema Rai, vediamo realmente promossi dalla macchina sanremese? Quanti arrivano al Festival da fuori circuito, fuori scuole di talent, fuori uffici stampa già agganciati?
Sanremo è una delle rare piazze pubbliche ancora in grado di cambiare la vita di un artista emergente. Quando metà del racconto è occupato da genealogie illustri, il segnale che passa al resto del Paese è chiaro: la scorciatoia ereditaria non è un’anomalia, è norma.
L’Italia fuori dall’Ariston: un Paese dove l’ascensore sociale è fermo
Fuori dall’Ariston, la musica non cambia. Gli studi sulla mobilità sociale lo ripetono da anni: in Italia il destino di un figlio somiglia in maniera imbarazzante a quello dei genitori. L’ascensore sociale è fermo tra due piani; per chi nasce in basso si parla di generazioni necessarie per arrivare al reddito medio. Non è sfortuna: è progetto immobilista politico.
La fotografia è nota: il reddito, il titolo di studio, il lavoro dei genitori pesano in modo decisivo sul futuro dei figli. Chi nasce nel 10% più povero ha probabilità bassissime di raggiungere la media nazionale in una sola vita. Le chiamiamo «disuguaglianze», ma nella pratica sono vincoli di nascita.
Università, giornali, ordini professionali, partiti: ovunque ci giriamo troviamo padri che lasciano le chiavi ai figli, docenti che formano i propri eredi, dinastie di studio legale, di studio medico, di collegio elettorale. Gli stessi cognomi sulle targhe, sulle testate, sui citofoni, sulle schede elettorali.
Sanremo non è un’anomalia pop, è solo la versione rumorosa di questa stessa struttura. La differenza è che lo fa con i cori, le luci, i palloncini, le paillettes: trasforma la disuguaglianza in intrattenimento prime time. Dove altrove la genealogia resta sottintesa, qui è dichiarata, celebrata, premiata dallo share.

La tv dei cognomi: quando il sangue vale più delle canzoni
Da giorni i giornali fanno la conta: «tris di figli d’arte», «Sanremo dei cognomi famosi», «ereditiera all’Ariston». Il sottotesto è sempre lo stesso: il vero spettacolo non è la canzone, è il sangue. Tredici Pietro non entra come rapper bolognese con una discografia propria: entra come figlio di Gianni Morandi. LDA non è solo un ex Amici che ha già fatto un Sanremo: è «il figlio di Gigi D’Alessio». Leo Gassmann arriva dopo aver vinto un Festival e interpretato Califano in una fiction, ma il frame resta «discendente della dinastia Gassmann».
Elettra Lamborghini è l’anomalia: non figlia di cantante, ma erede di un marchio industriale trasformata in personaggio pop. La sua biografia mediatica inizia sempre nello stesso modo: «ereditiera italiana più famosa, figlia di Tonino, nipote di Ferruccio Lamborghini», con in coda il twerking e i reality. Non è un processo ai singoli. Il punto è la regia collettiva: casting, titoli, servizi tv, comunicati, social. La macchina dell’intrattenimento decide che il gancio non è «cosa cantano», ma «da chi discendono». È un Festival della canzone che usa la musica come colonna sonora di un’altra trama: il Paese dei cognomi che contano.
Non è una novità: la genealogia sanremese è già tutta in archivio
Questa ossessione non nasce nel 2026. Ogni volta che Sanremo ha giocato con i «figli di», il racconto si è spostato dal brano alla biografia. Irene Fornaciari è stata per anni presentata prima di tutto come «figlia di Zucchero», anche quando portava in gara pezzi come Il mondo piange con temi tutt’altro che leggeri. Il testo, la voce, la scelta di campo arrivavano sempre dopo.
Negli anni Duemila, Marco Morandi, Giacomo Celentano e altri cognomi ereditati sono passati dal Festival con la stessa etichetta appiccicata sulla fronte. Più che «come sono le canzoni?», la domanda era «sarà all’altezza del padre?». Nel frattempo blog e commenti cominciavano a suggerire, quasi seriamente, che forse bisognerebbe proteggere i figli d’arte dal palcoscenico sanremese, per non trasformare ogni loro passaggio in una gogna.
Il meccanismo è sempre quello: la tv generalista chiama, il Paese risponde. Ci piace indignarci per il «figlio di», ma intanto clicchiamo, commentiamo, memiamo proprio quei cognomi. Sanremo non fa che amplificare un riflesso già nostro.
Dieci anni di Festival dei «figli di»: una retrospettiva a occhio nudo
Se restringiamo lo zoom agli ultimi dieci-quindici anni, il copione è quasi didattico. Irene Fornaciari, ancora: figlia di Zucchero, voce piena, repertorio non banale. Ogni intervista, ogni scheda, ogni lancio tv comincia dal padre, non dalla scaletta. Arriva il momento padre–figlio dei Bocelli, con Andrea e Matteo all’Ariston a cantare Fall on Me: è presentato come passaggio di testimone, gesto affettuoso, rito, ma resta pur sempre un reality dinastico in mondovisione.
Non è solo il palco “ufficiale”. Nel 2022 José Sebastiani, figlio di Amadeus, diventa protagonista indiretto del Festival dalla platea: inquadrato, evocato sul palco da Fiorello e Sabrina Ferilli, trasformato in personaggio narrativo senza nemmeno essere in gara. Nel frattempo si forma un sotto-genere: i «figli di» che arrivano ai Giovani, ai talent, ai sanremi minori, e che si portano sul palco l’attesa, il sospetto, il pregiudizio. Per chi si chiede ogni volta se siano lì «perché se lo meritano» o «perché sono figli di». È la domanda sbagliata: l’ossessione per la colpa individuale serve solo a non parlare delle strutture collettive che rendono più facile una strada rispetto a un’altra.
FantaSanremo: quando il cinismo diventa sport nazionale
In parallelo, l’Italia ha inventato il FantaSanremo. Un gioco nato in un bar delle Marche, diventato in quattro edizioni un fenomeno nazionale: milioni di squadre, regolamenti sempre più complessi, punteggi, leghe, sponsor, una valuta simbolica intitolata a Pippo Baudo. È una trovata: trasforma il Festival in un campionato. Si scommette su tutto: inciampi, saluti alle nonne, abbracci, cambi d’abito, ingressi dalla platea, comparsate a sorpresa. Tutto viene gamificato, reso leggero, convertito in punti.
Dentro questa logica i «figli d’arte» funzionano benissimo: generano meme, reazioni, strappi di narrazione. Sono perfetti per ottenere bonus, per far salire il punteggio, per animare i gruppi WhatsApp. Il problema non è il gioco. Il problema è quello che il gioco rivela: abbiamo imparato a trasformare persino la disuguaglianza simbolica in passatempo da divano. Guardiamo l’ennesima storia di privilegio e la convertiamo in un +10 in classifica, in una gif, in una risata. Smettiamo di chiederci perché quell’artista è lì e non altri: ci basta sapere se ci farà vincere la lega con gli amici.
La difesa standard è già pronta: «È solo musica, è solo tv, è solo Sanremo».
Sanremo non è un talent qualunque su una piattaforma qualunque. È il rito televisivo più potente che abbiamo: prende cinque sere di Rai1, condiziona palinsesti, campagne pubblicitarie, programmazioni radio, classifiche, tour, alcune economie. Decide chi verrà ascoltato per mesi da chi non compra un disco da vent’anni, ma tiene la tv accesa.
Quando questo rito viene costruito – consapevolmente – attorno a genealogie, il messaggio va ben oltre il pop. Dice: in Italia il talento è importante, ma il cognome lo è di più. Dice: è giusto che i figli e i nipoti di chi ha già avuto un palco abbiano una corsia preferenziale per averne un altro. Dice: se nasci nel posto giusto, il microfono ti aspetta; gli altri si arrangino.
Chi ha vent’anni e guarda Sanremo questo lo capisce benissimo, anche se non ha il linguaggio sociologico per dirlo. Capisce che il modello non è «studio e magari ce la faccio», ma «studio, magari ce la faccio e, se ho anche il cognome giusto, meglio ancora».
Che cosa chiederemmo a un Festival pubblico che prende sul serio la parola “merito”
Nessuno può seriamente sostenere che si debbano bandire i figli d’arte. Non avrebbe senso, e molti di loro lavorano il doppio per non farsi sbranare dal pregiudizio. Il problema non sono i singoli, è l’ecosistema. A un Festival di servizio pubblico, che usa – molti – soldi pubblici e occupa spazio pubblico, si potrebbe chiedere altro. Si potrebbe chiedere di spostare il fuoco: meno pedigree, più percorsi; meno alberi genealogici, più progetti.
Significherebbe smettere di titolare sui cognomi e raccontare le scelte: come è stato composto il cast, quante candidature anonime sono arrivate, quanti esordienti senza rete sono stati ascoltati. Significherebbe rendere visibile la commissione, i criteri, i conflitti di interesse. Significherebbe prendersi sul serio quando si ripete, ogni anno, la parola «merito».
Non è rivoluzione, è manutenzione ordinaria di un’idea minima di giustizia culturale.
Perché questo Sanremo fa male (e perché serve guardarlo benissimo)
Sanremo 2026, con Tredici Pietro, LDA, Leo Gassmann ed Elettra Lamborghini nello stesso cast, è una fotografia nitida: l’Italia continua a fidarsi più dei cognomi che delle canzoni. Non è odio per i figli – che spesso lavorano più degli altri proprio per dimostrare di «meritare» il posto che hanno. È sfiducia nei padri, nei board, nei direttori, nei comitati che ogni anno scelgono di raccontarci sempre la stessa storia di famiglia.
Basterebbe poco per cambiare: smettere di titolare sui pedigree, rendere trasparenti i criteri di selezione, prendersi il rischio di far entrare chi non ha un cognome da brand. Una rieducazione all’ascolto e all’intrattenimento culturale. Non succede quasi mai e se sporadicamente succede – l’anno scorso con Lucio Corsi – non gli si conferisce tutta l’attenzione che merita. Della serie: più di lì non puoi andare (Corsi arriva secondo, lodato da tanti, dimenticato oggi – quasi – da tutti?). Ed è questo, più di qualsiasi meme, a raccontare come funziona il potere culturale in Italia.
Continueremo a dire che «è solo musica», ma il vero programma è un altro: un tutorial televisivo, aggiornato a ogni febbraio, su come vivere in un Paese dove, oltre a doversi rapportare con le logiche della globalizzazione, nascere al piano giusto vale ancora più di qualsiasi ritornello.