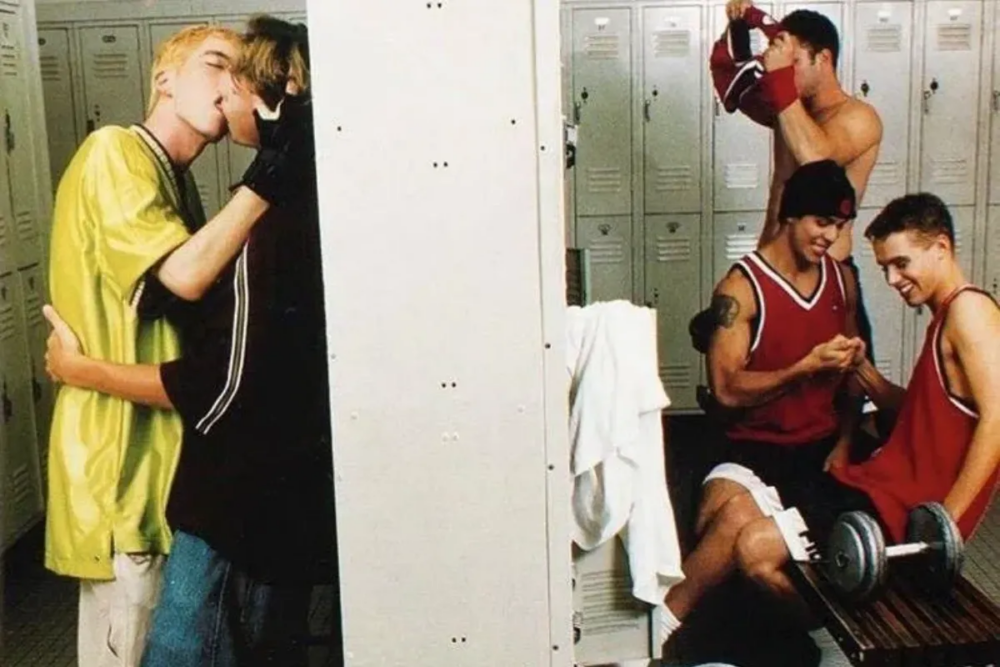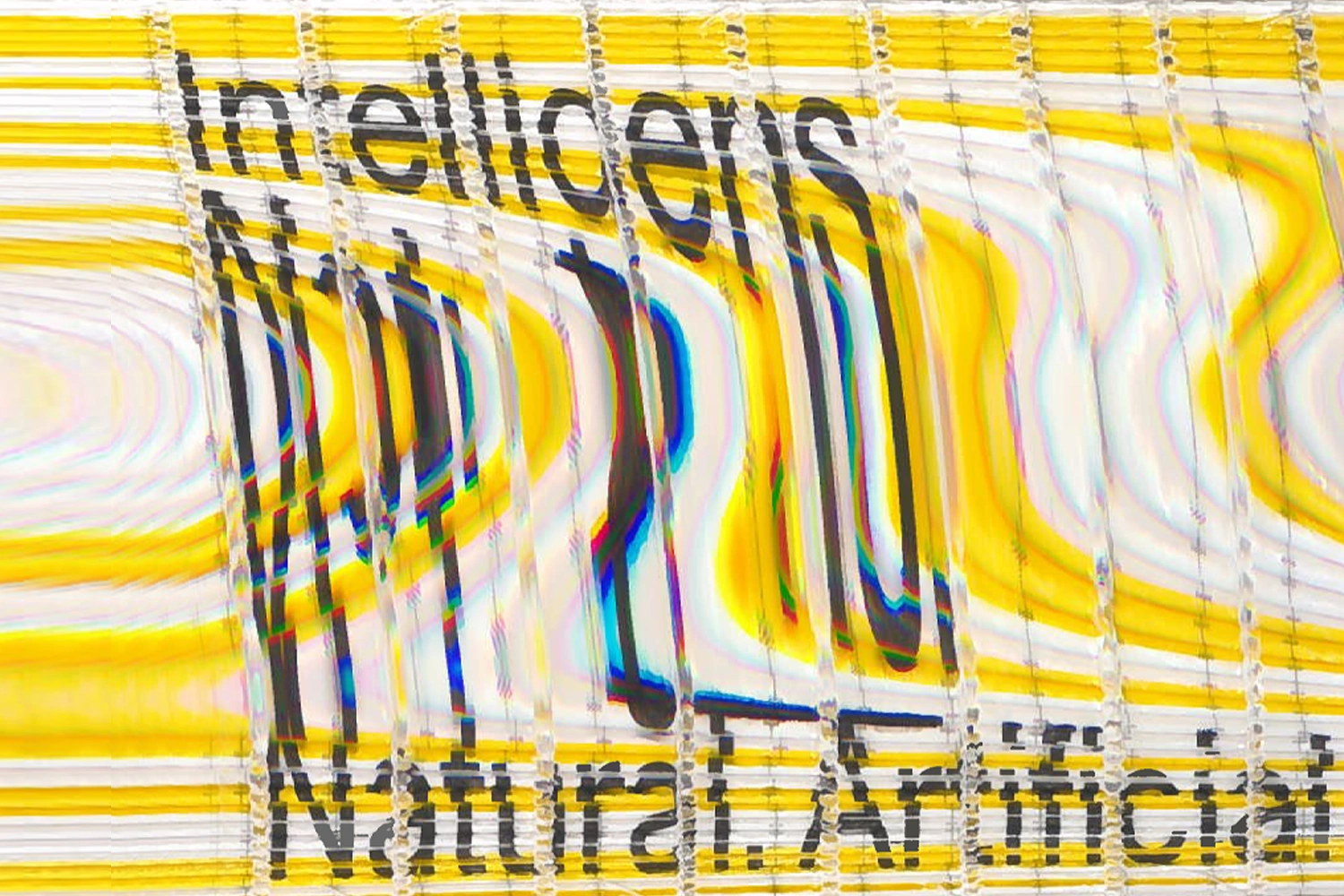
Gli alberi sono i committenti dell’architettura: dentro la Biennale 2025 di Carlo Ratti
«La riforestazione deve iniziare in modo concreto e locale, albero per albero, marciapiede per marciapiede. È una delle poche soluzioni efficaci al surriscaldamento delle città». Intervista a Carlo Ratti su Biennale Architettura 2025
Cosa significa essere culturalmente sostenibili? Trasformare la ricerca in strumento concreto secondo Carlo Ratti
Carlo Ratti: La parola “sostenibilità” ha perso parte della sua forza, logorata da un uso eccessivo e spesso superficiale. Per questo oggi occorre tornare alla precisione. Non basta più dichiararsi “sostenibili” – bisogna chiedersi come si è sostenibili, dove, per chi, e soprattutto in base a quali metriche.
I dati stanno cambiando anche il modo in cui si fa scienza – rendendo più quantitative persino le scienze sociali, che oggi in molti casi vengono definite “computazionali”. Questa rivoluzione dei dati può offrire un contributo importante alla sostenibilità: aiutarci a definirla meglio, a misurarla, e quindi a renderla realmente attuabile. Al MIT Senseable City Lab, dove lavoro da ormai vent’anni, adottiamo un approccio pragmatico e curioso. Analizziamo le città attraverso i dati, con l’obiettivo di fare ricerca e poi trasformala in strumenti concreti.
Un esempio nel nostro piccolo: Treepedia, un progetto nato per misurare la copertura arborea urbana usando tecniche di IA. I risultati, oltre a generare pubblicazioni scientifiche, sono accessibili pubblicamente e consultabili quartiere per quartiere. Questo ha permesso, a Parigi come a Boston, di pianificare nuove piantumazioni non sulla base di intuizioni astratte ma su dati reali – con lo scopo di portare a una distribuzione più equa del verde urbano».
Studiare le città che “sentono”: Carlo Ratti e la 19. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia
FJC Assieme al Prof. Antoine Picon, nel libro Atlas of the Senseable City (Yale University Press, 2023), avanza un’idea altra rispetto a quella di smart city – ormai ricorrente in urbanistica e architettura da più di un decennio. Una città sensibile e capace di sentire. Per la curatela della 19. Mostra Internazionale di Architettura, ha pensato a Venezia come un laboratorio. È possibile applicare il medesimo criterio di mappatura all’ecosistema lagunare veneziano: un atlante delle emozioni o un atlante tecnologizzato?
Carlo Ratti: Il Senseable City Lab al MIT nasce nel 2004 da questa intuizione: che la città non debba essere soltanto smart, ma anche senseable – capace di sentire, percepire, rispondere. In Atlas of the Senseable City sosteniamo che le città non siano contenitori statici ma sistemi dinamici e in continua evoluzione, resi più intelligenti e sensibili dall’onnipresenza dei dati e dalla loro interazione con lo spazio fisico.
Questo approccio può essere applicato a qualsiasi realtà urbana – e Venezia non fa eccezione. Al contrario: è una città che da sempre vive in stretta relazione con le forze che la circondano. Un organismo antico e fragile, capace di adattarsi ai ritmi delle maree, delle stagioni, delle attività umane.
Alla Biennale alcuni progetti seguono questa logica. C’è chi mappa le fioriture algali o la salinità della laguna, chi registra il paesaggio sonoro delle barene, chi raccoglie storie orali che altrimenti andrebbero perdute. Sono tutte forme diverse di ascolto – sensori tecnologici e sensori umani che, insieme, costruiscono una nuova lettura dello spazio. Ma la Biennale va oltre: esplora l’idea di un’intelligenza allargata, che non è solo artificiale ma anche naturale e collettiva.
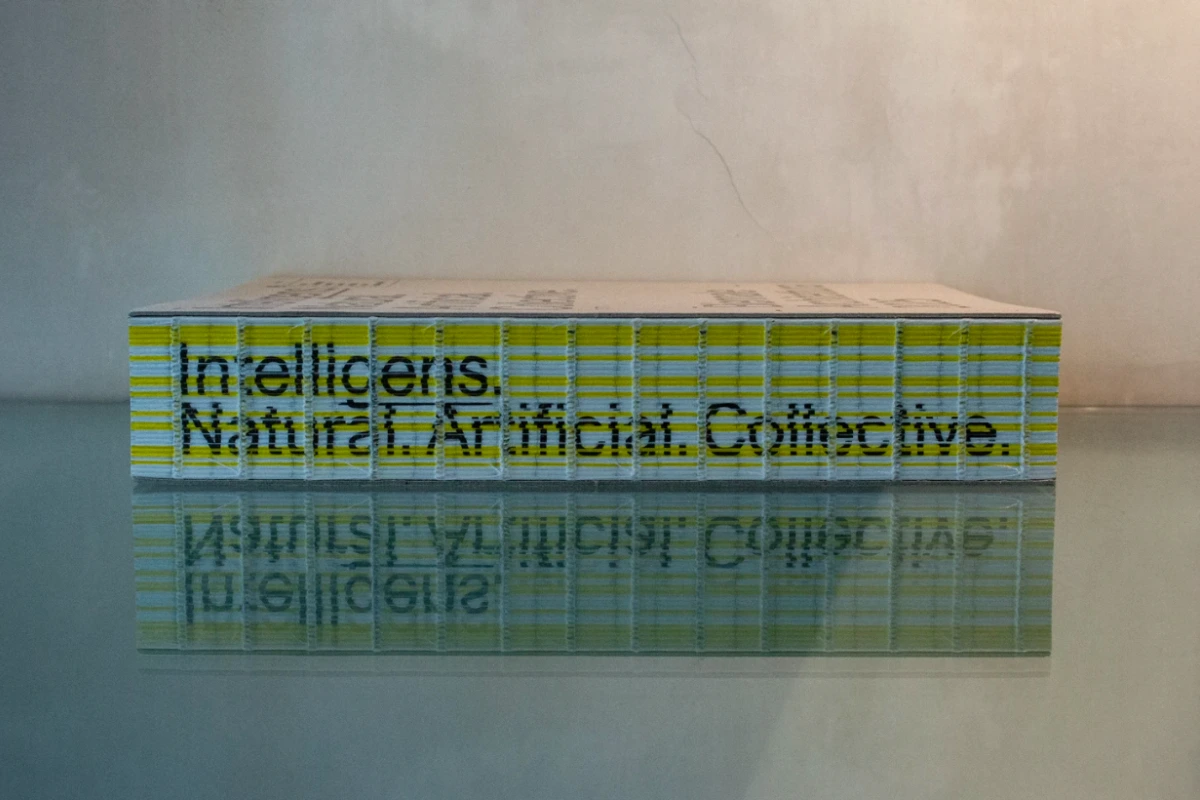
Per una Biennale interdisciplinare: Carlo Ratti sul progetto progetto Terms & Conditions
FJC: Una cifra caratterizzante la Sua curatela della 19. Mostra Internazionale di Architettura è il concetto di interdisciplinarità. Come si è sviluppato, ad esempio, il progetto che nasce dalla ricerca di Sonia Seneviratne e David Bresch, tra i principali scienziati del clima, in collaborazione con la Fondazione Città dell’arte Onlus dell’artista Michelangelo Pistoletto, con gli ingegneri climatici tedeschi Transsolar e con lo storico dell’ambiente Daniel A. Barber?
Carlo Ratti: Questa Biennale nasce da un’idea semplice ma radicale: che per affrontare le sfide del nostro tempo – e in particolare quella dell’adattamento climatico – dobbiamo attivare tutte le intelligenze disponibili. Non solo quelle degli architetti ma anche degli ingegneri, degli scienziati del clima, degli artisti, dei filosofi, dei designer, dei contadini, dei programmatori. La città – e il mondo – sono sistemi complessi, e richiedono risposte altrettanto complesse, costruite attraverso la contaminazione tra saperi.
Il progetto Terms & Conditions ne è un esempio emblematico. Nato dall’incontro tra la ricerca scientifica di Sonia Seneviratne e David Bresch, l’approccio artistico della Fondazione Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto, l’ingegneria ambientale di Transsolar e lo sguardo storico di Daniel A. Barber, Terms & Conditions occupa l’ingresso delle Corderie. Qui il pavimento è allagato e l’aria surriscaldata: una rappresentazione esperienziale e immersiva del clima futuro di Venezia.
Il progetto non si esaurisce nello spazio espositivo. Prosegue nella ricerca, nella produzione di conoscenza; ha generato anche un contributo scientifico importante – un articolo scritto dal gruppo di Seneviratne e Bresch, che analizza gli scenari climatici della laguna in prospettiva futura. Un’eredità, anche questa, per Venezia dopo la Biennale: fatta non solo di memoria ma di anticipazione.
Generazioni di architetti a confronto: la Biennale multigenerazionale di Carlo Ratti
FJC: È l’architettura in sé a faticare nell’abbracciare i valori promossi dalla Mostra o è una generazione di architetti che ne è avulsa?
Carlo Ratti: Non credo sia una questione generazionale. Il lavoro su questi temi, quest’anno, mette in dialogo oltre 350 partecipanti in team multigenerazionali – una varietà anagrafica che considero una delle sue forze (a proposito: più di 375 partecipanti lavorano in gruppi transnazionali e oltre 250 in team guidati da donne, in un ambiente tradizionalmente maschile).
Il nodo non è tanto negli architetti, quanto nel sistema dentro cui si trovano a operare. L’architettura si muove con inerzia, all’interno di un contesto regolatorio, economico e produttivo che raramente premia il rischio e che tende a favorire la ripetizione, non l’innovazione.
Momenti come la Biennale possono avere il ruolo di catalizzatori. Lo hanno fatto in passato, e credo che anche questa edizione, se saremo fortunati, potrà offrire una spinta. Vedo molta voglia di ripensare la disciplina: lo dimostra, per esempio, il Manifesto sull’adattamento che abbiamo firmato a Madrid con il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez: in poche ore ha raccolto l’adesione di oltre 250 partecipanti alla Biennale. Un gesto simbolico, certo – ma anche una dichiarazione di intenti. C’è voglia di rimettere l’architettura al centro.
Carlo Ratti su architettura e politica: suggerire direzioni, aprire scenari, proporre alternative
FJC: Nel testo L’architettura del fallimento (Postmedia, 2012), Douglas Murphy sostiene che solo i governi o coloro che partecipano attivamente al capitalismo possono permettersi di fare architettura, motivo per cui quest’ultima non può essere apolitica. Che dimensione occupa il messaggio politico nel Suo lavoro?
Carlo Ratti: L’architettura è un atto politico. Ogni intervento nello spazio costruito incide sulla vita collettiva – influenza i comportamenti, le relazioni, l’ambiente. Occorre distinguere tra due modi diversi di intendere il rapporto tra architettura e politica. Uno sano e uno malsano.
Partiamo da quest’ultimo. Pensiamo al legame tra Albert Speer e il regime nazista, o, in un contesto molto diverso, al ruolo che Vittorio Gregotti ha avuto nell’Italia socialista della fine del Novecento. In tutti questi casi, l’architettura diventa uno strumento per consolidare un messaggio politico preesistente. Un amplificatore del potere.
Dobbiamo stare ben alla larga da questa logica. L’architettura dovrebbe al contrario essere l’input di un processo politico. Può suggerire direzioni, aprire scenari, sollecitare, proporre alternative. Per poi lasciare spazio alle scelte dei cittadini. Per questo sono sempre stato attratto dai sistemi progettuali aperti, capaci di evolvere in funzione del feedback che ricevono.
Per quanto riguarda la Biennale 2025, il messaggio politico è chiaro: abbiamo bisogno di molteplici intelligenze per affrontare la sfide del nostro tempo: l’adattamento a un pianeta che cambia.
Carlo Ratti e il Manifesto di Economia Circolare per la 19. Mostra Internazionale di Architettura contro i rifiuti generati dagli eventi temporanei
FJC: La 19. Mostra Internazionale di Architettura presenta anche un Manifesto di Economia Circolare da Lei scritto con la guida di Arup e il contributo di Ellen MacArthur Foundation. Sette punti che invitano architetti, designer e innovatori a ripensare in maniera drastica l’approccio all’ambiente.
Carlo Ratti: Expo, Olimpiadi, Biennali, ecc. sono, per loro natura, occasioni uniche per sperimentare. Offrono un terreno libero, non vincolato dalla permanenza, dove testare nuove idee in architettura. Nella loro effimerità, spesso nascono innovazioni radicali. Basti pensare al Crystal Palace di Paxton per l’Esposizione Universale del 1851 o alla Torre Eiffel del 1889 – entrambe pensate come strutture temporanee, entrambe capaci di influenzare la storia dell’architettura moderna.
È questo lo spirito che a CRA – Carlo Ratti Associati – ci ha sempre attratto verso questo tipo di eventi. Negli anni abbiamo progettato per molte Expo: dal Digital Water Pavilion di Saragozza 2008 – incluso da TIME Magazine tra le migliori invenzioni dell’anno – fino ai padiglioni tematici di Milano 2015, e al Padiglione Italia di Dubai 2020. Oggi siamo coinvolti nell’Expo di Osaka, con il padiglione francese insieme allo studio Coldefy, e con le torce olimpiche di Milano-Cortina 2026, all’interno del padiglione italiano.
Ma c’è un problema che ci accompagna sempre: l’enorme quantità di rifiuti generata dagli eventi temporanei. Interi edifici finiscono in discarica nell’arco di poche settimane. È qualcosa che mi ha sempre dato moltissimo fastidio. La domanda quindi è: come progettare un evento temporaneo in cui nulla diventa rifiuto quando si spengono le luci?
Da qui l’idea del Manifesto per la circolarità, sviluppato con Arup e con la Ellen MacArthur Foundation. Un invito aperto a ripensare radicalmente il modo in cui costruiamo, scegliamo i materiali, progettiamo il ciclo di vita di ogni intervento.

La scelta dei materiali secondo Carlo Ratti: privilegiare le materie prime naturali
FJC: Il concetto di scelta dei materiali torna più volte nel Manifesto. Che materiale predilige nei Suoi progetti?
Carlo Ratti: Mi interessa ciò che segue la logica della natura: ciò viene da una vita precedente e in seguito può rigenerarsi in una seconda vita. Negli ultimi anni abbiamo sperimentato con fondi di caffè per un bancone Lavazza, o con scarti di pomodoro per la Mensa Mutti, appena completata. Qualche anno fa, all’Orto Botanico di Milano, abbiamo costruito il cosiddetto Circular Garden: la più grande struttura mai realizzata in micelio, la radice del fungo. Un’architettura cresciuta dal terreno, come una pianta, in poche settimane e poi riassorbita dal suolo, attraverso il compostaggio, senza lasciare tracce.
Anche alla Biennale abbiamo cercato di seguire questo principio. Il cartongesso è stato ridotto al minimo. La maggior parte delle installazioni è realizzata con pannelli forniti da Saviola Group e prodotti dal riciclo di vecchi mobili. Dopo l’esposizione, a novembre, questi pannelli verranno nuovamente macinati e trasformati in nuovi pannelli. La Biennale continuerà a vivere in cucine e armadi in giro per il mondo.
Carlo Ratti sulla rigenerazione urbana attraverso la forestazione. Mettere al centro gli alberi
FJC: Considerando The Greenary un caso non isolato, che ruolo hanno gli alberi quando progetta un edificio? Quanto è necessaria una riforestazione delle aree urbane attraverso progetti architettonici?
Carlo Ratti: Ci interessa la linea di confine tra naturale e artificiale. A volte questa relazione prende la forma di un albero – come nel caso di The Greenary, dove un ficus alto dieci metri è stato collocato al centro della casa. Ma non si è trattato di “inserire” l’albero: è la casa che si è sviluppata attorno a lui. Gli spazi, la luce, la struttura stessa sono stati progettati in funzione delle sue esigenze. In questo senso, l’albero è diventato il vero committente.
In altri casi, ci confrontiamo con sistemi naturali più complessi. Penso al dehors Trussardi in Piazza della Scala a Milano, realizzato insieme al botanico francese Patrick Blanc: un giardino sospeso a cinque metri d’altezza, appoggiato su una struttura di vetro, nel cuore della città. Oppure alla recente ristrutturazione del Palazzo Mondadori di Oscar Niemeyer, dove abbiamo integrato elementi verdi non come ornamento ma come vere e proprie infrastrutture: dispositivi per il raffrescamento naturale, la purificazione dell’aria, la gestione della stagionalità. Anche nel nostro studio di Torino, il giardino è diventato uno spazio di lavoro a tutti gli effetti per molti mesi dell’anno. Non un margine, una parte attiva dell’ufficio.
La riforestazione urbana, spesso evocata a livello globale, deve cominciare in modo concreto e locale: albero per albero, marciapiede per marciapiede. È una delle poche soluzioni efficaci che abbiamo oggi per contrastare il surriscaldamento delle città e il fenomeno delle isole di calore. Ed è anche un modo per riconnetterci, ogni giorno, con la natura che ci sostiene.
Materie prime naturali alla 19. Biennale d’Architettura: lo sterco di elefante dai Santuari in Thailandia alla costruzione di mattoni
FJC: Progetti nella Mostra come Elephant Chapel di Boonserm Premthada – incentrato sull’utilizzo sterco di elefante per creare mattoni – sono solo sperimentali nella loro bontà o hanno possibilità di inserirsi concretamente in un più ampio sistema di costruzione?
Carlo Ratti: Boonserm Premthada lavora a stretto contatto con i santuari per elefanti in Thailandia. Da questa relazione è nata un’intuizione semplice e potente: gli escrementi degli elefanti, ricchi di fibre, possono essere mescolati con l’argilla per produrre mattoni traspiranti, leggeri e resistenti.
Sarà possibile applicare questa soluzione su larga scala? Dipenderà da molti fattori – tecnici, normativi, economici. È importante avere il coraggio di provarci. È così che funziona anche in natura: per prova ed errore.
Credo questo sia anche il senso della Biennale. Non è un archivio di soluzioni già pronte, ma un laboratorio di possibilità. Alcune idee troveranno una via per entrare nei processi reali, altre resteranno provocazioni. Le provocazioni hanno un ruolo importante, perché spostano l’orizzonte di ciò che immaginiamo possibile.
Carlo Ratti e l’inevitabilità dello spazio pubblico: l’architettura deve costruire relazioni
FJC: Lei lavora molto negli Stati Uniti d’America. Come si relaziona al panorama socio-culturale attuale di chi pensa allo spazio come un rifugio “privatizzabile”?
Carlo Ratti: Ritrovarsi fisicamente, in uno stesso luogo, è un antidoto alla polarizzazione che spesso viviamo negli spazi digitali. Lo spazio pubblico ha una qualità unica: l’inevitabilità. Si tratta della sua capacità di mettere in relazione persone diverse con idee diverse, come nell’agora ateniese. Al contrario, le piattaforme online tendono a isolarci in camere a eco, accentuando le divisioni ideologiche.
Questo vale per gli spazi aperti, ma anche per quelli al chiuso. Al MEET Cultural Center di Milano, ad esempio, abbiamo cercato di usare l’architettura per favorire connessioni tra i visitatori. Da qui è nato il concetto di usare la scala centrale come una “piazza verticale” — un elemento di circolazione verticale che stimoli incontri e scambi. È un’idea che abbiamo esplorato in diversi progetti, proprio perché crediamo che l’architettura debba costruire soprattutto una cosa: relazioni.
Carlo Ratti: Imparare a leggere le intelligenze dell’universo per elevarsi al Bello. Non solo utilità
FJC Ha organizzato la Sua curatela della Biennale su una tripartizione del concetto di intelligenza. Il processo triadico è da sempre un sistema caro alla speculazione filosofica. In questa accezione, queste intelligenze – naturale, artificiale, collettiva – in campo architettonico saranno capaci di creare ancora guardano sì alle problematiche attuali ma anche al concetto di Bello come possibilità di elevazione dello spirito umano? Insomma: c’è ancora spazio per la dimensione dell’aspirazione o ne resta solo per quella del bisogno?
Carlo Ratti: Credo, come Galileo Galilei, che la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l’universo). La possibilità di elevazione non può che partire da esso e dalle molteplici intelligenze – naturale, artificiale, collettiva – che contiene».
Carlo Ratti, un profilo biografico
Architetto e ingegnere, il Professor Carlo Ratti insegna al Massachusetts Institute of Technology (MIT) e al Politecnico di Milano. È direttore del Senseable City Lab e socio fondatore dello studio di architettura e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati (Torino, New York City, Londra).
Laureato presso il Politecnico di Torino e l’École Nationale des Ponts et Chaussées a Parigi, ha conseguito un Master of Philosophy e un PhD in Architettura all’Università di Cambridge in Inghilterra, completando la sua tesi di dottorato come Fullbright Scholar presso il MIT.
Uno dei dieci studiosi più citati a livello internazionale nel campo della pianificazione urbana, è co-autore di oltre 750 pubblicazioni scientifiche, tra cui il recente Atlas of the Senseable City (scritto con Antoine Picon, Yale University Press). Già relatore a TED, pubblica in modo regolare articoli di opinione su The New York Times, Financial Times, The Guardian, Project Syndicate, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera, La Repubblica, El Pais. Ricopre il ruolo di co-presidente del Global Future Council su Città e Urbanizzazione del World Economic Forum.
È stato direttore didattico allo Strelka Institute for Media, Architecture and Design di Mosca, curatore del BMW Guggenheim Pavilion di Berlino e curatore del padiglione Future Food District durante Expo Milano 2015. È stato capo curatore dell’ottava Biennale di Urbanistica/Architettura di Shenzhen (UABB) nel 2019, co-curatore della seconda Biennale di Design di Porto nel 2021 e Mediatore Creativo responsabile di Visione Urbana della Biennale Nomade Europea Manifesta 14 a Pristina nel 2022.
Il suo lavoro è stato esposto in sedi quali il MoMA The Museum of Modern Art di New York, La Biennale di Venezia (Mostre Internazionali di Architettura), il Design Museum di Barcellona, il Science Museum di Londra, il MAXXI di Roma.
È curatore di Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva., 19. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia, che aprirà al pubblico il 10 maggio 2025.